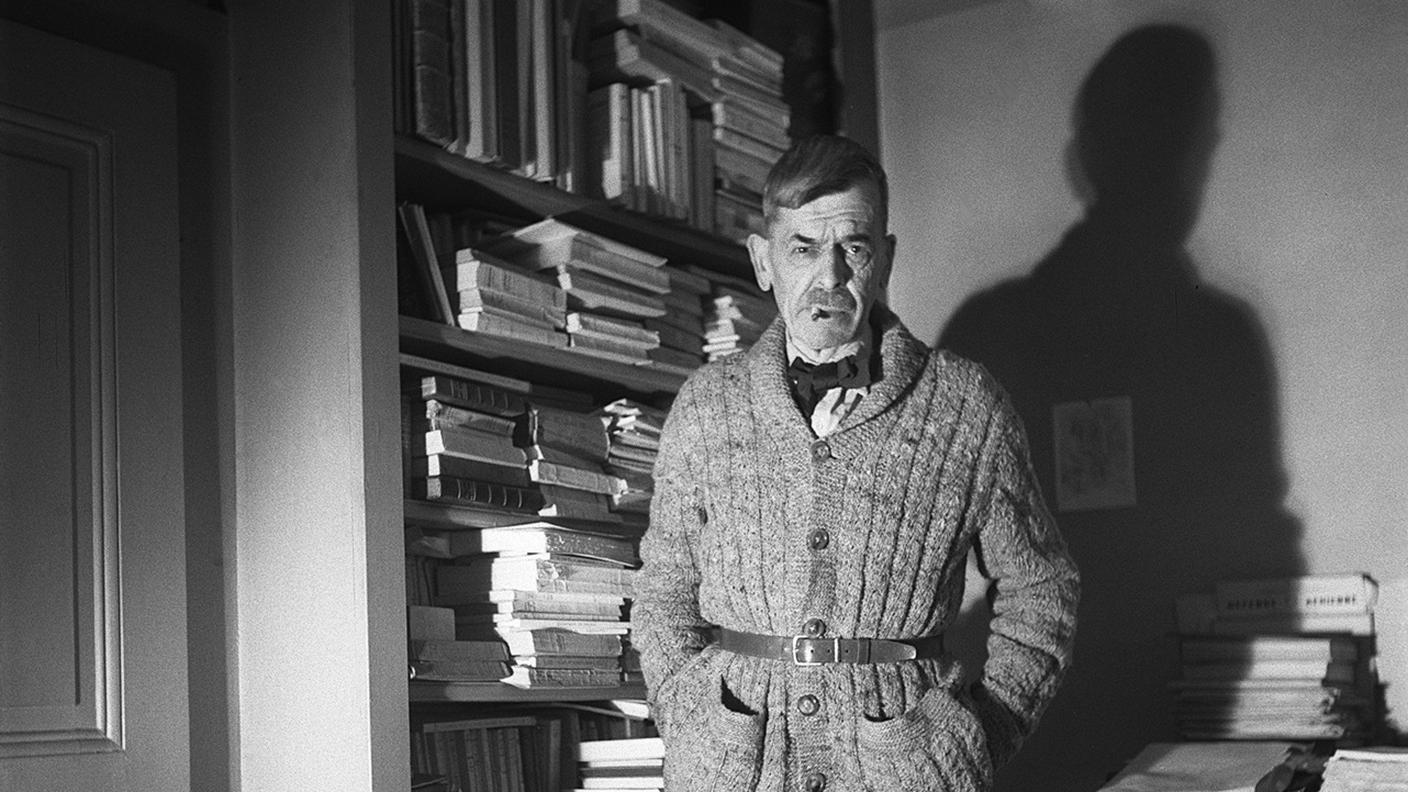Il tutto costituito dall’unione di due parti, ha scritto Robert Musil in un passo de “L’uomo senza qualità”, può essere definito non già per addizione ma piuttosto per sottrazione, perché i tratti comuni si profilano solo in virtù delle differenze. Un simile approccio, se così lo si può definire, è molto utile anche per comprendere le grandi coppie della letteratura: Goethe e Schiller, ad esempio, oppure Ibsen e Strindberg, i fratelli Thomas e Heinrich Mann. E in ambito elvetico, va da sé, Frisch e Dürrenmatt, per i quali il grande critico Hans Mayer aveva perfino proposto la denominazione “Frischunddürrenmatt”, un simpatico mostro lessicale da scriversi tutto unito e da pronunciarsi senza pause per la respirazione.
Ma la coppia letteraria che più di ogni altra si presta ad essere compresa a partire da un simile approccio è con ogni evidenza quella rappresentata dai due padri del romanticismo inglese, Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth, per i quali si potrebbe adottare la denominazione consigliata da Mayer per Frisch e Dürrematt. Più che “Coleridge and Wordsworth”, come ce li restituiscono le storie letterarie, si potrebbe insomma scrivere “ColeridgeandWordsworth”. Il mostro lessicale, nel loro caso, trova inoltre una legittimazione in una circostanza di fondamentale valore: Coleridge e Wordsworth, infatti, hanno firmato in coppia non già “un” libro, ma “il” libro che ha segnato il punto di snodo tra il Settecento e l’Ottocento, tra la fede illuministica nella ragione e nel progresso e le dubbiose, screziate e ironiche effusioni del romanticismo, aprendo la strada a una sensibilità che tutto sommato, pur se con qualche inevitabile ammaccatura, è giunta fino a noi e continua ad esercitare una notevole fascinazione. La data, non priva di forti connotazioni simboliche, è il 1798 (“anno mirabile”, come lo ha definito Angelo Righetti, ottimo traduttore per Mursia delle poesie di Wordsworth) e il titolo del libro è “Lyrical Ballads”, “Ballate liriche”, le cui poesie -in larga parte di Wordsworth, ma tra le poche composizioni di Coleridge c’è la straordinaria “Ballata del vecchio marinaio”- rientrano con pieno diritto nel novero dei capolavori della lirica di tutti i tempi.
“ColeridgeandWordsworth”, dunque. Quasi coetanei (Wordsworth era nato il 7 aprile 1770, ed è morto nel 1850; Coleridge, di due anni più giovane, è morto nel 1834), uniti negli anni decisivi della giovinezza da una profonda amicizia, da un comune sentire poetico ma anche dalla scarsità di mezzi (la collaborazione alle “Ballate liriche” nacque molto prosaicamente dalla necessità di guadagnare denaro), i due padri del romanticismo inglese hanno poi percorso strade molto diverse, anche sul piano dell’approccio al concreto lavoro poetico. Il dubitoso Coleridge temeva la “nobile solitudine” -che per Nietzsche costituiva il presupposto di ogni creazione artistica- ed era mosso da un desiderio di assolutezza, di unità e totalità di significati che la realtà e la poesia non potevano pienamente soddisfare. La sua vana ricerca del Sublime si è risolta in una propensione al frammento, all’opera incompiuta, che per molto tempo è stata considerata un limite e oggi, invece, ci appare giustamente modernissima.
Wordsworth, da parte sua, definisce e circoscrive il proprio universo poetico in relazione a Coleridge, ma opera una sostanziale differenziazione rispetto all’amico. Preso atto che il Sublime è inattingibile, Wordsworth articola la propria visione del mondo a partire da un “io lirico” che fonda la propria attività creativa sull’imperativo etico del “Duty”, il “dovere”, si pone in uno stato di totale apertura nei confronti dei dati del reale e quindi è maggiormente disponibile a recepire e poi a rimodellare la sensazione del Bello. Se Coleridge è attuale nella misura in cui afferma l’esigenza di una totalità proprio constatandone l’assenza, Wordsworth parla alla nostra sensibilità in virtù di un procedimento esattamente opposto: la totalità esiste, è data, ma bisogna cercarla tra le pieghe minime della realtà, nei “momenti liminari” (come ha scritto lo scandinavista Fulvio Ferrari a proposito di un poeta molto “wordsworthiano” come Tomas Tranströmer, Premio Nobel nel 2011) e con una scrittura poetica che si potrebbe definire “in esposizione”, perché nasce dalla sensazione dell’istante irripetibile ma giunge a piena forma soltanto dopo un lungo lavoro di lima.
L’esempio più noto di questa scrittura poetica è fornito da quella lirica semplicemente prodigiosa che è conosciuta col titolo di “Tintern Abbey”, dove la rievocazione di un paesaggio visto e vissuto nel passato conferisce significato e sostanza al presente, con «pensieri di più profonda solitudine» e la percezione di un Bello in virtù del quale «il peso del mistero, / il gravoso tedioso carico / di tutto questo mondo incomprensibile / si fa leggero», essendo «quasi sospeso l’alito della compagine corporale». I “Daffodils”, i “narcisi”, in un'altra incomparabile lirica (“Erravo solo come una nube…”), danzano nella brezza e «balenano all’occhio interiore / che fa la solitudine beata, / e allora mi si ricolma il cuore / di piacere, e danza con loro». L’intera produzione di Wordsworth si configura come una percezione, filtrata e rimodellata dall’“io lirico”, del Bello quale cifra più autentica del nostro essere al mondo, in virtù di un approccio alla realtà fatto di affezioni e incantamenti, e in nome di una pienezza di vita mai disgiunta dal senso del tempo e della morte, dalla tristezza immanente a ogni cosa umana. E’ il “valore fondante” della poesia, come lo ha definito Martin Heidegger parlando di un altro grandissimo poeta coetaneo di Wordsworth, Friedrich Hölderlin.
«Portai la musica in cuore / ben oltre l’eco del suo canto», dicono i versi conclusivi di un’altra splendida poesia, “La mietitrice solitaria”. Leggiamolo, rileggiamolo e amiamolo questo Wordsworth così lontano ma anche così vicino. Il suo luogo dell’anima -il “Lake District”, nella regione del Lancashire- può essere ovunque. E il suo Bello è anche il nostro. Deve esserlo. Ne abbiamo più che mai bisogno, per rischiarare almeno in parte le fitte tenebre che ci circondano e opprimono.
Marianne Faithfull rilegge i poeti romantici inglesi, con le musiche di Warren Ellis e la complicità di Nick Cave e Brian Eno.
Diderot 06.05.2021, 18:15
Contenuto audio