Zygmunt Bauman (19 novembre 1925 – 9 gennaio 2017) è stato uno dei pensatori più incisivi del Novecento. La sua celebre metafora della “società liquida” ha segnato il linguaggio comune, diventando chiave interpretativa della postmodernità: un mondo individualizzato, privatizzato, incerto, flessibile e vulnerabile, dove la libertà senza precedenti si accompagna a un desiderio insaziabile e a una gioia ambigua. La sua biografia si intreccia con le fratture del secolo breve: di origini ebraiche, fuggì dalla Polonia durante l’invasione nazista, tornò dopo la guerra e si laureò in sociologia a Varsavia. Conoscitore di Gramsci e Simmel, inizialmente marxista ortodosso, fu travolto dalle epurazioni del 1968 e costretto a lasciare la cattedra e il Paese. Insegnò a Tel Aviv e poi a Leeds, in Inghilterra, che divenne la sua seconda patria, o meglio il suo secondo esilio. Ebreo errante, come nel destino di un intero popolo, Bauman rifletté sul concetto di straniero («Sono nato straniero e morirò straniero. E sono innamorato di questa condizione») e sull’urgenza del dialogo interetnico, tanto più significativa in un’epoca segnata da populismi che innalzano muri e barriere.
Zygmunt Bauman: l'autunno delle certezze
RSI Cultura 10.01.2017, 09:35
Con lo sguardo clinico del patologo, Bauman mise a nudo i mali della società contemporanea: instabilità, frammentazione, apparenza che prevale sulla sostanza. Il tempo si riduce a episodi, la salute a “fitness”, la libertà a “zapping”. La deregulation economica trasforma i cittadini in consumatori, mentre la cultura diventa un grande magazzino di offerte e tentazioni, capace di creare e soddisfare desideri in un ciclo infinito di dipendenza. La sua critica alla tecno-cultura è radicale: l’informazione e la tecnica riducono l’umano a macchina, la ragione calcolante diventa l’unico criterio di interpretazione del mondo, basato su performance ed efficienza. Le relazioni autentiche si dissolvono nell’interattività tecnologica, lasciando spazio a solipsismo e solitudine esistenziale. La tecnologia, che crediamo di dominare, ci domina.
Bauman attraversò le tragedie del Novecento: l’utopia marxista, l’oltraggio nazista, la Shoah, l’epurazione comunista, l’esperienza israeliana e il rifiuto del sionismo. Da queste esperienze nacque un pensiero critico che rifugge ideologie e omologazioni. La sua lucidità consegna un’analisi del presente implacabile: «Durante la guerra la gente era comunque più ottimista, vedeva la luce alla fine del tunnel. Le insicurezze erano temporanee, perché se la guerra fosse finita, tutto sarebbe andato a posto. Ora invece ci rendiamo conto che l’insicurezza è per sempre».
La nozione di società liquida si colloca nel solco delle grandi teorie della modernità e della postmodernità. Se Durkheim aveva individuato nella solidarietà organica la forma di coesione delle società complesse, Bauman mostra come tale coesione si dissolva in una fluidità che rende instabili i legami sociali. In questo senso, la sua analisi dialoga con quella di Ulrich Beck sulla “società del rischio” e con Anthony Giddens sulla “modernità riflessiva”: tutti convergono nel sottolineare l’incertezza come tratto distintivo del nostro tempo. La liquidità non è solo precarietà economica, ma anche precarietà identitaria, relazionale e culturale.
Intervista a cura di Roberto Antonini - 03.09.2014
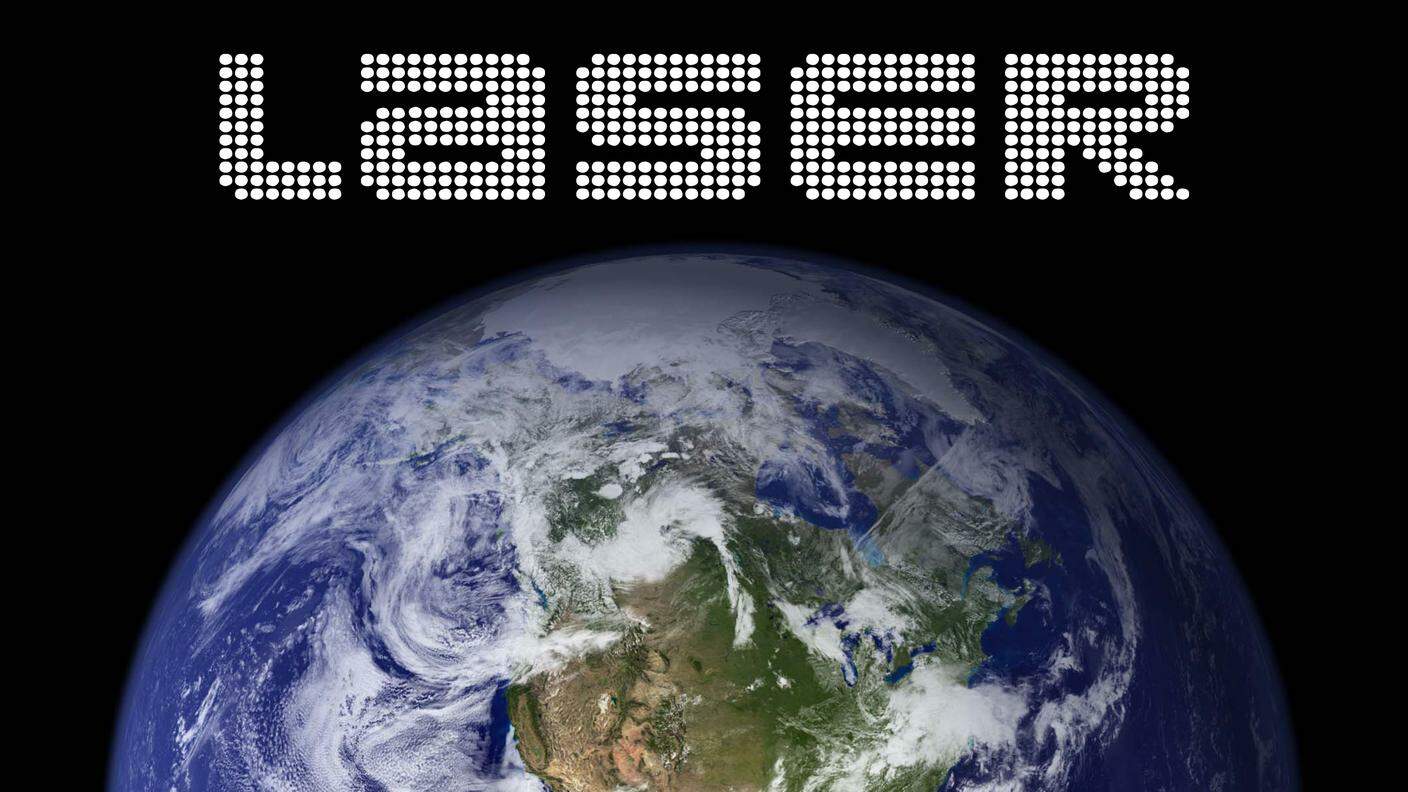
Contenuto audio
Zygmunt Bauman (1./2)
Laser 10.01.2017, 09:00
Zygmunt Bauman (2./2)
Laser 10.01.2017, 22:35
Nel 2025, a cent’anni dalla nascita, Bauman appare più attuale che mai. Le sue intuizioni sulla fragilità dei legami, sulla mercificazione della cultura e sulla colonizzazione tecnologica risuonano in un mondo segnato da crisi ambientali, migrazioni di massa e populismi digitali. Il centenario diventa occasione per rileggere la sua opera come bussola critica: non per trovare soluzioni semplici, ma per comprendere la complessità del presente e ricostruire spazi di solidarietà e responsabilità collettiva. La sua eredità non è un sistema chiuso, ma un invito a pensare senza certezze, a vivere nell’insicurezza come condizione permanente e a cercare nuove forme di comunità in un mondo liquido. In questo senso, Bauman rimane un interlocutore imprescindibile, capace di illuminare la nostra epoca e di ricordarci che la sociologia non è mai neutra, ma sempre chiamata a interrogare il presente e a stimolare la coscienza critica.


