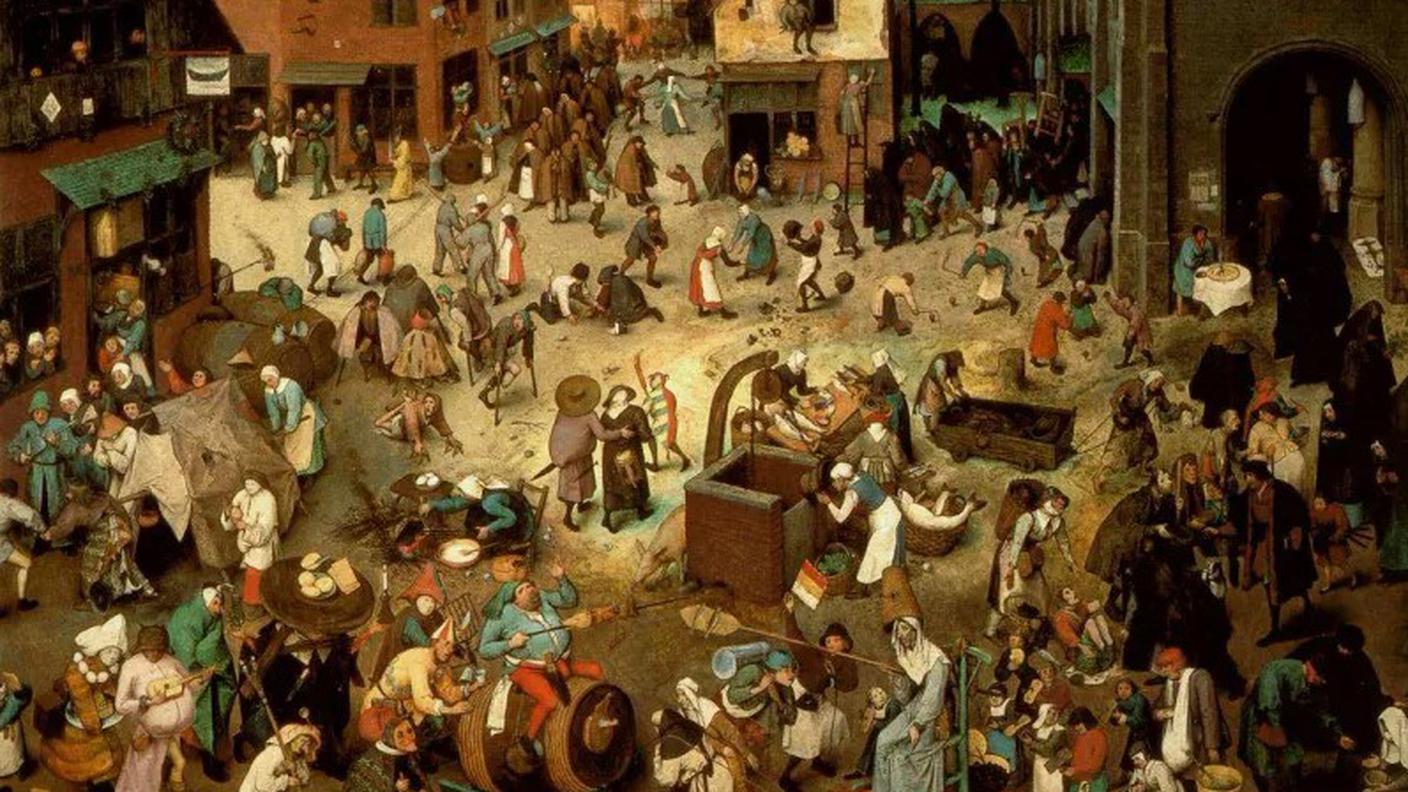Il riscaldamento globale non è più una previsione: è una realtà che si misura, si vive, si soffre. E in estate, nelle città, si concentra in un fenomeno tanto invisibile quanto impattante: le isole di calore. Per affrontarle, non bastano le parole. Serve camminare. Serve guardare. Serve capire. È con questo spirito che SUPSI e la Città di Lugano hanno organizzato una passeggiata divulgativa nell’ambito del Long Lake Festival, trasformando il centro urbano in un laboratorio a cielo aperto.
A guidare questa esplorazione è Annalisa Rollandi, ricercatrice in sviluppo territoriale alla SUPSI, che spiega con chiarezza: «Le isole di calore sono aree urbane con temperature più elevate rispetto alle zone rurali circostanti. Le abbiamo mappate a livello cantonale, e i centri urbani e le zone industriali risultano le più colpite». Il cemento, l’asfalto, la scarsità di vegetazione: tutto contribuisce a trattenere il calore, rendendo le città vere e proprie trappole termiche.

Addio Lugano fresca
Alphaville 17.07.2025, 11:45
Contenuto audio
Ma non si tratta solo di diagnosi. La ricerca, ci ricorda Rollandi, è già in azione. «La collaborazione tra ricerca scientifica e enti locali è fondamentale. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità per raccogliere dati, sviluppare progetti e coinvolgere la cittadinanza». E i cittadini, oggi, sono più consapevoli. Chiedono interventi, soluzioni, cambiamenti. Non si accontentano più di panchine roventi e piazze desertificate.
Tra le soluzioni più visibili, c’è l’impianto di nebulizzazione Swiss Fog, installato in diverse aree di Lugano. Un’innovazione locale che rinfresca l’aria e restituisce vivibilità agli spazi pubblici. «La scelta delle aree di intervento si basa su considerazioni scientifiche e politiche», spiega Rollandi. «Cerchiamo di bilanciare l’efficacia con le esigenze della comunità». È un equilibrio delicato, ma necessario.
Non mancano però le contraddizioni. Alcuni nuovi sviluppi urbani, come il Campus Est di SUPSI e USI, sembrano poco adatti a resistere al caldo: tanto cemento, poca ombra. «Non esiste una soluzione unica», ammette la ricercatrice. «Serve un insieme di interventi calibrati sul contesto: più verde urbano, materiali riflettenti, pianificazione sostenibile».
E qui entra in gioco la lungimiranza. «È fondamentale pianificare gli interventi in anticipo e accompagnarli con un monitoraggio microclimatico continuo». Solo così si possono raccogliere dati utili per guidare le scelte future. Le soluzioni temporanee, come le “aureole 2.0”, sono interessanti, ma non bastano. Serve pensare in grande, e a lungo termine.
Alla fine, tutto ruota attorno a una parola chiave: benessere. «L’obiettivo è migliorare il benessere delle persone negli spazi pubblici, renderli utilizzabili anche durante le ondate di calore». Per farlo, serve un approccio multidisciplinare, che unisca scienza, urbanistica e partecipazione. Perché il clima cambia, ma anche le città possono cambiare — se lo vogliamo davvero.