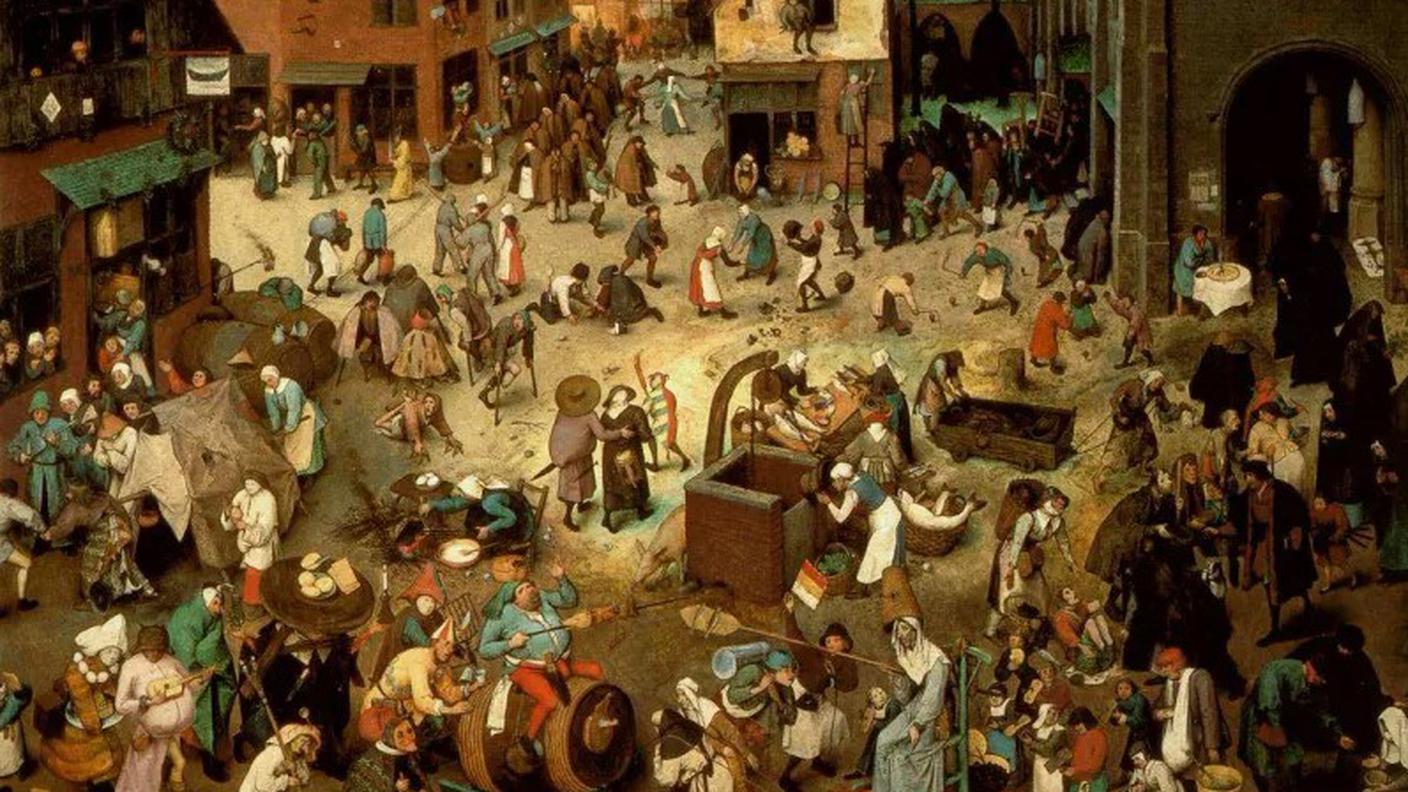Sono piccoli, blu, vivono in funghi e parlano una lingua tutta loro. Ma dietro l’apparenza innocente del fumetto creato da Peyo (diventato poi serie tv, cortometraggio, lungometraggio, giocattolo e pupazzetto), i Puffi nascondono una struttura sociale rigorosamente codificata che ha fatto impazzire politologi, sociologi e giornalisti per oltre sessant’anni. Non è solo nostalgia infantile: è ideologia mascherata e seduttiva.
L’ultima a rilanciare il dibattito è stata Licia Troisi, che su La Repubblica ha collocato i Puffi nell’orbita della sinistra parlamentare. Ma come ricorda il giornalista Federico Vergari, autore del saggio Politik Comics, «è un esercizio che va avanti da tantissimi anni, questo di associare i puffi a una parte politica». E non è difficile capire perché: «I puffi sono penetrati dentro il tessuto sociale in maniera trasversale».
Cosa votano i Puffi?
Alphaville 13.08.2025, 11:30
Contenuto audio
Già nel 2000, La Nazione li definiva “gli ultimi comunisti”. E in effetti, l’organizzazione del villaggio puffo ha qualcosa di inquietantemente utopico. «Sono 99, tutti uguali, blu come la classe operaia. Si identificano per quello che fanno, non per quello che sono: il puffo muratore, il puffo cuoco, quello inventore…», spiega Vergari. Non c’è proprietà privata, non c’è moneta, non esiste mercato. Tutto è gestito da un leader carismatico, paternalistico: il Grande Puffo, barbuto e vestito di rosso. Serve altro?
Persino il linguaggio è livellato: «Si cerca sempre di abbattere, di appiattire e di evitare termini complessi», dice Vergari. Il verbo “puffare”, usato come ausiliare universale, è una forma di semplificazione radicale, uniformante, linguisticamente totalitaria. Una lingua che cancella le differenze, che standardizza il pensiero. Orwell avrebbe avuto qualcosa da dire.

Peyo, creatore dei Puffi, nel 1984
Ma non tutti vedono rosso. C’è chi ha letto nei Puffi una metafora massonica, con il blu come colore simbolico e i funghi come templi esoterici. Altri vedono in Gargamella — l’antagonista — la personificazione del capitalismo predatorio, vorace, decadente: sporco, avido, ossessionato dalla cattura e trasformazione dei Puffi in oro. Un’allegoria fin troppo trasparente.
E poi c’è Puffetta. L’unica donna, creata da Gargamella per seminare discordia, poi “redenta” dal Grande Puffo. «I puffi nascono che sono tutti maschi. Gargamella crea una donna per gettare scompiglio», racconta Vergari. Una figura che meriterebbe un’analisi di genere: da strumento di corruzione a icona di integrazione, ma sempre sotto il controllo maschile. Una presenza ambigua, strumentalizzata, mitizzata.
Il fumetto, ci ricorda Vergari, è tutt’altro che innocuo. «Il fumetto è un linguaggio, può raccontare qualsiasi cosa, anche la politica». E lo fa con potenza. Da Palestina di Joe Sacco, reportage grafico sul conflitto israelo-palestinese, a Maus di Art Spiegelman, che narra l’Olocausto attraverso una potente metafora visiva, il fumetto ha dimostrato di saper affrontare temi complessi con profondità e precisione.
«È un errore pensare al fumetto come qualcosa che semplifica e banalizza», afferma Vergari. I Puffi non sono solo un esercizio di nostalgia infantile: sono una lente sorprendentemente nitida, spiazzante, analitica, attraverso cui osservare il potere, l’ideologia e la rappresentazione sociale. Che si tratti di comunismo, massoneria o satira del capitalismo, il loro villaggio blu è un microcosmo che riflette le dinamiche del mondo reale.