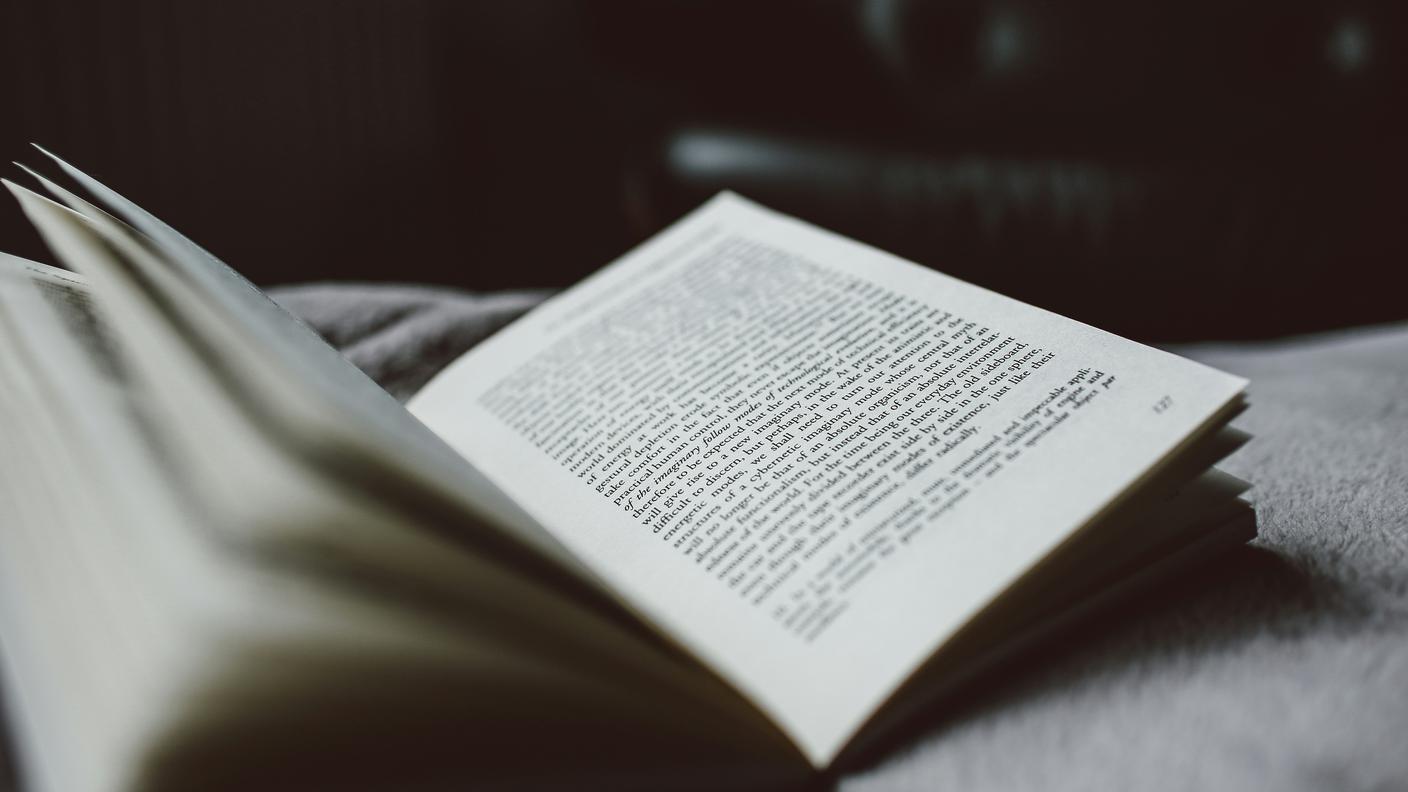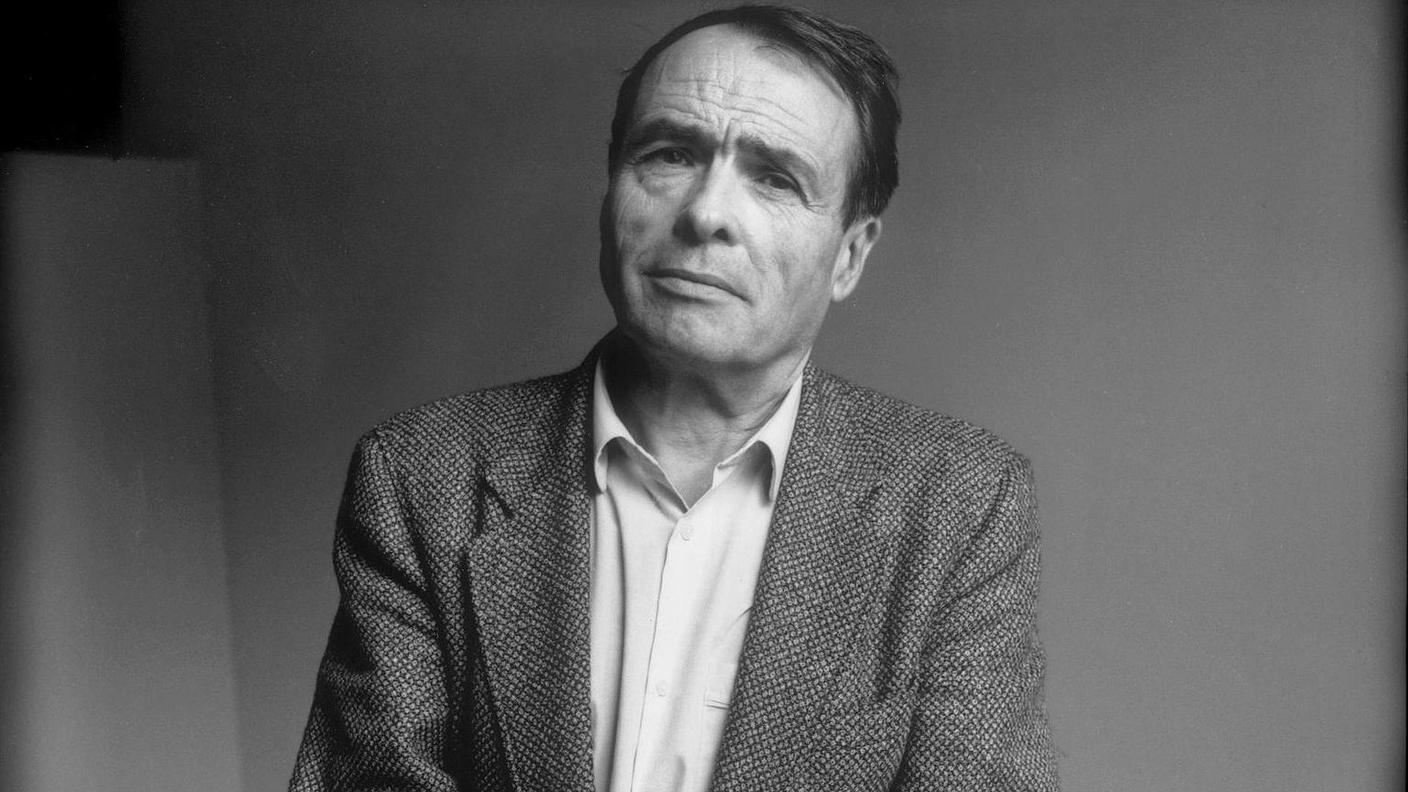A prima vista, il mercato del lavoro, al giorno d’oggi, sembra offrire pochi sbocchi a chi intraprende studi di natura culturale e letteraria. Potrebbe ad ogni modo essere un falso mito che deriva dalla percezione di una società in cui i mestieri collegati all’informatica e all’economia appaiono come moltiplicarsi di giorno in giorno. Nuove aziende, nuove priorità tecnologiche, nuove ricerche per svilupparsi sono decisamente il fiore all’occhiello di una società che vuole essere al passo coi tempi e generare introiti economici importanti, per poi reinvestirli nuovamente magari negli stessi settori da cui quegli introiti provengono.
Questo non significa, tuttavia, che oggi non si possa parlare di una rinascita del settore culturale, come afferma il giornalista ed insegnante universitario Paolo di Stefano. Una rinascita che, paradossalmente, significa nel concreto essere testimoni di una crisi di quello stesso settore, svuotato dei suoi compiti e della sua essenza più profonda e votato alla produttività sfrenata:
«Oggi sono cambiati i giornali, è cambiato il rapporto dei giornali con la cultura. Sono cambiate le pagine culturali ed è cambiato anche il rapporto degli editori con i loro autori. Prima di tutto perché è cambiato il mercato editoriale, ma anche direi il mercato culturale. C’è stata una moltiplicazione impressionante non solo di libri ma anche dei cosiddetti eventi che hanno a che fare con il libro. Penso per esempio ai festival che sono numerosissimi in Italia più che in ogni altro paese. Anche se un’altra cosa però c’è stata: da una parte, appunto, una moltiplicazione di eventi e di pubblicazioni, dall’altra parte questa moltiplicazione ha portato a una confusione inevitabile. E quindi ciò ha comportato un cambiamento anche nella critica letteraria, nell’impossibilità di selezionare e di proporre delle gerarchie a un pubblico di lettori. Questo è il dato più importante e più evidente.
Paolo di Stefano, scrittore, giornalista e docente universitario
L’implosione delle gerarchie ha dunque condannato il settore culturale a interfacciarsi con un aumento esponenziale della produzione letteraria che non è (non lo è quasi mai) sinonimo di qualità e profondità. Quello che sembra è che persino un settore che dovrebbe essere per sua natura interessato alla trasmissione del sapere e a stimolare la riflessione si ritrovi intrappolato all’interno di dinamiche aziendali, per cui l’utile è il più importante pilastro che sorregge l’intero settore. Un tradimento ideale che non può che generare conseguenze spiacevoli soprattutto se ci si rivolge al futuro:
«C’è una evidente mancanza di autorevolezza, quella stessa autorevolezza che c’era una volta. Un tempo il lettore di libri andava a prendersi il Corriere della Sera e lì trovava delle proposte che provenivano da pagine e da firme riconoscibili e quindi si instaurava un rapporto di fedeltà, di fiducia e di garanzia con il proprio giornale che era un rapporto molto più stretto e sano. Oggi assistiamo ad un fenomeno di polverizzazione, per cui ognuno si sceglie le proprie vie. Certo, potersi scegliere le proprie strade ha dei vantaggi, ma soprattutto degli evidenti svantaggi. Il fatto di essere gettati nel grande mare di questa confusione significa che il concetto di qualità in qualche modo non è più garantito da figure critiche che un tempo avevano una voce significativa e che orientavano i lettori, assumendosi così una grande responsabilità. Quindi ecco che assistiamo ad un calo della responsabilità da parte della critica odierna. Il puntare sulla quantità non è limitato al mercato librario, ma è anche nella proposta dei giornali. In un momento in cui forse si richiederebbe davvero una maggiore selezione per arginare e per proporre anche un modo di vedere le cose diverso rispetto a quello del web».
Paolo di Stefano, scrittore, giornalista e docente universitario
Per quanto riguarda il mercato editoriale, le sfide che attendono coloro che intraprendono la carriera dello scrittore e della scrittrice sono ardue, soprattutto alla luce dell’imperativo commerciale su cui si fonda l’industria libraria. Autori e autrici che devono trovare il modo di riuscire a preservare la propria autenticità letteraria e artistica all’interno di un settore ormai dedito in gran parte al guadagno:
«Oggi diciamo che le case editrici puntano moltissimo sugli esordienti. Puntano in modo forse scriteriato per tentativi spontanei, non tanto credibili perché negli anni si è sperimentato che tanti esordienti hanno avuto successo. Quindi le case editrici buttano fuori un sacco di nomi, perché magari prima o poi uno di questi riesce ad imporsi. Poi invece le difficoltà arrivano con gli altri libri, con quelli che vengono dopo, con il secondo, con il terzo. Se hai fallito il primo libro sei allora un po’ condannato definitivamente. Se invece il primo è andato bene, e succede in rarissimi casi, ma succede, allora diciamo che la casa editrice ti guarda con un certo occhio di privilegio. La differenza è che mentre prima contava meno la possibilità di vendere, il gradimento del mercato, oggi quest’ultimo è davvero tutto, mentre la qualità letteraria può esserci o non esserci, ma l’importante è che il libro si venda».
Paolo di Stefano, scrittore, giornalista e docente universitario
Il lavoro culturale tra giornalismo, editoria e università
Alphaville 14.04.2025, 18:05
Contenuto audio