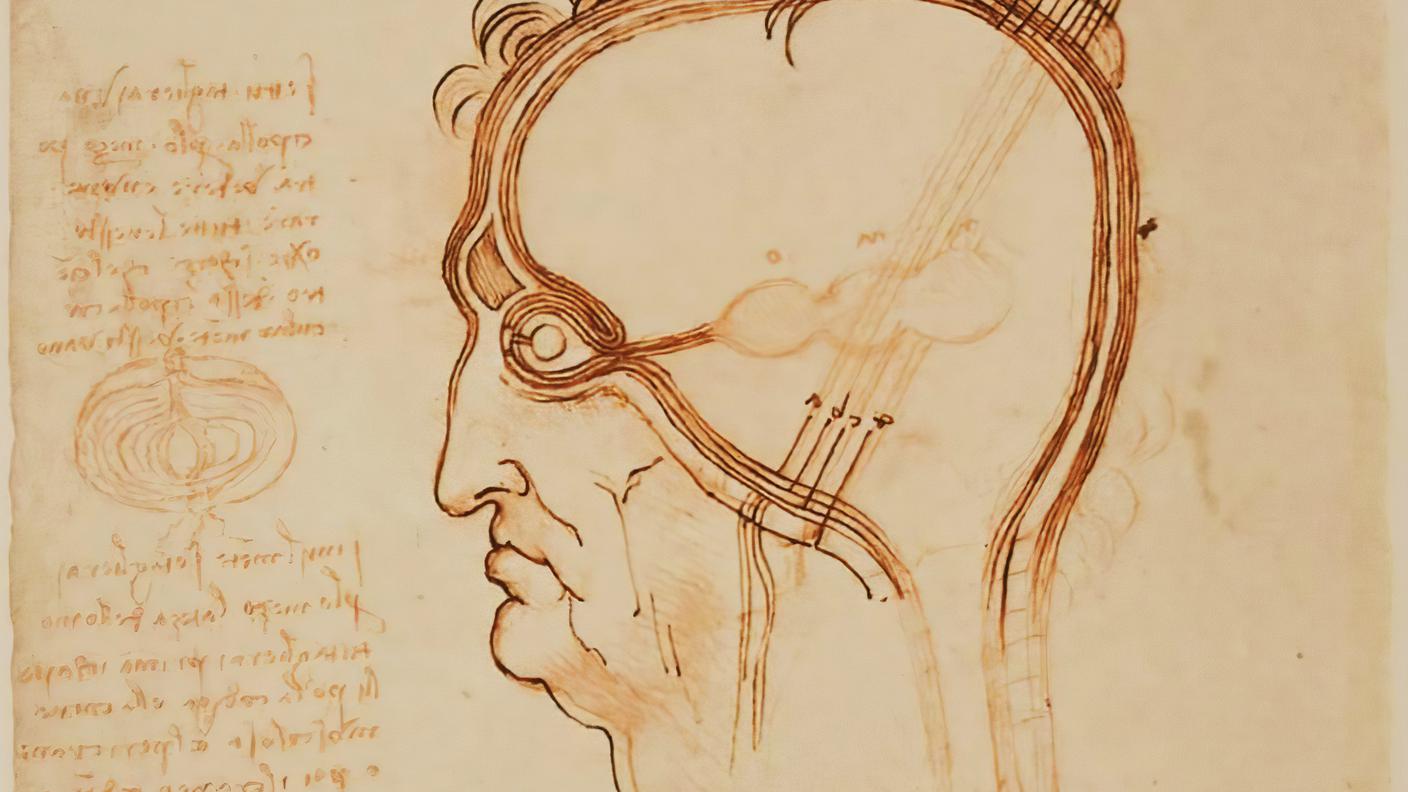Mentre la terra arde, il freddo si industrializza. Aria condizionata, frigoriferi, piste da sci sintetiche: produciamo freddo artificiale in quantità esponenziale, eppure il ghiaccio vero, quello naturale, si dissolve. È il paradosso perfetto: più freddo, più caldo. E così sconfiniamo nel grottesco: sostituendo il ghiaccio con la sua caricatura, ne acceleriamo l’estinzione.

Canicola: montagna presa d'assalto
Telegiornale 11.08.2025, 12:30
Ma ciò che stiamo perdendo, con i ghiacciai, non è solo un ecosistema. È un paesaggio mentale che ha modellato la nostra immaginazione, la nostra capacità di pensare l’ignoto, di confrontarci con il limite. La scomparsa del ghiaccio è una desertificazione dell’immaginario.
Nel XVIII secolo, esploratori e artisti si trovavano spiazzati davanti ai ghiacciai. Non sapevano come descriverli, come dipingerli. Mancavano le parole. Oggi, paradossalmente, abbiamo i dati, le formule, le simulazioni. Ma ci manca lo stupore. Il ghiaccio è diventato una curva su un grafico, un indicatore climatico. E così, mentre lo perdiamo, perdiamo anche la sua simbologia.
Max Leonard suggerisce che il nostro primo incontro con il ghiaccio fu traumatico. Una cacciata dall’Eden. Un impatto che ha lasciato un’impronta nella nostra psiche collettiva. Il ghiaccio ci ha insegnato la resistenza, la sopravvivenza, il silenzio. Ha modellato migrazioni, culture, religioni. Ha ispirato miti, leggende, esplorazioni. Ha spinto l’uomo a superarsi.
Eppure, il ghiaccio ha sempre resistito alla nostra fantasia. A differenza del fuoco, che ha acceso passioni e rivoluzioni, il ghiaccio è stato il simbolo della freddezza, dell’assenza, della distanza. Ma proprio questa sua ritrosia lo ha reso potente. Il ghiaccio non si lascia raccontare facilmente, e per questo ci ha costretto a pensare in modo diverso. A rallentare. A osservare.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/Ghiacciai-in-ritirata-la-sfida-idrica-della-Valposchiavo--2975033.html
Gaston Bachelard ci ricorda la sua doppia natura: la neve che consola, i ghiacciai che intimidiscono. Il freddo che avvolge, il freddo che respinge. È questa ambivalenza che ha alimentato la nostra immaginazione per millenni. E ora, con la sua scomparsa, rischiamo di perdere anche quella tensione creativa.
Il ghiaccio ha avuto un ruolo centrale anche nella letteratura. Jules Verne, con La sfinge dei ghiacci, immaginava un Polo Sud misterioso e magnetico, dove la natura glaciale si fa enigma e minaccia. Edgar Allan Poe, nel suo Arthur Gordon Pym, lo descrive come confine dell’umano, luogo di dissoluzione e vertigine. Miguel Serrano lo trasforma in mito esoterico, mentre Salgari lo rende teatro d’avventura. Il ghiaccio è sempre stato il luogo dove la razionalità si incrina e il fantastico prende il sopravvento.
Supercelle e catastrofi meteo
Laser 03.10.2025, 09:00
Contenuto audio
Anche l’arte contemporanea ha fatto del ghiaccio un materiale simbolico. Olafur Eliasson, con Ice Watch, ha portato blocchi di ghiaccio groenlandese nelle piazze europee, lasciandoli sciogliere sotto gli occhi dei passanti: un orologio che segna l’agonia del pianeta. Néle Azevedo, con i suoi Melting Men, ha scolpito migliaia di figurine di ghiaccio destinate a sciogliersi, simboli dell’effimero e della fragilità umana. Il ghiaccio, in arte, è tempo che si consuma, memoria che evapora, materia che si dissolve.
La perdita dei ghiacci è come la perdita della biodiversità: non solo ambientale, ma cognitiva. Meno ghiaccio significa meno possibilità di pensare il mondo in modo complesso, meno spazio per il mistero, per l’altrove, per il silenzio. È una crisi dell’immaginazione.
La vera sfida non è solo salvare i ghiacci fisici. È salvare il ghiaccio mentale. Quel frammento cristallino del pensiero umano che ci ha insegnato a vedere il mondo con occhi diversi. Perché il ghiaccio non è solo un indicatore climatico. È un patrimonio culturale. È una lente attraverso cui abbiamo guardato il mondo. E se lo perdiamo, perdiamo anche una parte di noi.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/dialogo/Perch%C3%A9-la-Svizzera-si-scalda-pi%C3%B9-di-altri-Paesi--2997546.html