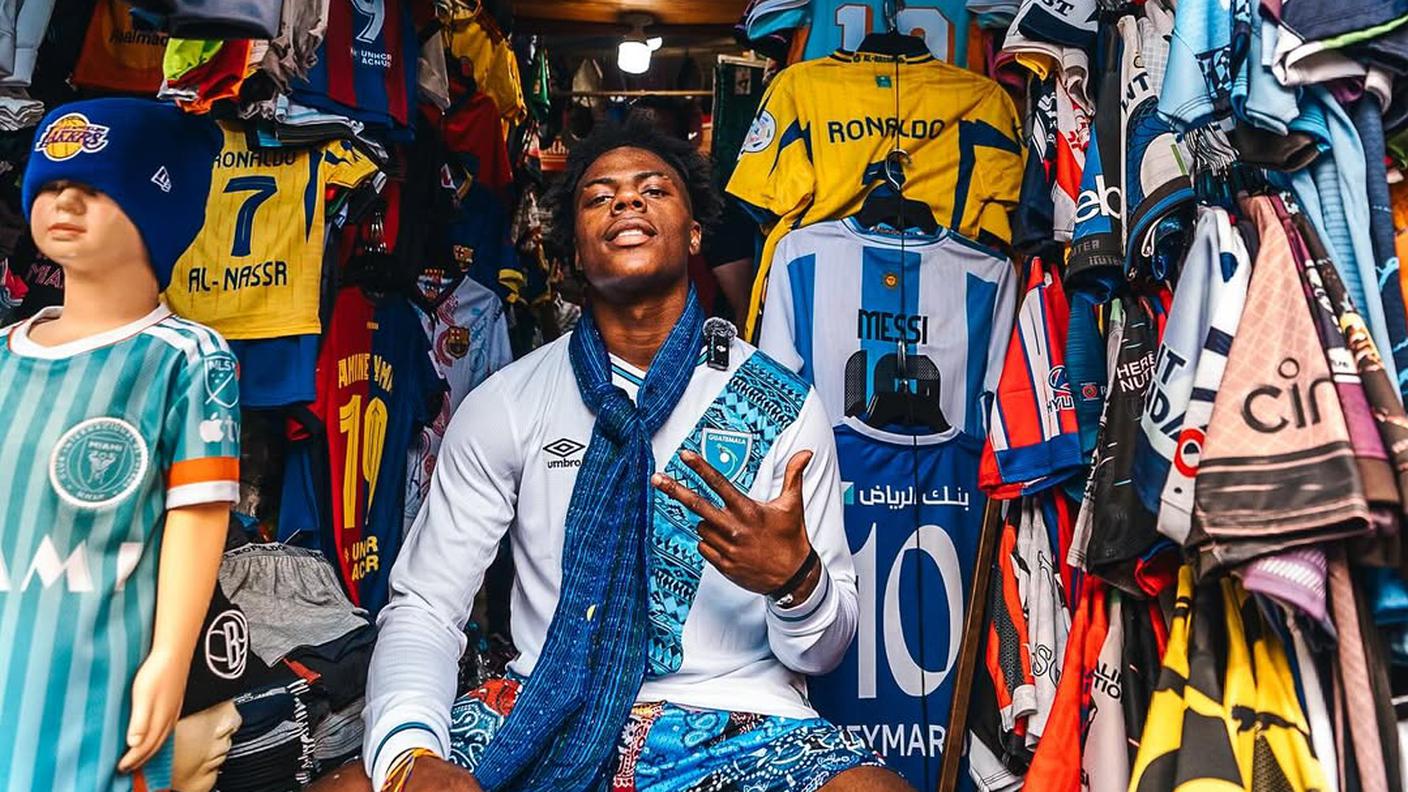Fino allo scorso maggio, erano quasi centodieci milioni di copie. Poi Zelda: Tears of The Kingdom ne ha vendute altri dieci milioni solo nei primi tre giorni. Sono effettivamente i numeri, a certificare l’importanza fondamentale della saga di Zelda nella storia del videogame. Ma anche se viviamo in tempi in cui chi ha successo ha sempre ragione, e i numeri sono tutto, possiamo ancora permetterci di pensare che non bastino. Il successo passa, i best seller scarsi vengono presto dimenticati. La persistenza di Zelda nel nostro immaginario invece va oltre i rendiconti, e la qualità delle opere che fanno parte della saga trascende l’ambito dei videogame.
Che poi, a pensarci, anche quest’ultimo si è allargato enormemente nell’ultimo mezzo secolo, fino a far diventare quelle raccontate dai videogiochi storie fondative per un’intera generazione, così come un tempo capitava con i romanzi o con i film. Il che non significa, per carità, che non passi alcuna differenza tra leggere Proust e giocare a The Last of Us. Però bisogna riconoscere che la qualità della narrazione videoludica si sia alzata fino a raggiungere picchi inaspettati, e che stabilire paralleli tra videogame e classici letterari abbia finalmente senso.
Zelda è una saga fantasy, un gioco di azione e avventura che ruota intorno all’eroe Link, chiamato a salvare un mondo fantastico e con esso – solitamente – la principessa Zelda che dà il nome al gioco. Dietro quest’idea banalissima c’è la costruzione di un mondo assai meno banale, portato davanti agli occhi di chi gioca con una grazia e una solennità non comuni: soprattutto questo tono, unito a un’estetica infantile ma non umoristica, distingue Zelda da altri, celeberrimi prodotti del mondo del videogame in generale e Nintendo in particolare, a partire da Super Mario.
Il lavoro degli autori di Zelda, da Shigeru Miyamoto (creatore anche di Super Mario) ieri a Eiji Aonuma oggi, è pura mitopoiesi, paragonabile – fatte le dovute differenze – a quello portato a termine da J.R.R. Tokien o H.P. Lovecraft. E certo, qualsiasi narrazione fantasy moderna può in qualche modo essere ricondotta a Tolkien, magari con lo scopo di nobilitarla. Eppure è difficile non vedere i paralleli tra gli stessi autori, messi in fila ad esempio dalla tolkienista (pare che un titolo del genere esista davvero) Alicia Fox-Lenz nella raccolta di saggi intitolata proprio Mythopoeic Narrative in The Legend of Zelda: sia Tolkien che Miyamoto ad esempio hanno lavorato sui loro racconti durante periodi di rapido sviluppo dei loro rispettivi paesi – l’Inghilterra della seconda rivoluzione industriale, il Giappone del boom tecnologico – ed entrambi erano affascinati dal mito del “mondo naturale” giunto ormai al tramonto, mito che è filtrato nelle loro opere. Entrambi hanno fatto evolvere i mondi che hanno creato, da semplici contenitori per storie infantili a universi capaci di parlare anche al pubblico adulto: la narrazione della Terra di Mezzo diventa assai più matura tra Lo hobbit e Il signore degli anelli, così come quella del mondo di Hyrule fa tra l’esordio di The Legend of Zelda e il già citato ultimo capitolo Tears of The Kingdom. Oggi, l’ultimo capitolo di Zelda è consigliato “da dieci anni in su” (dodici in alcuni paesi), e il fatto sorprendente è che il limite superiore è per una volta realistico: Tears of The Kingdom può essere effettivamente apprezzato anche dal pubblico più adulto, come capita con le grandi, complesse, fantastiche storie animate dello studio Ghibli di Hayao Miyazaki, o della Pixar.
Zelda però non è solo una grande narrazione fantasy costruita sulle fondamenta di archetipi condivisi in mezzo mondo: rappresenta in qualche modo anche la quintessenza del videogame moderno. Non solo perché Zelda è da sempre costruito per non costringere il giocatore a seguire un percorso lineare (al contrario ad esempio del già citato Super Mario), e questo tipo di approccio è alla base dei cosiddetti videogiochi open world che dominano il mercato nel 2023. Ma anche e soprattutto perché Zelda ha imposto al grande pubblico la struttura che caratterizza il 90% dei videogame realizzati negli ultimi quarant’anni (tanto che qualcuno ha parlato di “Miyamoto Framework”): un mondo con il quale si interagisce tramite un avatar, controllato direttamente dal giocatore, che lo muove verso un obiettivo, superando ostacoli e subendo punizioni in caso di errori. Miyamoto ha ammesso nel corso di alcune interviste di aver dato all'avatar il nome "Link", perché il personaggio è effettivamente il nostro legame con il sistema-mondo del gioco, in continua espansione intorno a lui, intorno a noi. Difficile non pensare – senza bisogno di scomodare alcuna delle pur molteplici e autorevolissime teorie psicologiche sull’argomento – quanto questo processo di continua esplorazione e adattamento assomigli, semplicemente, all’esperienza umana che segue la fine della prima infanzia, e che ci accompagna per l’intera esistenza.
Zelda, inoltre, rispetto ad altre narrazioni letterarie o cinematografiche fantasy a cui possiamo paragonarla, ha il vantaggio tipico dei videogame, cioè l’immersività. Non perché non ci si possa perdere dentro un romanzo o un film, ovviamente, ma perché il modo stesso in cui facciamo esperienza di un videogame – soprattutto se prevede sessioni di gioco relativamente lunghe come Zelda – aumenta la possibilità di essere coinvolti emotivamente. Inevitabilmente, parti diverse della nostra mente reagiscono in modo diverso agli stessi stimoli: sappiamo che Zelda è un gioco e una narrazione, sappiamo che si tratta di fiction ben progettata. Tuttavia, l’immersione in un mondo plausibile e che, pur se non è realistico, segue le leggi emotive del nostro, fa sì che alcuni aspetti inconsci della nostra mente reagiscano come farebbero nella realtà: facendoci provare dunque vera felicità, tristezza, paura. Soprattutto, però, nel caso di Zelda, si tratta di meraviglia: una sensazione che ricerchiamo sin dall’antichità, e che nel mondo contemporaneo diventa ogni giorno più preziosa.