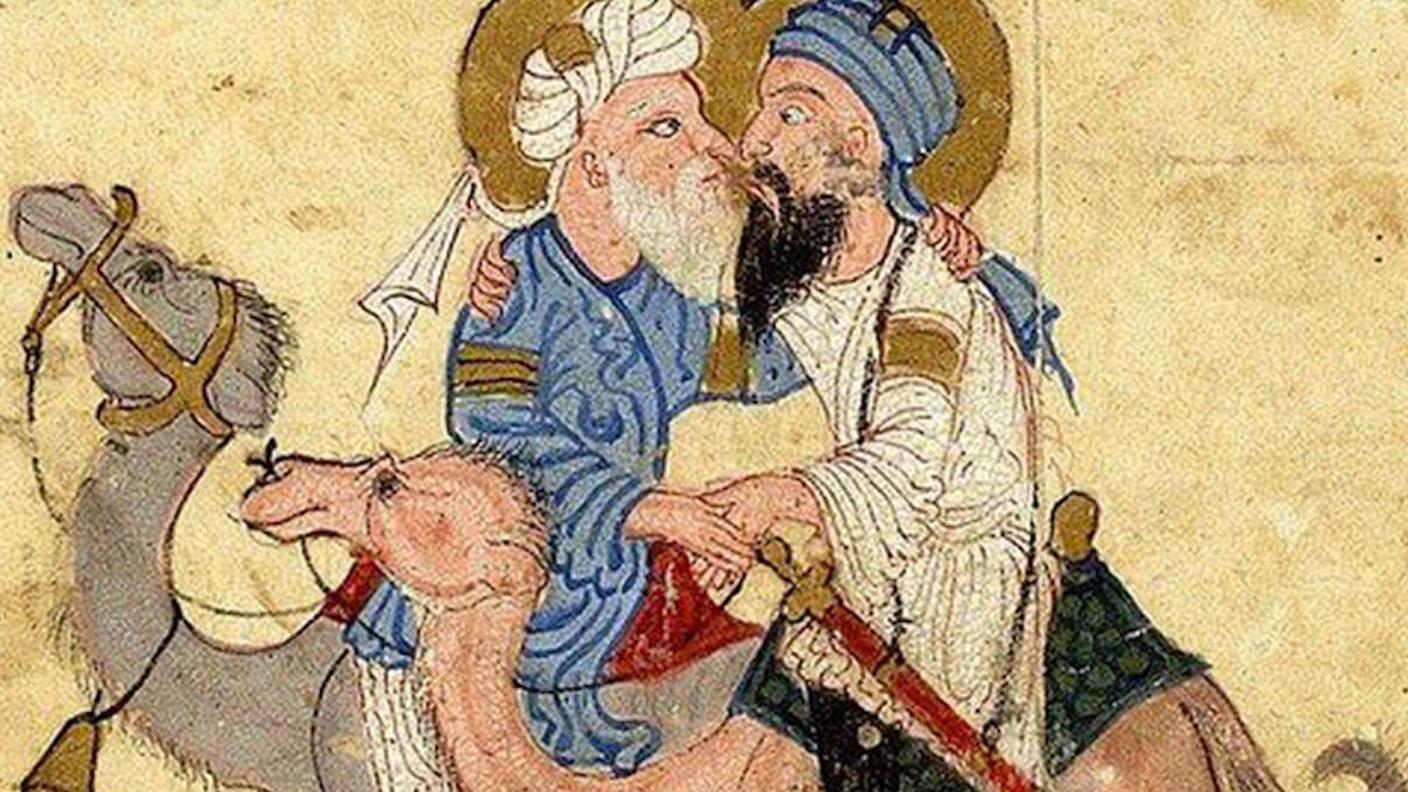Un’amica mi ha parlato della fine della sua relazione sessuoaffettiva, dopo 20 anni. Ha usato l’espressione «lutto senza il morto», e mi ha spiazzato. Ma è esatta: dopo aver trascorso metà della propria vita insieme a una persona, la sensazione che si prova quando ci si lascia è molto vicina a quella del lutto dopo la morte di una persona amata. È quello che ho provato per la fine della relazione con la mia amica più storica, una delle più care: abbiamo condiviso 26 anni di vita, e poi le nostre strade si sono separate. Non trovavo le parole, quindi ho usato quelle che avrei usato per raccontare la fine di una relazione romantica: «Ci siamo lasciate».
La nostra società ha creato una gerarchia non scritta dei lutti. Al vertice c’è la morte di una persona. Anche qui, con distinzioni: un genitore o un partner vale più di un’amicizia, una persona giovane più di una anziana, una persona morta di morte naturale più di una morta per cause “socialmente inaccettabili” come l’AIDS, un’overdose, o il suicidio. In fondo alla classifica, ci sono tutte le altre perdite.
Potremmo chiamarli “lutti in sala d’attesa”. Quei dolori senza nome, a cui non viene dato il permesso di entrare.
Sono perdite invisibili. La morte di un animale: in fondo, «era solo un gatto», e «puoi sempre prenderne un altro». Ma anche la fine di una relazione: non solo divorzi e separazioni di relazioni romantiche (gerarchicamente “più importanti”), ma anche la fine di amicizie o rapporti che non hanno un riconoscimento sociale, come per esempio una relazione extraconiugale.
Licenziamenti o fallimenti: la perdita del lavoro non è solo economica; è la perdita di un ruolo sociale, di una routine, di un’identità. È un lutto vissuto spesso con vergogna, come un fallimento personale. Il lutto per la fine di un sogno familiare: quando ci si separa e sono coinvolte altre persone il dolore è moltiplicato. Ma anche un sogno professionale, accantonato per i motivi più svariati, può essere un dolore devastante e poco compreso. Anche un sogno politico o valoriale, accantonato o naufragato per i motivi più diversi, può essere difficile da superare. Pensiamo alla caduta del Muro di Berlino, alla fine di un partito o alla chiusura di un’associazione in memoria di una persona cara.
Lo scioglimento di un gruppo musicale amatissimo, o il pensionamento di una persona che consideriamo mentore, l’abbandono della casa in cui abbiamo vissuto esperienze importanti, un trasferimento. La scoperta di non poter avere figlie o figli biologici, un aborto, ma anche l’allontanamento, il cambiamento di una persona amata a causa di una dipendenza. La sensazione di mancanza quando non si ha avuto un genitore, o si è vissuto un abbandono in età infantile.
Altri lutti nascosti sono quelli legati a una malattia cronica o a una disabilità acquisita, o alla scoperta di avere un problema di salute mentale. Lo stesso vale se queste esperienze sono vissute da una persona cara.
Il problema di questi lutti è che, non essendo riconosciuti a livello sociale, chi li vive non sente l’autorizzazione a esprimere il proprio dolore: tende a soffocarlo, a minimizzarlo. Questo prolunga e complica il processo di elaborazione.
Mancano anche rituali e parole. Per questi lutti, non abbiamo un vocabolario condiviso. Non ci sono condoglianze per chi perde il lavoro. Non ci sono giorni di permesso per la morte di un cane. Questa assenza di linguaggio e di rituali nega l’esperienza, costringendo le persone a elaborare il dolore in solitudine.
Il sociologo Kenneth Doka nel 1989 ha coniato l’espressione disenfranchised grief, che si può tradurre come “lutto non autorizzato”. Questa espressione descrive un dolore a cui la società non concede la “franchigia”, cioè il diritto di essere vissuto, espresso e riconosciuto pubblicamente: «La perdita non può essere apertamente riconosciuta, validata socialmente o pianta pubblicamente» (Disenfranchised Grief. Recognizing Hidden Sorrow, Lexington Books, 1989). In altre parole, alle persone sopravvissute non è stato accordato il diritto di soffrire.
Renee Blocker Turner e Sarah D. Stauffer, nel volume Disenfranchised Grief. Examining Social, Cultural, and Relational Impacts (Routledge, 2024), suggeriscono una “nuova categoria di lutto” che include le perdite «specificamente legate a discriminazione, marginalizzazione e oppressione». Questo saggio collega esplicitamente il lutto non autorizzato a quadri teorici di giustizia sociale: una parte del saggio è dedicata a come le barriere sistemiche creino lutti non autorizzati per gruppi specifici, come le persone LGBTQIA+, afrodiscendenti, con disabilità e che sopravvivono a violenza sessuale. Per le persone LGBTQIA+, il lutto non autorizzato può verificarsi a causa della mancanza di riconoscimento sociale delle loro relazioni o della loro perdita. Nella comunità afrodiscendente, il lutto non autorizzato è anche legato al lutto collettivo per la violenza razziale e la brutalità della polizia. Le persone con disabilità spesso sperimentano perdite legate a indipendenza o identità che non vengono riconosciute come lutti validi dalla società non disabile. Le persone sopravvissute alla violenza sessuale sperimentano un lutto non autorizzato per la perdita della sicurezza, della fiducia e del senso di sé. Inoltre la cultura dello stupro e il “biasimo della vittima” (victim-blaming) spesso non autorizzano questo dolore, suggerendo che la persona sopravvissuta sia in qualche modo responsabile della propria perdita.
Doka suggerisce alcune soluzioni: dato che la società nega i rituali pubblici (funerali, permessi di lavoro, visite di condoglianze) per i lutti non autorizzati, la persona che soffre dovrebbe creare attivamente i propri rituali. Per esempio scrivere un elogio funebre, restituire o distruggere oggetti simbolici, creare una scatola dei ricordi. La seconda soluzione è la validazione: il semplice atto di riconoscere che la perdita è reale e che il dolore è legittimo. Per questo bisogna cercare di circondarsi di persone che comprendono e validano il nostro lutto, e iniziare a riconoscerlo e validarlo iniziando da sé.
Quante volte abbiamo nascosto il nostro dolore perché non ci sembrava abbastanza importante? E cosa possiamo fare, come collettività, per costruire nuovi rituali che diano dignità a tutte le nostre perdite, individuali e collettive?

L'elaborazione di un lutto
Prima Ora 21.10.2025, 18:00