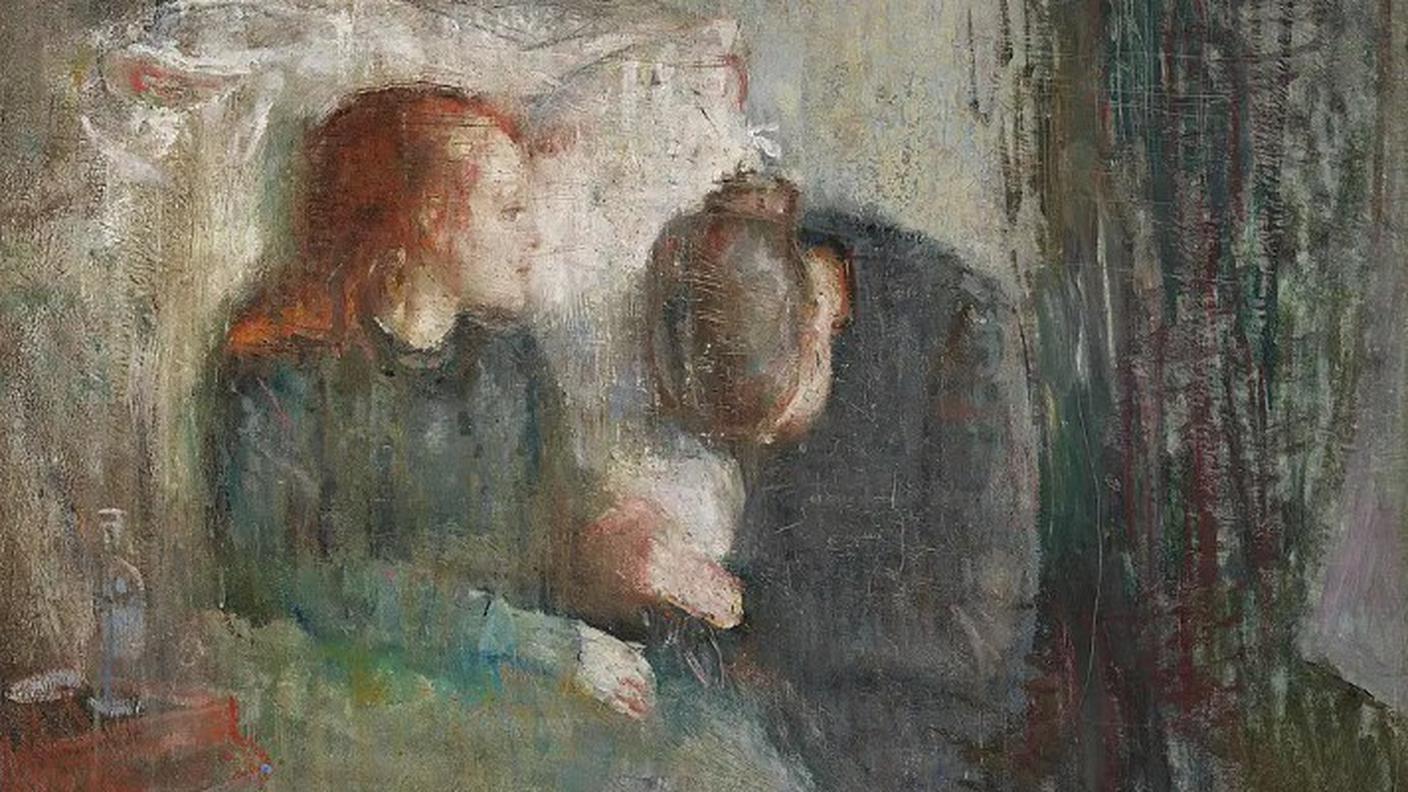«Il fascismo non è stato un corpo estraneo alla società italiana, ma una sua espressione storica» — così scriveva Emilio Gentile, tra i massimi studiosi del regime. Eppure, l’Italia democratica ha preferito raccontarsi una favola: quella di un popolo traviato da un uomo solo, redento dalla Resistenza, e immune da derive autoritarie. Una favola utile, certo, ma pericolosa. Perché ha lasciato il fascismo vivo sotto pelle, pronto a riemergere non come regime, ma come linguaggio, stile, tentazione.
Dopo il 1945, nessuna Norimberga italiana. Nessuna epurazione sistematica. Nessuna riflessione collettiva sulle complicità diffuse. I funzionari del regime rimasero al loro posto, i prefetti continuarono a firmare, i docenti a insegnare. La Costituzione repubblicana nacque antifascista, ma in un Paese che non aveva fatto i conti con il proprio passato. «La democrazia italiana è nata zoppa» — scrive Giovanni De Luna — «perché ha rimosso il trauma invece di elaborarlo».
La memoria pubblica si è divisa. Da un lato, l’epica resistenziale, spesso mitizzata. Dall’altro, il revisionismo strisciante, che ha ridotto il fascismo a folklore, a estetica, a “parentesi autoritaria”. I manuali scolastici hanno parlato di Mussolini più che del fascismo. Le leggi razziali sono state trattate come un errore, non come il frutto coerente di un’ideologia. Il colonialismo italiano è rimasto ai margini, come se fosse stato gentile, educativo, “diverso” da quello altrui.
Anche il cinema ha avuto un ruolo decisivo in questa rimozione. Film come La vita è bella di Roberto Benigni (1997) hanno commosso il mondo, ma anche consolidato una narrazione ambigua: quella di un italiano buono, che protegge il figlio dai nazisti cattivi, in un campo di concentramento dove l’orrore è tedesco, mai italiano. Il film non nomina le leggi razziali del 1938, né il ruolo attivo del fascismo nella deportazione degli ebrei. «La Shoah italiana è stata raccontata come una tragedia tedesca, con italiani spettatori o eroi» — osserva David Bidussa.
Il neorealismo, pur con la sua forza etica, ha contribuito a questa semplificazione. Roma città aperta (1945) mostra la brutalità dell’occupazione nazista, ma lascia sullo sfondo la complicità fascista. Il nemico è il tedesco, il collaborazionista è un’eccezione. La commedia all’italiana, poi, ha spesso ridicolizzato il Ventennio, trasformandolo in caricatura. Il federale (1961) di Luciano Salce, con Ugo Tognazzi, mostra un fascista grottesco, più ridicolo che pericoloso. Il regime diventa farsa, non tragedia.

Questa tendenza non è solo italiana. Anche in Francia, Germania e Stati Uniti il cinema ha spesso isolato il male nel nazismo, evitando di affrontare le zone grigie, le complicità, le responsabilità diffuse. Ma in Italia, dove il fascismo fu regime e cultura, questa rimozione ha avuto effetti più profondi. Ha contribuito a costruire una memoria selettiva, dove l’antifascismo è celebrato, ma il fascismo non è compreso.
«La storia non è un tribunale, ma può essere una scuola di responsabilità» — ammoniva Claudio Pavone. Eppure, quella scuola non è mai stata davvero frequentata. Il fascismo è stato condannato moralmente, ma raramente studiato come fenomeno sociale, culturale, antropologico. Non si è voluto vedere quanto consenso raccolse, quanta modernità incarnò, quanta continuità lasciò in eredità.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il linguaggio politico si è impoverito, l’antifascismo è diventato una formula vuota, buona per cerimonie e anniversari. I simboli del regime riemergono nei cortei, nei social, nei discorsi pubblici. Alcuni partiti flirtano con la retorica fascista, approfittando dell’amnesia nazionale. La Shoah è commemorata, ma spesso separata dalla riflessione sul fascismo italiano che la rese possibile. Il razzismo, la misoginia, l’autoritarismo trovano spazio perché non sono percepiti come eredità storiche, ma come opinioni legittime.
La democrazia, senza memoria, diventa fragile. Non basta votare per essere liberi. Serve sapere da dove si viene, cosa si è stati, cosa si è scelto. Serve riconoscere che il fascismo non fu solo violenza, ma anche consenso, seduzione, promessa. E che quelle stesse dinamiche possono tornare, sotto altre forme, in altri contesti.
«Il fascismo è eterno» — scriveva Umberto Eco — «perché è una struttura mentale, più che un regime». E quella struttura, se non la si smonta, se non la si interroga, se non la si espone alla luce della storia, resta lì. Pronta a riattivarsi. Pronta a parlare la lingua del presente.
Gli intellettuali e il fascismo
Alphaville 15.05.2025, 12:30
Contenuto audio
Bibliografia
Pavone, Claudio. Una guerra civile. Bollati Boringhieri, 1991
Eco, Umberto. Il fascismo eterno, in Cinque scritti morali. Bompiani, 1997
Gentile, Emilio. Il fascismo come religione politica. Laterza, 2001
Marcus, Millicent. Italian Film in the Shadow of Auschwitz. University of Toronto Press, 2002
Bidussa, David. Il passato alle spalle. L’Italia e la memoria della Shoah. Einaudi, 2007
De Luna, Giovanni. La Repubblica inquieta. Feltrinelli, 2017
La stampa italiana e il dibattito sul regime fascista (1945–1955)