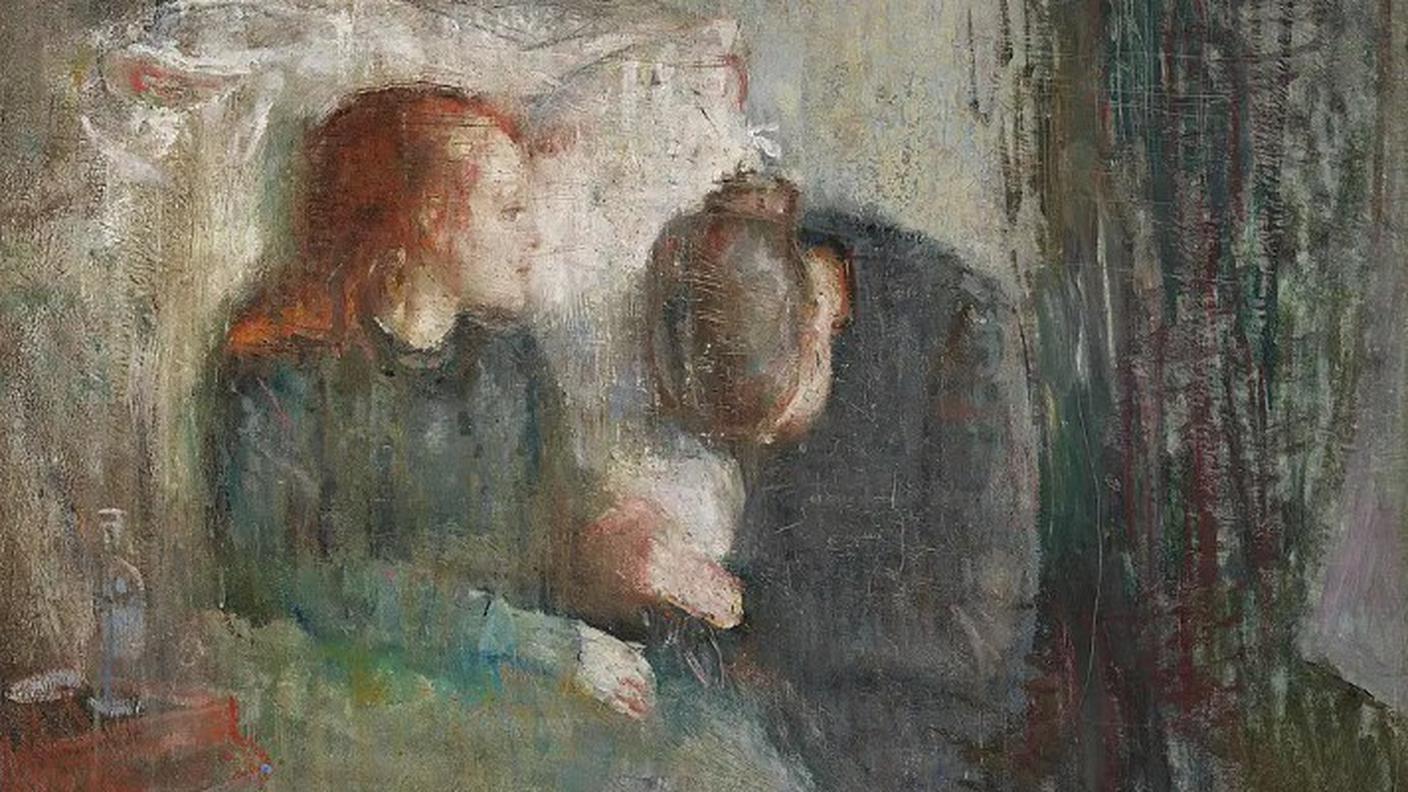Il boia cambogiano. Uno dei dittatori più feroci al mondo.
Lo pseudonimo universalmente noto è Pol Pot, all’anagrafe registrato come Saloth Sâr, nato il 19 maggio 1925 a Prek Sbauv nella provincia di Kampong Thom in Cambogia, e morto il 15 aprile 1998 ad Anlong Veng, nel nord-ovest del Paese.
Il ‘diavolo rosso’, come lo soprannominò il giornalista Robert J. Samuelson (Pol Pot: Il diavolo rosso, 2021): un uomo che sognò una Cambogia contadina “pura”. Un’ideologia radicale che cancellò un quarto della popolazione. Un progetto totalitario che trasformò i cittadini in schiavi dei campi, riducendo la Cambogia a un laboratorio di sterminio.
Nato in una modesta famiglia di contadini, proprietaria di alcuni ettari di terra e di risaia, grazie alla sorella Luk Khun Meak (ex concubina del re Monivonga) a sei anni si trasferì a Phnom Penh con due fratelli. Nella capitale cambogiana venne avviato al noviziato buddhista nel monastero di Botum Vadey e poi studiò in un istituto cattolico fino ai quattordici anni. Gli anni della giovinezza, e in particolare il periodo in cui studiò all’interno del monastero, rivestirono un ruolo centrale nell’evoluzione identitaria di Saloth Sâr: la sua familiarità con il buddhismo esercitò un’influenza indiretta ma significativa su diversi aspetti di quella che fu poi la futura politica di Pol Pot (Il comunismo dei khmer rossi come religione della politica, Mattia Basso, 2023).
Studiò al Collège Sihanouk di Kompong Cham e, successivamente, al Collège technique Russey Keo di Phnom Penh, dove ottenne una borsa di studio per l’École française de radioélectricité di Parigi. Durante il periodo francese entrò in contatto con ambienti marxisti, si iscrisse al Partito Comunista Francese e cominciò a maturare idee rivoluzionarie, innescando anche la trasformazione identitaria da cui nacque il soprannome, ma non ancora l’uomo spietato che avrebbe poi fatto uccidere circa due milioni di compatrioti.
Tornato in Cambogia nel 1953, si unì al Partito Comunista della Cambogia (Pracheachon, 1951), con l’incarico di proselitismo e della creazione di comitati politici nei villaggi. In quel periodo di legge marziale, Saloth Sâr si confrontò presto con l’esigenza di clandestinità, apprendendo le tecniche dell’azione segreta e del vivere sotto copertura e, in questo contesto, il nome di battaglia che aveva scelto iniziò a rivelarsi particolarmente utile per mantenere una parvenza di normalità. Il 9 novembre 1953 fu proclamata l’indipendenza da parte del re, atto ratificato ufficialmente nel 1954 attraverso gli Accordi di Ginevra, che sancirono il riconoscimento della Cambogia come Stato autonomo e sovrano. Saloth Sâr rientrò a Phnom Penh, dove insegnò storia, geografia e letteratura francese al liceo Chamroeun Vichea; fu un’altra fase cruciale della sua vita, nella quale apprese la capacità di parlare in pubblico, fondamentale poi nella sua successiva attività politica.

Bandiera della Democratic Kampuchea, Cambogia.
L’ascesa al potere e la trasformazione completa in Pol Pot avvenne a partire dal 1962, quando prese il posto di Tou Samouth dopo il suo assassinio (How Pol Pot came to power: a history of communism in Kampuchea, 1930–1975, Ben Kiernan, 1985), segretario del Communist Party of Kampuchea (PCK): un’organizzazione politica clandestina ispirata al marxismo-leninismo e successivamente al maoismo, che mirava a trasformare radicalmente la società cambogiana attraverso l’abolizione della proprietà privata, della religione e delle istituzioni tradizionali.
Il partito mantenne un profilo estremamente segreto fino al 1975, anno in cui ottenne il potere approfittando del vuoto lasciato dal ritiro americano con la fine della guerra del Vietnam (The Pol Pot Regime, Ben Kiernan, 2002), conquistando Phnom Penh e instaurando la Kampuchea Democratica (1975–1979). Pol Pot divenne Primo Ministro nel 1976, avviando una radicale trasformazione del Paese ispirata al maoismo e alla Rivoluzione Culturale cinese; in quel periodo i membri armati, i funzionari e i sostenitori del CPK vennero identificati con il nome di Khmer rossi, un termine coniato inizialmente dai media e dagli oppositori che poi si diffuse su scala globale.
Si trattava di un regime alla cui base c’era sia un apparato militare, sia uno ideologico, attraverso i quali Pol Pot attuò il suo processo di “purificazione”, evacuando forzatamente le città e deportando la popolazione nelle campagne, eliminando sistematicamente gli oppositori politici, gli intellettuali, le minoranze etniche e religiose. Abolì infatti la proprietà privata, la moneta e le religioni, e chiunque fosse sospettato di opporsi al regime veniva arrestato, torturato e spesso giustiziato; il solo fatto di indossare degli occhiali poteva essere considerato segno di intellettualismo e portare dunque alla condanna a morte.
Si stima che tra il 1975 e il 1979 morirono tra 1,7 e 2,5 milioni di persone, ossia il genocidio di circa un quarto della popolazione cambogiana dell’epoca, avvenuto a causa di esecuzioni, carestie, lavori forzati e malattie. Luoghi come il carcere di Tuol Sleng (S-21) – in cui furono detenute, torturate e uccise oltre 15.000 persone accusate di essere nemici del regime – e i campi di sterminio di Choeung Ek – dove sono state ritrovate oltre 8.000 fosse comuni contenenti i resti di migliaia di vittime – divennero simboli delle atrocità commesse

Cambogia, teschi delle vittime degli Khmer rossi.
La caduta del regime dei Khmer rossi fu determinata in modo diretto dall’intervento militare del Vietnam, avvenuto alla fine del 1978. Se inizialmente, durante la guerra civile contro il regime di Lon Nol (predecessore di Pol Pot) i rapporti tra Hanoi e Phnom Penh erano collaborativi, vi fu un rapido deterioramento dopo l’ascesa al potere del ‘diavolo rosso’, data la linea ultranazionalista e anti-vietnamita che adottò, sfociata anche in scontri di confine a partire dal 1977 e in attacchi armati diretti da parte dei Khmer rossi nel delta del Mekong (The Tragedy of Cambodian History, David Chandler, 1991).
A seguito di queste aggressioni, e con l’obiettivo di installare un governo amico, il Vietnam lanciò una massiccia invasione della Cambogia il 25 dicembre 1978. Con l’appoggio di fuoriusciti Khmer e del Fronte Unito di Salvezza Nazionale della Cambogia (FUSNC), le truppe vietnamite occuparono così Phnom Penh il 7 gennaio 1979, e il regime di Pol Pot crollò. I leader fuggirono verso la giungla, dove avrebbero condotto una lunga guerriglia; fu così instaurata la Repubblica Popolare di Kampuchea, sostenuta da Hanoi e riconosciuta principalmente dal blocco sovietico (The Pol Pot Regime, Ben Kiernan, 2002).
Tuttavia, nonostante ufficialmente il regime fosse caduto, i Khmer rossi resistettero e si riorganizzarono al confine con la Thailandia, continuando la lotta armata per diversi anni, ricevendo inaspettatamente sostegno materiale e diplomatico da parte della Cina e di alcuni Paesi occidentali tra cui, nel contesto della Guerra Fredda, gli Stati Uniti: contrari all’occupazione vietnamita (When the War Was Over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, Elizabeth Becker, 1998), che invece perdurò fino al 1989. Solo negli anni ’90, con gli Accordi di Parigi del 1991 e il progressivo disarmo dei gruppi armati, si avviò un processo di pacificazione e transizione democratica, sotto la supervisione delle Nazioni Unite.
I Khmer Rossi si frammentarono e nel 1997 Pol Pot fu infine arrestato dai suoi stessi compagni e posto agli arresti domiciliari. Morì il 15 aprile 1998, ufficialmente per un attacco cardiaco, poco prima di essere consegnato a un tribunale internazionale.
RG 08.00 del 16.11.2018 - Il servizio di Loretta Dalpozzo
RSI Info 16.11.2018, 09:10
Contenuto audio
I terribili crimini commessi da Pol Pot e dal suo regime rimasero a lungo impuniti. Nel 2001 il parlamento cambogiano istituì, all’interno del sistema giudiziario nazionale, un tribunale speciale (Camere Straordinarie) incaricato di giudicare i crimini contro l’umanità commessi durante il regime, ma il funzionamento ancora debole della giustizia locale portò, nel 2003, a un accordo tra le Nazioni Unite e il governo cambogiano per processare i principali responsabili dei crimini (Extraordinary Justice; Law, Politics, and the Khmer Rouge Tribunals, Craig Etcheson, 2019), con una corte ibrida, composta da giudici e avvocati sia cambogiani sia internazionali.
Tuttavia, a causa di ritardi burocratici e limitate risorse economiche, le Camere Straordinarie iniziarono a operare solo nel 2007, dunque oltre trent’anni dopo i fatti; nel 2008 furono poi formalizzate le accuse contro cinque persone, tra cui l’allora capo di Stato e alcuni ministri, e nel luglio 2010 Kaing Guek Eav, primo imputato davanti al tribunale, fu finalmente condannato: 35 anni di carcere con l’accusa, tra le altre, di genocidio e tortura. E nel 2018 una sentenza storica: i due più alti dirigenti dei Khmer rossi ancora in vita, per la prima volta, furono condannati in Cambogia per genocidio; Nuon Chea (92 anni) che era allora l’ideologo del partito comunista cambogiano e di Khieu Samphan, (87 anni), ai tempi la più alta carica istituzionale del regime di Pol Pot.
Un regime che ha provocato la morte di due milioni di persone
Grazie al monitoraggio delle Camere Straordinarie da parte dell’Open Society Justice Initiative, alcuni processi sono stati completati con condanne confermate, mentre altri sono in appello, e diversi casi restano bloccati da problemi procedurali e resistenze interne, soprattutto da parte dei giudici nazionali (swissinfo.ch, 2012). In sostanza, nonostante i numerosi successi nel dare voce alle vittime e nel documentare i crimini del regime, il tribunale è stato anche criticato per la lentezza dei processi, l’elevato costo – quantificato in centinaia di milioni di dollari – e per una portata giudiziaria limitata rispetto all’ampiezza delle atrocità commesse.
Nel 2020, la Justice Initiative ha dunque deciso di terminare il monitoraggio, evidenziando ancora criticità e crescenti interferenze politiche, così come la riduzione del sostegno internazionale e il progressivo indebolimento dell’impegno delle Nazioni Unite nel garantire l’integrità della corte.
Alla Cambogia, oggi resta solo la Giornata Nazionale della Memoria che si svolge il 20 maggio per commemorare le sue vittime. Vittime per le quali l’aspirazione a una giustizia piena, rimane infine incompiuta. E resta il trauma, l’ingiustizia e soprattutto un potente ammonimento storico, su ciò che può accadere quando il potere si fa ideologia assoluta e la vita umana diventa sacrificabile in nome di un’utopia totalitaria.
Cambogia, 50 anni dalla conquista del potere da parte dei Khmer Rossi
SEIDISERA 17.04.2025, 18:00
Contenuto audio