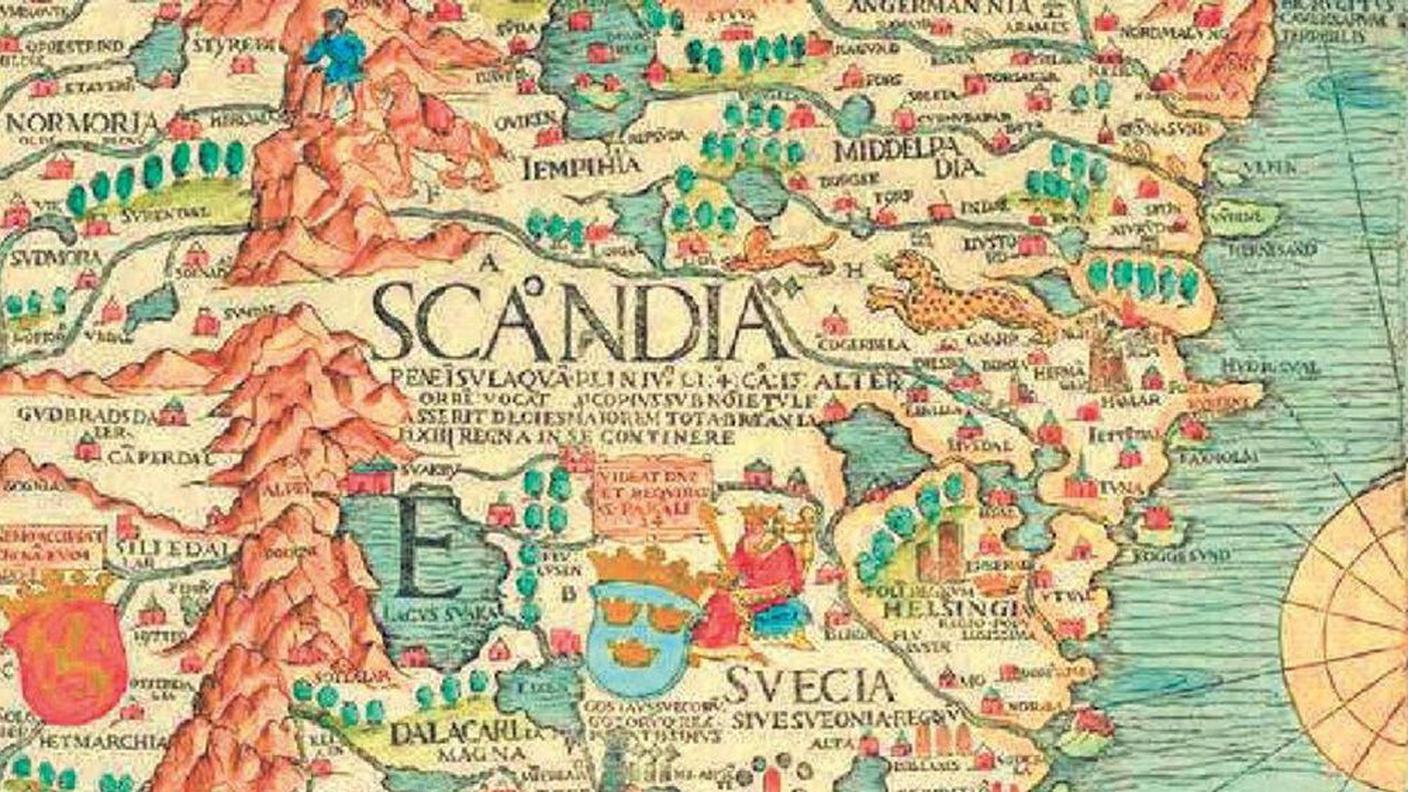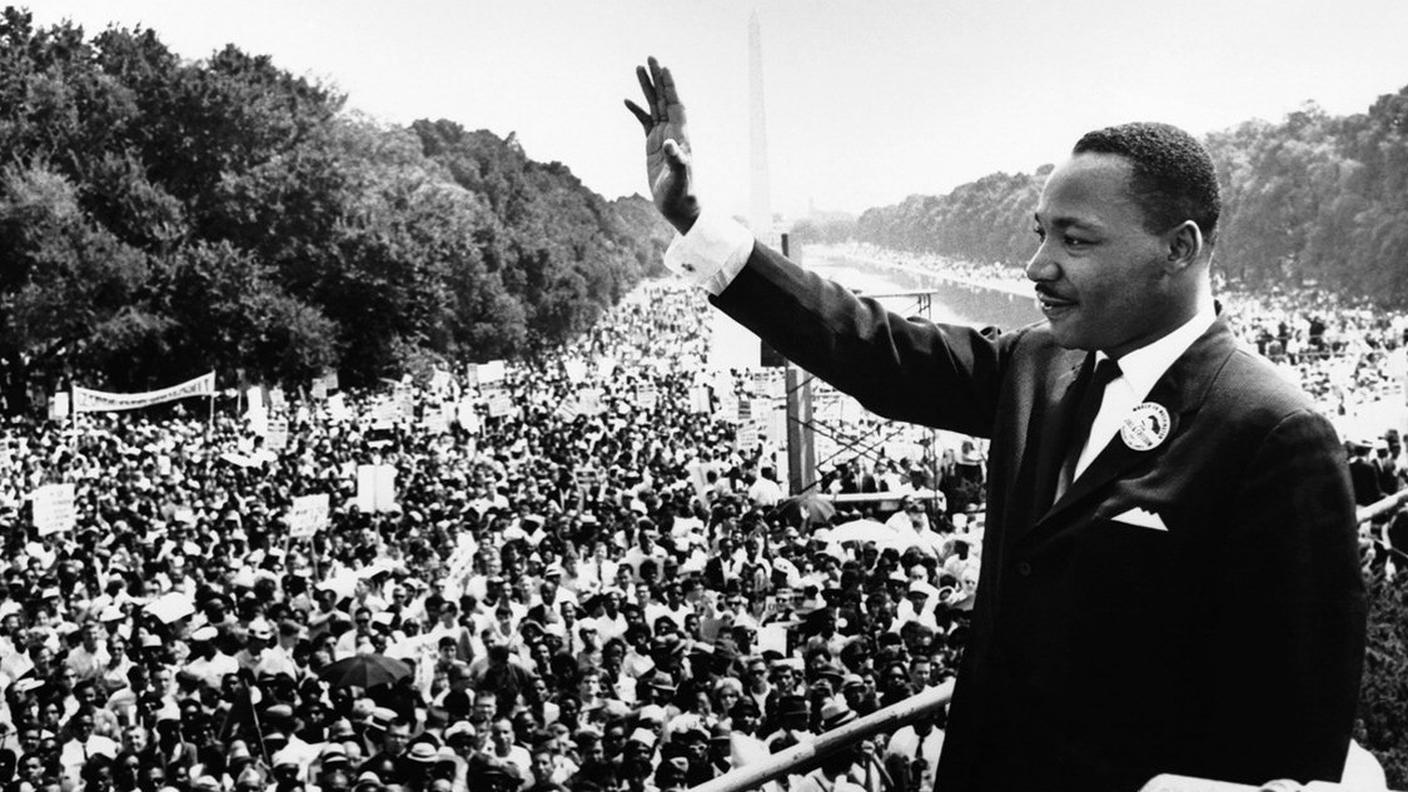Addentrandosi nella splendida valle della Breggia, seguendo il corso del fiume omonimo, non ci si aspetta di trovarsi davanti una scenografia così armonica e al contempo contrastante. La natura, con la sua scala imbattibile, riesce ad accogliere e integrare persino le strutture squadrate di un cementificio dismesso. Volumi, materiali e forme artificiali che si fondono con il paesaggio in un equilibrio sorprendente. Ma il merito va anche ai progettisti della riconversione, che hanno saputo distillare l’essenza dell’architettura industriale e di una fetta importante della storia moderna locale.
Nella piana “ai Molini” oggi convivono la bellezza selvaggia del paesaggio, il valore della storia vissuta e il fascino innegabile dell’architettura — quella grande, potente, che sorprende e incanta proprio perché fuori contesto.
Tutta l’area oggi è gestita dalla Fondazione Parco delle Gole della Breggia, che oltre a mantenerla intatta, la mantiene anche viva: gli spazi del sedime vengono affittati per manifestazioni artistiche, musicali o eventi di vario tipo (vengono girati anche diversi film).
Inoltre, la Fondazione organizza una serie di visite guidate che permettono di conoscere i vari aspetti di questo luogo, dalle peculiarità geologiche del parco naturalistico (dal 1998 è tra le zone naturali da salvaguardare), all’interessante storia della produzione del cemento, che si sperimenta percorrendo i cunicoli di estrazione nelle viscere della montagna e visitando gli spazi entro i quali si svolgevano le varie tappe del processo produttivo.
La Saceba in zona Molini
Il cementificio Saceba (acronimo di Società Anonima CEmento BAlerna) nasce nel 1963, in pieno boom edilizio, e va quindi a rispondere all’enorme domanda di calcestruzzo necessario per la costruzione di edifici, ponti, viadotti, autostrade, dighe. L’iniziativa parte da Paride Melera e Hans Rudolf Suter, che verranno poi accompagnati nell’impresa da altri importanti imprenditori, come Cesare Giudici e Paride Pelli.
Saceba: da ex-cementificio a luogo culturale
RSI Cultura 13.05.2025, 17:00
Poi per 40 anni, fino alla sua chiusura nel 2003, sarà la fabbrica di moltissimi impiegati e operai (con un picco di 150 persone negli anni d’oro): addetti all’estrazione della materia prima, ai processi produttivi, alla manutenzione, all’amministrazione o alle analisi di laboratorio. La struttura del cementificio viene progettata dallo studio ingegneristico Roncati e Cantoni, mentre lo studio di progettazione della Von Roll disegna l’impianto tecnico e i macchinari.
La fabbrica è andata a insediarsi in una piana che si apre lungo il fiume, circondata dalle montagne che formano le gole della Breggia. Prima era una zona di mulini: mulini per la macinazione dei cereali, ma anche opifici idraulici per la produzione artigianale del cemento. Questa zona offriva infatti sia la forza dell’acqua che serviva ad alimentare i mantici dei forni e le macine delle pietre, sia la materia prima necessaria alla produzione del cemento: il biancone (maiolica) e la marna (scaglia).
Poco più a valle rispetto al sedime della Saceba, si trovavano due cementifici preindustriali, uno dei quali (l’ex cementificio Zariatti e eredi Belloni, prima Monti e Peverelli) è ancora conservato e dopo aver ospitato la fabbrica di eliche di Philip Rolla, oggi è abitato dallo studio CCRZ.
Come funzionava la Saceba?
Per prima cosa era necessario estrarre la materia prima. Fino agli inizi degli anni Settanta l’estrazione avveniva a cielo aperto, poi si sono iniziati a scavare dei cunicoli all’interno della montagna. In circa 6 anni sono stati scavati circa 5 km di gallerie sotterranee: un dedalo buio e abitato da pipistrelli, oggi visitabile con le guide della Fondazione.
Il materiale estratto veniva portato al frantoio, dove avveniva la prima macinatura che lo riduceva alla grandezza di un pugno. Da qui veniva trasferito sul nastro trasportatore che attraversava il fiume Breggia e lo depositava nel grande capannone. Da qui le pietre venivano poi prelevate tramite i carroponti e portate nei mulini, che le riducevano in farina cruda.
A questo punto si avviava il processo di omogeneizzazione, che consisteva nella miscelazione dei vari ingredienti: maiolica (biancone) 86%, scaglia (marna) 12% e pirite 2%. Questo processo veniva supervisionato grazie a un pannello di controllo perché per avere un prodotto sempre uguale era importante rispettare un dosaggio costante. Le varie farine venivano mescolate nei silos; per il loro spostamento si usava l’aria compressa. I percorsi verticali avvenivano anche tramite degli elevatori a tazze verticali, protetti all’interno di tubi a sezione quadrata.
Come si può ben intuire, nonostante le farine fossero mosse all’interno dei tubi, c’era una forte circolazione di polvere e per poter lavorare in un contesto salubre era fondamentale prevedere un sistema di filtri. Ancora oggi la torre dei forni ospita un macchinario composto da una serie di cilindri di tessuto elettrostatico i quali, muovendosi, permettevano di filtrare l’aria e purificarla dal pulviscolo. La polvere catturata veniva comunque riutilizzata, quindi convogliata in un tubo e immessa in un apposito silos.
La miscela precedentemente omogeneizzata poteva ora entrare nei forni, assieme al carbone per la combustione. Oggi è rimasto in loco solo uno dei due forni verticali originari. Si tratta di un grande cilindro in acciaio rivestito internamente di mattoni refrattari, che occupa tre piani della torre. Grazie all’immissione di aria compressa le temperature raggiungevano i 900 gradi, necessari per modificare la composizione chimica della miscela.
I due forni verticali hanno però avuto una vita breve: già nel 1967, solo quattro anni dopo la loro messa in funzione, sono stati sostituiti da un più potente forno rotante orizzontale (alimentato a nafta), in grado di raggiungere i 1’450 gradi e di produrre da solo 450 tonnellate di clinker al giorno (contro le 300 t dei due forni verticali).
La Saceba ha svolto il processo fin qui descritto fino al 1981. Poi, a causa delle polveri e delle esplosioni che mettevano in pericolo le abitazioni di Castel San Pietro, l’attività estrattiva viene interrotta e di conseguenza i forni spenti. Il potente forno orizzontale viene smantellato e trasportato in Italia.
Continua però la seconda parte della produzione del cemento: la molatura del clinker, che ora viene importato dall’Italia (quindi la macinazione con l’aggiunta di gesso) e l’imballaggio nei sacchi. A questo punto il cemento era pronto per proseguire il suo percorso nei cantieri, dove veniva miscelato con acqua, sabbia e inerti per diventare calcestruzzo.
Dalla Holcim alla Fondazione Parco delle Gole della Breggia
Dall’inizio della sua attività al 1983, la Saceba era una SA di proprietà prevalentemente locale. Poi la ditta EG Portland inizia un percorso di acquisizione e quando nel 2000 quest’ultima viene inglobata dalla Holcim, anche la Saceba entra di conseguenza sotto il suo controllo.
La produzione cessa definitivamente nel 2003 e la fabbrica viene chiusa. La Holcim decide di donare il sedime dell’ex cementificio alla Fondazione Parco delle Gole della Breggia, contribuendo anche al risanamento dell’area. Il 90% delle costruzioni del comparto vengono demolite, ma il team di progettisti decide di mantenere il frantoio, una parte del capannone di deposito e la torre dei forni, che viene risanata e resa accessibile per delle manifestazioni.
Dal 2012 quindi la Fondazione Parco delle Gole della Breggia gestisce il passato, il presente e il futuro di questa affascinante realtà.
Area ex SACEBA tra i 32 progetti premiati per Constructive Alps
Attualità culturale 31.03.2015, 19:05
Contenuto audio
Fonti e bibliografia:
Ringraziamo Peter Flückiger, per le sue preziose informazioni sul percorso del cemento, e la Fondazione Parco delle Gole della Breggia. Oltre ai documentari e ai servizi disponibili negli archivi della RSI, citiamo:
Il cementificio nel parco – Storia della Saceba e della riqualifica territoriale realizzata dopo la sua chiusura, a cura di Giovanni Buzzi e Paola Pronini Medici, Casagrande, 2012.