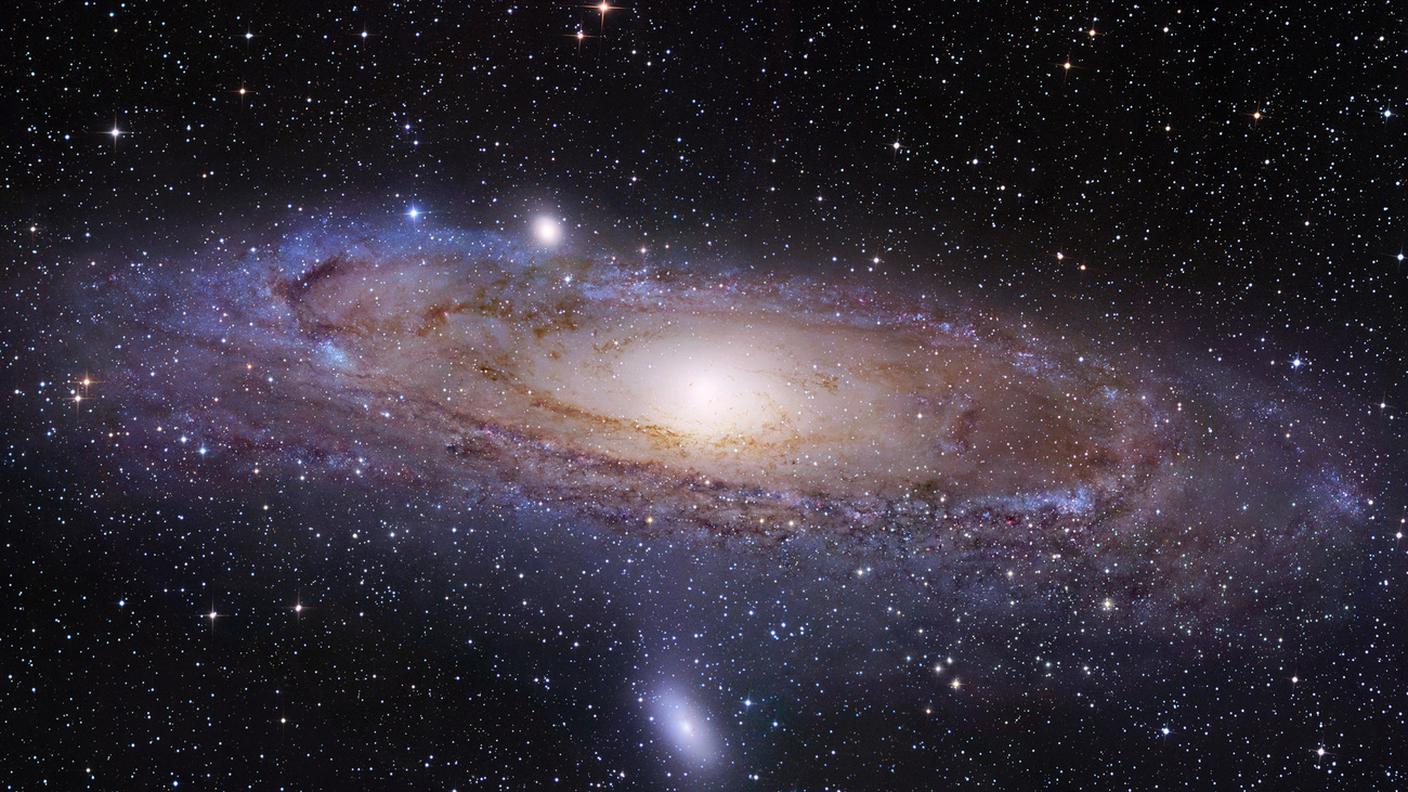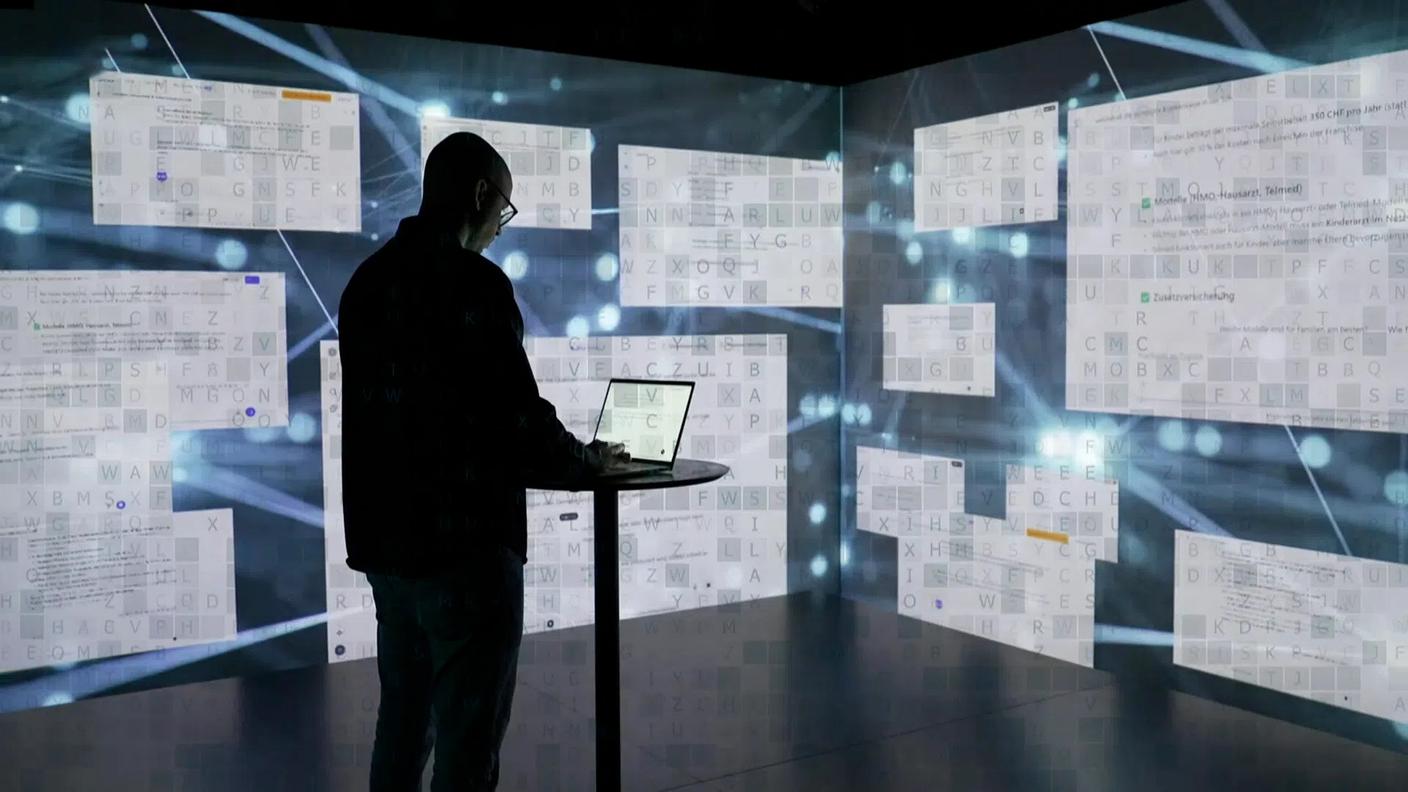I fuochi d’artificio sono un argomento un po’ divisivo. Alcuni ne amano la magia, altri ne odiano il rumore, soprattutto chi è più vicino agli animali. Il primo d’agosto, con i tradizionali spettacoli pirotecnici in tutta Svizzera, torna puntuale il dibattito, ma se c’è una cosa sulla quale non si discute, questa è la scienza che ci sta dietro.
I fuochi d’artificio sono un fantastico connubio tra fisica e chimica. Ciascun colpo può essere diviso in due problemi scientifici diversi. Il primo consiste nel portare in quota la carica esplosiva, il secondo nel farla deflagrare e generare gli scintillanti colori e i maestosi suoni che conosciamo.
Gemelli di fuoco
Storie 05.03.2023, 20:40
Contrariamente a quello che pensano in molti, i fuochi d’artificio degli spettacoli pirotecnici non sono dei razzi, ovvero non sono dotati di una spinta propulsiva costante dovuta alla combustione di una sostanza. Si tratta, invece, di mortai, come dei cannoni: una prima carica esplode dentro un cilindro e lancia verso l’alto una sfera, che costituisce il fuoco d’artificio vero e proprio. Questo proiettile contiene una miccia temporizzata, una seconda carica esplosiva e delle piccole sfere, dette stelle, responsabili dei colori. La miccia temporizzata, più propriamente chiamata spoletta, è calibrata per far deflagrare la carica alla quota desiderata. L’esplosione della carica incendia le stelle e le proietta verso l’esterno. Queste sono composte da sostanze quali tipicamente sali o metalli e, con il calore, danno luogo a reazioni chimiche che producono i vari effetti. Così, ad esempio, stelle contenenti stronzio produrranno luce rossa, bario il verde e rame il blu. Si possono aggiungere sostanze come il titanio per formare le scie, oppure altri composti che danno luogo a fischi o altri effetti sonori.
Un’invenzione arrivata dalla Cina
I fuochi d’artificio sono stati, tra il Diciottesimo e Diciannovesimo, tra le prime applicazioni della scienza teorica moderna alla tecnica e all’innovazione, anche se la loro comparsa è molto antecedente a questo periodo. La scoperta della polvere da sparo è avvenuta in Cina tra il 700 e il 900 circa, ma la sua diffusione, per fini sia militari che di intrattenimento, risale alla dinastia Song (960–1279). In questo periodo si producevano soprattutto razzi luminosi, petardi e altri effetti molto diversi rispetto a quelli che conosciamo oggi.
Fuochi d'artificio del primo d'agosto 2022: cosa ne pensano i cittadini?
RSI Info 29.07.2022, 12:00
La tecnologia è arrivata lentamente in Europa e, nel corso del Diciottesimo secolo, ha preso grande slancio grazie a una famiglia italiana, i Ruggieri. I cinque fratelli Ruggieri (Antonio, Francesco, Gaetano, Petronio e Pietro) sono emigrati a Parigi da Bologna nel 1743 e si sono rapidamente affermati nella capitale francese come punto di riferimento per i giochi pirotecnici, che al tempo erano principalmente elementi scenici del teatro della commedia italiana. Gradualmente i Ruggieri hanno conquistato sempre più successo di pubblico e si loro fuochi sono diventati degli spettacoli a sé. Gli eventi erano molto teatrali, ricchi di riferimenti alla mitologia e costituiti soprattutto da macchine che muovevano le fiamme. I Ruggieri dovevano la propria fortuna al monopolio della tecnica per la realizzazione degli elementi pirotecnici, custodita gelosamente all’interno della famiglia.
Sì o no al divieto per i privati dei fuochi d’artificio e dei petardi in Svizzera?
Controcorrente 09.01.2025, 11:50
Contenuto audio
Nello stesso periodo in cui la famiglia Ruggieri metteva in scena i propri spettacoli, la chimica moderna cominciava ad affermarsi, soprattutto grazie allo scienziato francese Antoine Lavoisier. Uno dei membri della famiglia, Pietro Ruggieri, ha capito in fretta che bisognava includere la scienza moderna all’interno della fabbricazione dei fuochi d’artificio per renderli ancora più spettacolari. Ha cominciato quindi a collaborare con Antoine Lavoisier nel 1766 e i due sono riusciti a produrre dei fuochi colorati, senza però raggiungere risultati convincenti. L’idea di incorporare le nuove scoperte nella pirotecnica ha impiegato ancora qualche anno per dare i suoi frutti, passando per dei momenti molto duri. È stato infatti a causa di un disastro che i fuochi d’artificio hanno assunto la forma, e soprattutto i colori, che hanno oggi.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/natura-e-animali/Quei-botti-nemici-degli-animali--2385673.html
Nel 1770, il futuro re Luigi XVI la regina Maria Antonietta hanno ingaggiato la famiglia Ruggieri per uno spettacolo pirotecnico alle proprie nozze, ma l’evento è stato segnato da un drammatico incidente. Alcune cariche esplosive sono deflagrate vicino alla folla, che si è confusamente data alla fuga. Nella calca sono rimaste uccise oltre 130 persone. La città di Parigi ha così tagliato il budget annuale dedicato ai fuochi d’artificio da diverse centinaia di migliaia lire a meno di duemila lire, rendendo pressoché impossibile l’attività economica della famiglia.
A questo punto, nel mezzo di una crisi, la scienza, unita all’ingegno, ha risollevato le sorti della famiglia Ruggieri e ha cambiato la storia della pirotecnica. Un altro membro della famiglia Ruggieri, Claude-Fortune, ha ripreso con determinazione lo sviluppo di fuochi colorati e brillanti facendo leva sulla sua passione per la chimica. Verso la fine del secolo, Claude Ruggieri è riuscito finalmente a produrre dei fuochi colorati simili a quelli che conosciamo oggi, aggiungendo metalli e sali. La storia riporta che la prima comparsa in uno spettacolo pubblico è stata quella del colore verde per le nozze di Napoleone Bonaparte con Maria Luisa nel 1810.
Rappresentazione dei fuochi d'artificio della famiglia Ruggieri per le celbrazioni del 15 agosto 1806 a Parigi. Dipinto attribuito a Francesco Piranesi
Claude Ruggieri ha condensato le proprie conoscenze in un trattato pubblicato nel 1801 divenuto leggendario nel campo della pirotecnica, l’Elémens De Pyrotechnie (elementi di pirotecnica). Il testo è dedicato, non a caso, a Jean-Antoine Chaptal, chimico autore di Elémens De Chemie (elementi di chimica) e ministro di Napoleone. Nella prefazione, Claude Ruggieri, considerabile il padre della pirotecnica moderna, decreta l’unione tra fisica e chimica:
L’arte dei fuochi d’artificio non è, di per sé, che un lavoro meccanico, che richiede soltanto la conoscenza di alcune materie usate nei fuochi, dei loro nomi e dei loro usi, secondo la composizione che si desidera realizzare. Ma per meritare il nome di artista in questo campo, bisogna innanzitutto essere fisico, per prevedere, senza dover ricorrere a prove, gli effetti di un’operazione qualunque; meccanico, per la costruzione perfetta di un pezzo che si è appena immaginato e che si vuole realizzare senza ostacoli; disegnatore e un po’ architetto, perché il pirotecnico che concepisce un’opera è l’unico in grado di accordare tutti gli effetti del fuoco con le regole dell’architettura, e perché è assai difficile che qualcun altro possa tracciare un progetto a partire dall’idea altrui.
La conoscenza della chimica è, sopra ogni cosa, assolutamente necessaria, poiché serve a combinare con sicurezza le materie impiegate nelle composizioni dei fuochi. Occorre conoscerne l’affinità, le proprietà e il valore, per poter operare in sicurezza e con la massima economia possibile.
Claude-Fortune Ruggieri, Elémens de pyrotechnie