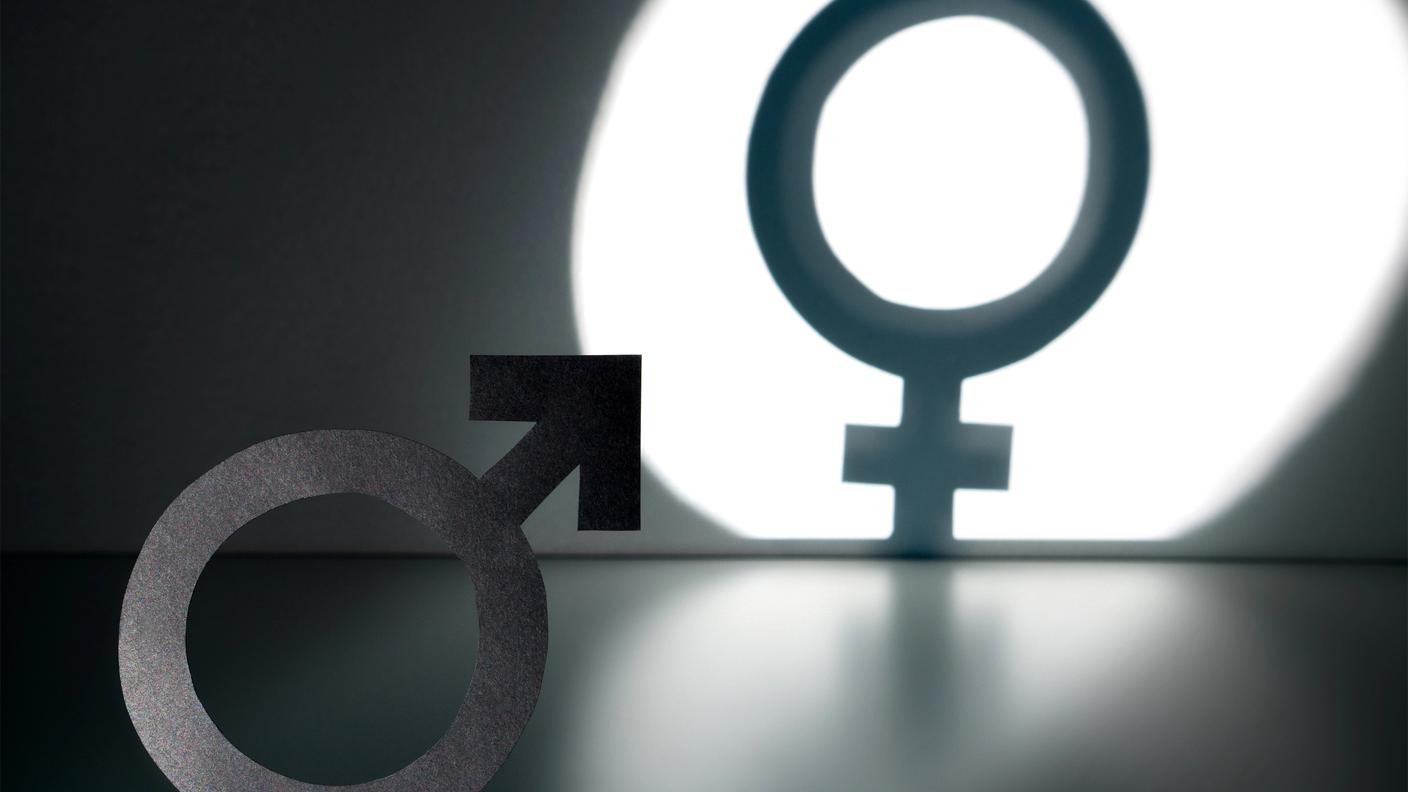Il Tribunale federale, la nostra Corte suprema, compie 150 anni; un’istituzione che ha contributo a fare la storia della Svizzera (e che in occasione di questa ricorrenza fra l’altro aprirà le sue porte al pubblico a settembre).
Le sentenze storiche
A tutti sarà capitato di aver sentito o letto un riferimento al Tribunale federale a Losanna, a Mon Repos. Espressioni, queste e altre ancora, che evocano decisioni definitive su temi come, ad esempio, circolazione stradale, licenze edilizie, espulsioni.... Dalla massima istanza del terzo potere statale sono uscite sentenze storiche, si pensi a quella del 1990 in cui venne sancito il diritto di voto alle donne nella Landsgemeinde ad Appenzello Interno o quella che diede la spallata definitiva (a livello di giurisprudenza) agli “accordi cartellari”, il caso riguardava i prezzi concordati con e fra i produttori di birra, era il 1986.
Le critiche a composizione e funzionamento
Oggi, tenendo conto dell’integrazione dell’ex Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna, si contano 40 giudici e oltre 370 dipendenti, che trattano circa 8’000 casi all’anno. Una storia di successo, scritta con e dallo stesso Tribunale federale; una storia però non esente da critiche che riguardano sia la sua composizione sia il suo funzionamento. Anche per il Tribunale federale l’elezione dei giudici avviene secondo quote partitiche: senza partito (a cui si paga una tassa di mandato) non si entra. Un sistema criticato dal Consiglio d’Europa (andammo a votare sull’estrazione a sorte dei giudici nel 2021 ma l’iniziativa fu bocciata a larghissima maggioranza). Alcuni partiti (nel passato recente l’UDC ma più indietro nel tempo non solo) hanno interagito in maniera controversa e insofferente con i propri togati d’area (anche se indirettamente); ed è successo - l’ultima volta con la causa “anziane per il clima” - che la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sconfessasse Losanna.
Come è cresciuto in questi 150 anni il Tribunale federale e come sta
“Il Tribunale federale si è sviluppato bene dalla prima infanzia, nell’Ottocento, poi è cresciuto, interpretando e sviluppando la Costituzione svizzera fino alla grande revisione di fine ‘900. Dunque è stato il Tribunale federale che negli anni ha anche elaborato e specificato anche i diritti fondamentali”, spiega ai microfoni di SEIDISERA della RSI l’esperto Michele Luminati, professore di storia e teoria del diritto e direttore dell’Istituto di ricerca sulla giustizia all’Università di Lucerna.
“Il sovraccarico? L’alternativa è aumentare l’organico”
Il Tribunale federale, dunque, ha avuto un ruolo sempre più importante per lo sviluppo del diritto. Molto riconosciuto anche a livello internazionale, sottolinea il professore. Oggi c’è il tema del sovraccarico, della grande massa di ricorsi. “Diciamo che li smaltisce abbastanza bene - dice Luminati -. Uno dei temi che il Tribunale stesso ha posto negli ultimi anni è quello di limitare l’accesso. Questo da un lato è comprensibile, però dall’altra parte è anche giusto che si possano porre a questo Tribunale anche questioni che altrimenti rimarrebbero ferme alle sentenze dei tribunali cantonali. L’alternativa è aumentare l’organico”.
Il Tribunale e la giurisprudenza che cambia
È però anche capitato che il Tribunale federale tornasse sui suoi passi. Alcune decisioni vengono prese a maggioranza dai giudici. E succede anche che la Corte europea dei diritti dell’uomo la pensi diversamente.. Su questi punti il professore pone un distinguo. “È chiaro che la giurisprudenza di un tribunale cambia. Abbiamo il concetto che deve avere una certa costanza, anche perché deve dare una certa garanzia., però è chiaro che il Tribunale cambia anche la sua giurisprudenza, perché cambia la società. Molto cautamente. Non è che si fa da un giorno all’altro”.
Il rapporto con le Corti europee
Altra cosa è il rapporto con le Corti europee eccetera, spiega Luminati. “Negli ultimi decenni abbiamo avuto un incremento di diritto internazionale, dunque anche un maggiore peso di queste Corti. Ed è fisiologico che Strasburgo non sia sempre d’accordo con Losanna, però questo rapporto non è soltanto unilaterale. Il Tribunale federale, cosciente anche di quello che succede a livello europeo, in qualche modo lo recepisce nelle sue sentenze. In più anche ciò che fa il Tribunale federale svizzero viene recepito, in un certo senso, anche a livello internazionale. Dunque questo è uno scambio. Per quanto riguarda il modo in cui decide, c’è sempre il discorso della maggioranza. Ci sono purtroppo sempre meno udienze pubbliche quando la Corte non riesce a trovare una soluzione. In quei casi, cosa rarissima, quasi unica al mondo, si può assistere a questo dibattito pubblico tra i giudici quando non riescono a trovare un consenso. Questo è un fenomeno molto particolare del concetto democratico della giustizia che purtroppo negli anni viene usato sempre meno, perché ci si accorda per via scritta”.
Gli attacchi della politica ai giudici
A criticare il Tribunale federale c’è l’UDC che, a intervalli più o meno regolari, parla di sentenze di parte. Rapporti controversi con la politica ci sono stati anche con altri partiti in passato. Oggi sempre più persone si chiedono se la composizione del Tribunale per quote, con tanto di pagamento della cosiddetta tassa di mandato ai partiti, rappresenti un rischio per l’indipendenza del potere giudiziario. Il professor Luminati ritiene che questo costituisca un rischio nel momento in cui c’è una polarizzazione politica tale che dei partiti tentino di influenzare l’attività dei giudici.
“Storicamente - agli albori di questo Tribunale supremo - avevamo giudici che erano quasi tutti dei politici a livello nazionale (erano anche giuristi ovviamente, che entravano in Tribunale). Questo poi è cambiato e siamo passati dalla figura del “giudice politico” a giudici membri di partiti (presupposto per l’elezione) ma non a politici attivi. Man mano c’è stato un distacco rispetto a quella che era la colorazione politica del Tribunale federale. Purtroppo negli ultimi vent’anni, più o meno, assistiamo a un incremento della pressione sui giudici da parte di alcuni partiti Pressioni che poi si manifestano chiaramente al momento delle elezioni o della rielezione, soprattutto del o della giudice. Questo diventa un problema; il fatto di essere sotto pressione rispetto a sentenze fatte da un Tribunale che non fanno piacere a una forza politica. Questo mette in questione anche il sistema di elezione che abbiamo”.
“La prima Istituzione statale che viene attaccata è la Giustizia, la più debole”
Il dibattito politico è sempre più polarizzato. Dunque c’è anche chi si chiede se si arriverà al punto di una rottura dell’equilibrio tra potere giudiziario (in questo caso il Tribunale federale) e la politica. “Abbiamo esperienze in altri Paesi dove la prima Istituzione statale che viene attaccata o messa in crisi è la giustizia, la più debole. Se le altre due non la rispettano, la giustizia non ha la forza, ha bisogno degli altri due poteri. Sicuramente dovremmo rivedere il tema della rielezione. Io sarei più per un’elezione di lunga durata ma limitata, come si fa anche per i Tribunali europei. Dodici anni senza rielezione. Questo permetterebbe un ricambio maggiore anche all’interno del Tribunale. Adesso è di 4 anni ma un giudice è rieleggibile fino alla pensione. Il sorteggio non mi è sembrato all’epoca la soluzione giusta ma è indubbio che dovremo rivedere il modo in cui eleggiamo i giudici federali”, conclude il professor Luminati.