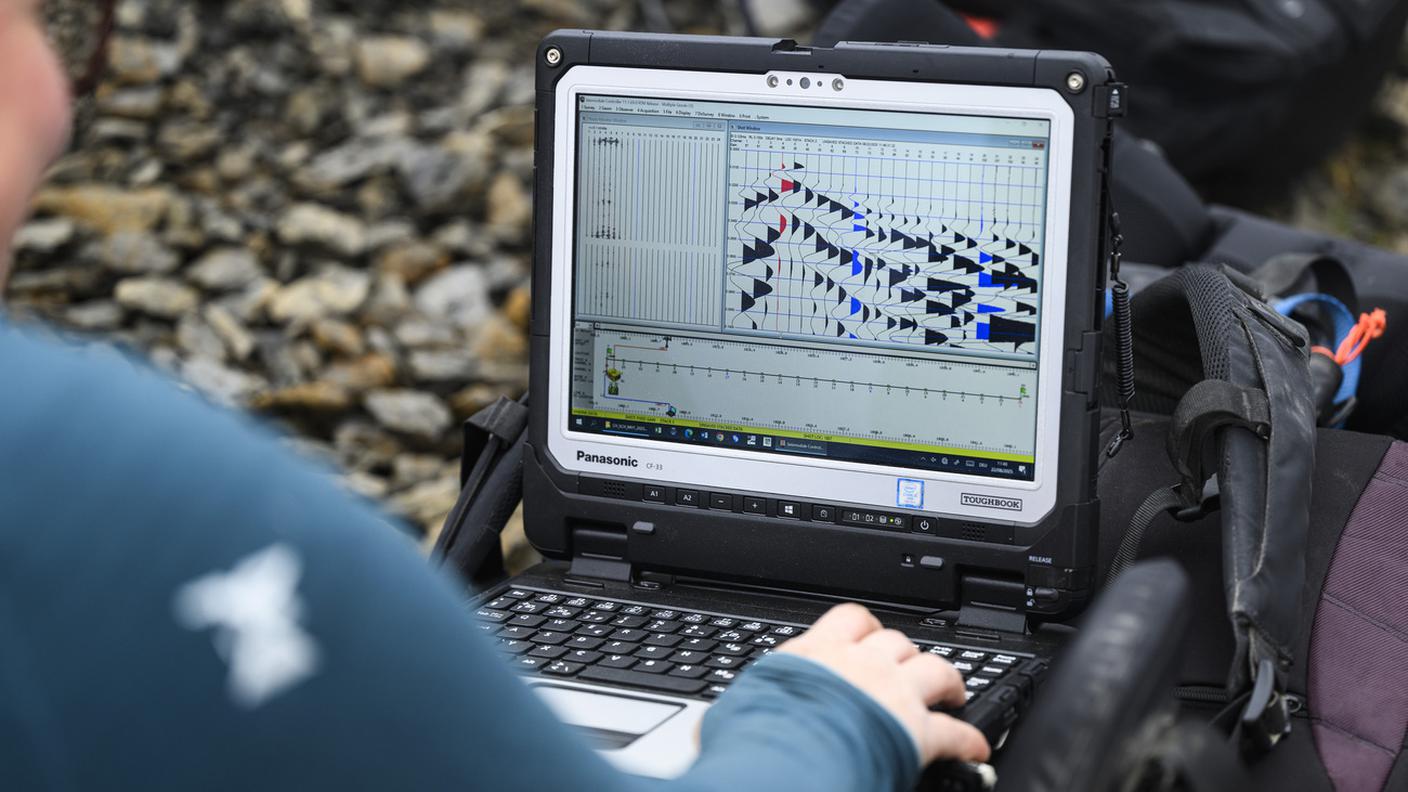Svizzera-Unione europea, sono molte le novità previste dai nuovi accordi che verranno discussi prossimamente in Parlamento. La ripresa dinamica del diritto europeo è uno degli aspetti più tecnici, ma anche più delicati.
Il principio è che quando l’Unione europea cambia una sua legge direttamente legata a uno degli accordi bilaterali, anche la Svizzera adeguerà le sue leggi. C’è di mezzo quindi la sovranità. I negoziatori svizzeri hanno ottenuto che la ripresa non sarà automatica, bensì dinamica: in pratica la Svizzera potrà rifiutare la modifica, ma dovrà accettare delle contromisure.
In questa intervista alla RSI il professore di diritto costituzionale all’università di Zurigo Andreas Glaser spiega le ripercussioni di questo vincolo, partendo dalla rilevanza: “A prima vista sono aspetti piuttosto tecnici, complicati. Ma politicamente secondo me sono gli elementi più importanti dell’intero pacchetto”.
Perché?
“Innanzitutto perché il recepimento dinamico del diritto europeo sarà un cambiamento fondamentale della procedura legislativa per il Parlamento, ma anche per il popolo che vota in Svizzera”.
Concretamente si sta parlando di alcune modifiche che possono essere decise a Bruxelles e poi entrano in una maniera che il Consiglio federale dice non automatica ma dinamica nel diritto svizzero. Cioè si può sempre dire di no…
“Sì, esatto, c’è questa contraddizione. Naturalmente si può sempre violare un contratto. Perché è di questo che stiamo parlando, se la Svizzera non dovesse accettare una novità del diritto europeo”.
Il consigliere federale Ignazio Cassis però afferma che la Svizzera può dire no, deve semplicemente accettare contromisure (non sanzioni), per riequilibrare le dinamiche sul mercato interno.
“Su questo i nuovi accordi sono chiari: il senso è che la Svizzera accetti tutte le riforme europee, non può dire di no. Poi però l’Unione europea ha riconosciuto indirettamente, accettando queste contromisure, che c’è il pericolo che la Svizzera (governo, parlamento o popolo) possa dire puntualmente di no”.
La ripresa dinamica non è una novità assoluta, c’è ad esempio nell’accordo Schengen tra Svizzera e Unione europea. Perché ora dovrebbe essere più problematico?
“Vero, per l’area Schengen abbiamo già questo sistema, ma adesso parliamo di aree di diritto molto più larghe. Innanzitutto la libera circolazione delle persone. Perciò sono convinto che sia arrivato il momento di regolare più in dettaglio questa procedura”.
Quali dettagli si dovrebbero regolare meglio?
“È necessario una specie di sistema d’allarme, in modo che già molto presto durante la procedura di recepimento il Parlamento e il popolo svizzero abbiano possibilità di intervenire e dire che c’è un problema, se una puntuale riforma europea non dovesse piacere.”
Quindi intravede il rischio che una novità in arrivo da Bruxelles passi inosservata e non ci sia più il tempo per prendere una contromisura, o per chiedere un’eccezione all’Unione europea?
“Sì, esatto. Perché dire di no presto è più semplice che di no in una fase avanzata. È più facile arginare un problema se si segnala subito la sua esistenza all’Unione Europea”.
Ma non è un po’ ipocrita essere così pignoli con l’Unione europea, mentre vediamo che nei rapporti di forza internazionali (Stati Uniti, Cina, …) già adesso bisogna piegarsi a decisioni prese altrove…
“Sì, certo, se confrontiamo la situazione coi fatti imposti con la forza nelle relazioni con altri paesi, la relazione con l’Unione europea è su un piano completamente diverso. Ma con l’UE secondo me è giusto essere corretti, abbiamo una relazione basata su valori democratici e dello stato di diritto. È un po’ un problema di lusso, se vuole, ma nelle relazioni con Bruxelles è giusto avere questa aspettativa”.
Un aspetto rilevante è: si potrà tornare indietro? In altre parole, quanto sarà possibile testare questo modello per dieci anni e poi eventualmente dire no, non ci piace, vogliamo tornare alla situazione precedente.
“Tornare indietro diventa sempre più difficile. Ma non è impossibile, come ha dimostrato la Brexit. Quindi si potrà sempre disdire gli accordi bilaterali, ma dopo 10 o 20 anni sarà più complicato”.