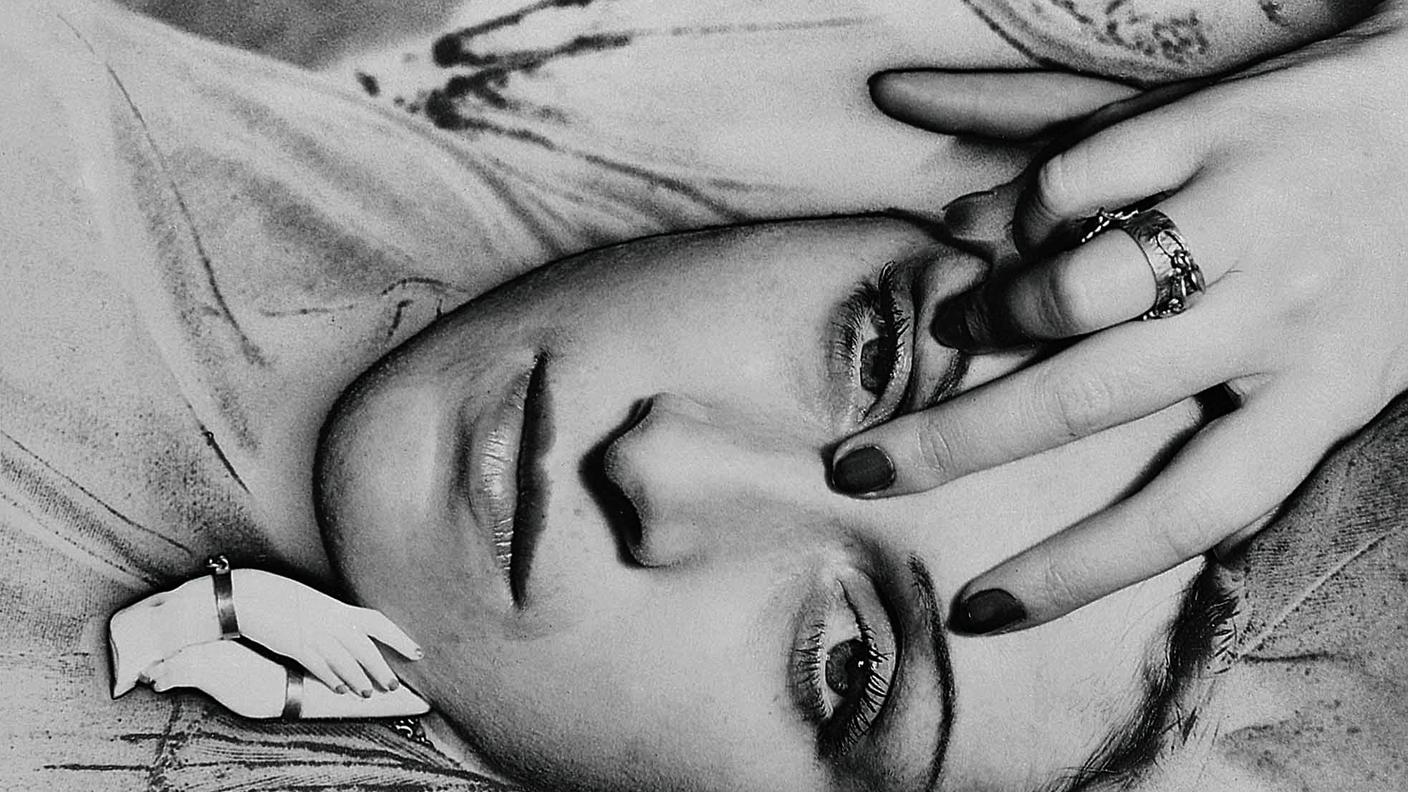Al LAC è in programma, fino a sabato, il Dittico della bufera. In questa nuova produzione Carmelo Rifici torna ad indagare due testi cecoviani che hanno segnato le tappe fondanti del suo percorso registico: Tre sorelle e Il gabbiano. Scritti a distanza di sei anni l’uno dall’altro, sono permeati di un legame viscerale, quasi si trattasse di fratelli: se Il gabbiano è il testo giovane, delle intuizioni, Tre sorelle è la più matura evoluzione.
Nell’ottobre del 1895 Anton Čechov scriveva all’amico Suvorin: «Pensate un po’: scrivo un lavoro teatrale! Scrivo con piacere, andando contro le convenzioni teatrali in modo terribile. È una commedia con tre ruoli femminili, sei ruoli maschili, quattro atti, un paesaggio (vista su un lago), numerose discussioni letterarie, poca azione e cinque pud di amore». Parlava de Il gabbiano, un dramma che sosterrà, con rammarico, aver iniziato forte e terminato pianissimo, lui che non si considerava un drammaturgo.
Già, perché Čechov era prima uno scrittore di racconti, brevi, intensi, scritti rapidamente e inizialmente più per necessità pecuniaria che per amore. Čechov era un medico instancabile, le sue origini povere, la grande famiglia (era il terzo di sei figli) che manteneva, il suo rapporto con le ingiustizie, l’amore per le persone semplici e la compassione hanno da sempre caratterizzato il suo scrivere. Ma era un incredibile artista, che è riuscito con le sue opere a dar voce alle speranze naufragate, alle difficoltà di un tempo in declino, alle intime passioni, a raccontare davvero la gente di provincia.
Nel mestiere letterario, come in quello di medico, Anton privilegiava la diagnosi e non la terapia, l’esposizione, la comprensione del problema, e non la soluzione. Per Čechov lo scrittore doveva fornire un quadro della realtà del personaggio, della vicenda che si raccontava. Non c’erano soluzioni, prediche, messaggi: «Credo che i romanzieri non debbano risolvere problemi quali Dio, il pessimismo, ecc. Compito del romanziere è quello di come e in quali circostanze le persone hanno meditato su Dio o sul pessimismo. L’artista non deve essere il giudice dei suoi personaggi e di quanto essi dicono ma solo un testimone imparziale… ai giurati, ossia ai lettori, la valutazione».
Questo non piaceva a tutti e infatti tra le molte critiche che gli venivano mosse c’era quella dell’assenza di obiettività e moralità. I suoi spettacoli non avevano il successo dei racconti, e soprattutto non raccoglievano consensi. Ivanov venne messo in scena nel 1887 ma a causa della faciloneria degli attori fu un disastro e dopo due repliche venne tolto dal cartellone. Anche quando presentò Lo spirito della foresta, che sarà il materiale per la base di Zio Vanja, un attore in voga all’epoca, Lenskij, gli dirà: «Scrivete piuttosto racconti. Avete un eccessivo disprezzo per la scena e la forma drammatica, le stimate troppo poco per scrivere un lavoro teatrale».
Čechov non si dava però per vinto e appunto sette anni dopo e soprattutto dopo aver scritto racconti del calibro di La corsia n. 6 e Il monaco nero, dopo aver viaggiato per l’Europa, visto Venezia, aver descritto le condizioni precarie dei prigionieri di Sachalin, aiutato come medico nelle carestie, incontrato e stretto amicizia con Tolstoj, eccolo che ci riprovava con Il gabbiano.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Anton-Cechov--1782504.html
Il gabbiano è un dramma quasi senza trama. Abbiamo una madre attrice superficiale, possessiva con il proprio figlio Konstantin, che è un aspirante scrittore sensibile e inquieto. Poi c’è l’amante di lei, Trigorin, che scrive e di successo ne ha parecchio ma è piuttosto volgare e presuntuoso. Tra i possidenti in vacanza che gravitano attorno a questo micromondo c’è Nina, aspirante attrice, della quale Konstantin è innamorato. Lei però non sceglie l’amore ma la gloria, fuggendo con Trigorin, che all’attrice anziana preferisce la giovane… Insomma, un incastro irrisolvibile se non che il sogno di successo di Nina fallisce, viene abbandonata dal vanitoso Trigorin, torna alla tenuta e dice a Konstantin che all’amore preferisce la vita randagia di attrice di terz’ordine. Tutto ciò avrà le conseguenze disastrose che chi conosce la pièce ben sa, ma che qui non sveliamo. Certo è che il monologo finale di Nina è indimenticabile.
Il problema per Čechov è però che, data la sua ormai acquisita notorietà in campo letterario, gli viene affidato un cast d’eccezione, e il 17 ottobre, serata della prima a San Pietroburgo, i mostri sacri della scena desacralizzeranno Il gabbiano. Una pièce che richiedeva attenzione, sobrietà e semplicità, che andava in primis capita dagli attori, che però la reciteranno enfatizzando declami, e di fatto uccidendola. «Vivessi ancora settecento anni non scriverò mai più per il teatro», dirà l’autore, amareggiato soprattutto dalle reazioni di pubblico e amici e dichiarando di non volerne mai più sentir parlare, e che nessuno ne scrivesse.
Accade però il contrario, perché un giovanissimo regista, Konstantin Sergeevič Stanislavskij, e il nuovo direttore del Teatro di Mosca chiederanno a Anton di rimettere in scena Il gabbiano per la prima stagione del Teatro. Lo avevano letto, lo avevano capito, e assicuravano all’autore la massima cura. Čechov, che nel frattempo iniziava a subire le conseguenze della tubercolosi e per questo si era ritirato a Melichovo in riva al mare, passò qualche giorno a Mosca a vedere le prove de Il gabbiano. Rimase colpito dall’impegno del regista (!) e soprattutto ammaliato, tra tutti i bravissimi attori, proprio da una di queste, Ol’ga Knipper (nel ruolo dell’Arkadina). Questa volta la messa in scena fu un trionfo, sia per il testo, sia per la nuova messa in scena rigorosa di Stanislavskij, e il pubblico in delirio. Nel frattempo l’attrice e lo scrittore si avvicinavano e scattava l’amore. Olga lavorava per il teatro di Mosca, quindi non poteva stare molto con Anton, che però, sulla scia di questo amore, iniziò a scrivere Le tre sorelle, con una parte tutta per lei, quella di Maša. È il 1900.
Le tre sorelle sono Olga, Maša e Irina Prozorov, tre donne colte e sensibili che vivono in una città di provincia russa, lamentando la monotonia della loro esistenza e il sogno irrealizzabile di tornare alla vita raffinata e entusiasmante di Mosca. Sono figlie di un generale deceduto l’anno in corso: Maša è moglie di Kulygin, un professore di ginnasio che ha sposato troppo giovane e che quindi, guarda un po’, non ama; Olga è la maggiore e insegna in un liceo femminile; e infine la piccola Irina, desiderosa di emanciparsi a Mosca. Sono circondate da ufficiali che fanno spesso visita in brigata (e che scombussolano alcuni cuori, tra feste di carnevale e digressioni politiche) e dal fratello Andrej, che, sposato con la meschina Natasha, soffre per la sua incapacità di raggiungere il riconoscimento sociale e il lustro intellettuale. Attraverso le vicende delle sorelle l’opera riflette sul tema della disillusione, della vacuità della società borghese e dell’incapacità umana di realizzare i propri desideri. In generale i personaggi sono intrappolati nell’attesa vana di un futuro migliore, sogno irraggiungibile che si scontra con la realtà quotidiana.
Il Teatro di Mosca lo metterà in scena, sempre con la regia di Stanislavskij. Dall’estero, dove è ripartito per inquietudine, scriverà spesso a Olga per darle consigli di recitazione che passeranno alla storia, come: «Non fare in nessun atto il viso rattristato. Stizzito sì, ma non rattristato. La gente che da tempo porta in sé una pena, e vi si è abituata, fischietta soltanto e rimane sovrappensiero. Così anche tu, resta di frequente sovrappensiero sulla scena mentre gli altri discorrono». La prima, il 31 gennaio del 1901, è ancora una volta un grandissimo successo.
Il mese di maggio dello stesso anno Čechov sposerà Olga, due anni dopo scriverà il suo ultimo spettacolo Il giardino dei ciliegi e nel 1904, purtroppo, stremato dal suo male, morirà.
Quel che colpisce del suo teatro è la vicinanza con la realtà. Čechov sembra accompagnarci attraverso i suoi personaggi, i salotti, i giardini di provincia, le vicende amorose, le disillusioni, proprio in quella Russia di fine Ottocento che tutti ci immaginiamo. Siamo lì con i suoi personaggi, ad attendere, a discorrere del niente, ad amare e sperare. Il mondo sta andando in rovina, e noi guardiamo con loro quel che accade, senza poterlo fermare.
Confidò così a un amico a proposito del suo teatro un giorno: «Il pubblico vuole che ci siano l’eroe, l’eroina, i grandi effetti scenici. Ma nella vita ben raramente ci si spara, ci si impicca, si fanno dichiarazioni d’amore. E ben raramente si dicono cose intelligenti. Per lo più si mangia, si beve, si bighellona, si dicono sciocchezze. Ecco cosa bisogna far vedere in scena. E non perché questo sia necessario all’autore ma perché così avviene nella vita reale».
In questa realtà, c’è chi accetta di vedere lo squallore di una vita che si sta sbriciolando, e chi invece cerca con l’intelletto, la personalità, l’arroganza di uscirne. La speranza è sempre verso un futuro che sembra irraggiungibile e irrealizzabile e che non permette mai, purtroppo, ai suoi personaggi di agire e di vivere il cambiamento nel momento reale.
Kappa
Kappa 30.09.2025, 17:00
Contenuto audio