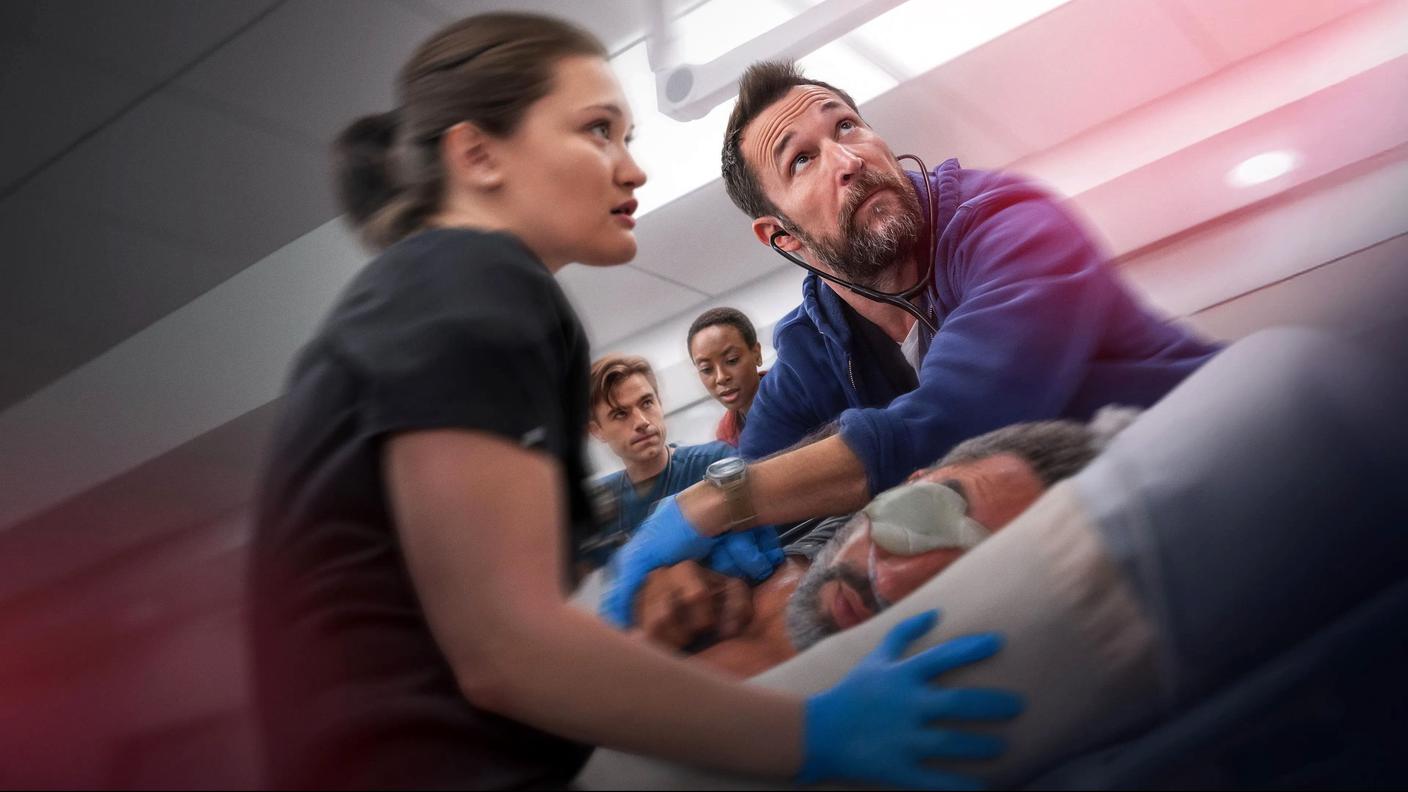Dal romanzo di Charles Dickens al film di David Lean, Great Expectations ha attraversato la storia della cultura inglese, ed è anche un titolo perfetto per raccontare il cinema britannico del secondo dopoguerra. Oltre al già citato David Lean, saranno presenti nella retrospettiva del Locarno film festival di quest’anno registi come Michael Powell (con e senza il socio storico Emeric Pressburger), Terence Fisher, Robert Hamer, Lance Comfort, che si passeranno il testimone nel narrare le “grandi speranze” del cinema e della società inglese in quegli anni cruciali tra Cinquanta e Sessanta.
La retrospettiva è curata, come lo scorso anno, dal critico, regista e co-direttore de Il Cinema Ritrovato a Bologna, Ehsan Khoshbakht. Great expectations si concentra su un cinema nazionale ingiustamente trascurato dalla critica, che ha fatto dell’autocritica impietosa il pilastro dell’idea stessa di ricostruzione. Come sottolinea lo stesso Khoshbakht, «Ogni singolo film del programma è ambientato tra il 1945 e il 1960, quindi niente salti nel futuro o nel passato, niente film fantastici, niente horror. Volevo studiare la vita delle persone in Gran Bretagna in quel periodo e come i film rappresentino la loro realtà quotidiana. Questo era l’obiettivo alla base della selezione. Ecco perché i film di guerra non sono presenti, perché riguardano il paesaggio del dopoguerra. Ecco perché i grandi film horror non sono presenti: i film fantastici possono ancora dirci molto sulla psiche di una nazione, ma questo non faceva parte della storia che volevo raccontare».
Alessandro Chiara: Nell’introduzione del libro che accompagnerà la retrospettiva, lei afferma che per il pubblico internazionale il cinema britannico del dopoguerra è ancora un cinema nazionale in gran parte inesplorato. Come lo spiega? Perché pensa che sia così trascurato?
Ehsan Khoshbakht: Il cinema britannico del dopoguerra, purtroppo, non è conosciuto quanto meriterebbe, per varie ragioni. Alcune sono di natura “industriale”: questi film, in lingua inglese, venivano sempre paragonati ai film hollywoodiani e perdevano la partita contro di loro, in termini di distribuzione: i film hollywoodiani erano più conosciuti in altri paesi europei, e non era così comune per i film britannici ottenere una distribuzione. L’altro fattore è che, purtroppo, i critici britannici erano poco generosi con certe tendenze del cinema britannico, soprattutto con il cinema di genere. I film britannici più notevoli del periodo, come Brighton rock, sono stati stroncati dai principali critici dell’epoca, perché li consideravano realizzati con “cattivo gusto”, qualunque cosa questo significhi.
Questo complesso di inferiorità culturale non ha certo giovato alla causa dei film britannici, nonostante l’accoglienza positiva per pellicole come Amleto di Laurence Olivier, che ha vinto l’Oscar. Alcuni film venivano però proiettati in alcuni dei migliori cinema delle città europee. A Parigi, per esempio, c’era una sala che proiettava il meglio delle commedie degli Ealing studios e i nuovi film britannici. Il punto di fondo, però, è che la valutazione critica del cinema britannico si rifà sempre a ciò che François Truffaut ha detto nella celebre intervista insieme ad Alfred Hitchcock: che le parole “britannico” e “cinema” sono incompatibili. Il che è ovviamente una totale assurdità.
Non riesco a pensare a un altro sistema di studi cinematografici, al di fuori di Italia e Francia, così vivace, così impegnato in diversi tipi di film, così in sintonia con i gusti popolari, così innovativo in termini di stile, come il sistema britannico. Probabilmente la gente, o persino i critici, non conoscevano il cinema britannico quanto avrebbero potuto, e uno degli obiettivi principali di questa retrospettiva è proprio quello di mostrare alcuni dei film meno visti del periodo, e di inserirli nel giusto contesto.

The Astonished Heart di Terence Fisher
Un ruolo importante è stato svolto anche dai registi statunitensi, a causa di McCarthy e della lotta anticomunista...
Credo che una delle principali differenze tra il cinema britannico e il cinema italiano, o francese, sia che si tende a dimenticare quanti stranieri, quanti esuli, quanti talenti internazionali siano stati coinvolti nell’industria cinematografica britannica, fin dagli anni ‘30. Va ricordato che uno dei produttori più influenti del cinema britannico fu Alexander Korda, un ebreo ungherese che si trasferì in Gran Bretagna e iniziò a produrre film. Molti europei, e quando dico europei, intendo principalmente europei centro-orientali, fuggirono dai nazisti negli anni ‘30 o durante la guerra e si unirono all’industria cinematografica britannica.
Abbiamo anche il fenomeno dei registi americani che, costretti a trovare lavoro fuori Hollywood o in un atto di autoesilio, finirono in Gran Bretagna e vi diressero i loro film. Registi in liste di proscrizione e che hanno realizzato alcuni dei film più “britannici” di sempre. Joseph Losey è il primo nome che viene in mente: quando si pensa a Losey, si pensa alla dissezione del sistema di classe in Gran Bretagna. E lui è americano.
Vorrei soffermarmi sul ruolo delle donne nel cinema britannico. Aveva qualcosa a che fare con la guerra, che ovviamente portava gli uomini a combattere? Quale prospettiva particolare hanno portato le donne nel cinema britannico del dopoguerra?
Le donne avevano una presenza molto forte nel cinema britannico del dopoguerra. Non dimentichiamo che questo è il Paese delle suffragette. Durante la guerra, quando gli uomini erano lontani e le donne entrarono nelle fabbriche, nel mondo del lavoro e in politica, cominciarono a porsi una domanda fondamentale e logica: se possiamo fare tutto questo, perché non possiamo fare film? Dopo la guerra emerse una nuova generazione di registe - sia nel documentario che nella fiction - tutte voci chiave del cinema britannico. Muriel Box è forse la più nota di quella generazione: ha prodotto e diretto film, scritto sceneggiature... Una serie di film straordinari, commedie e drammi. Aveva un tocco molto leggero, ed era famosa soprattutto per le commedie che diresse negli anni ‘50.
C’erano molte altre persone, sia dietro che davanti alla macchina da presa, ad esempio alcune sceneggiatrici. Questo è ovviamente in linea con quello che stava succedendo altrove in Europa perché, sai, si assiste anche all’emergere di registe in Spagna, in Francia e in altre parti del mondo. Ma credo che il movimento britannico fosse più unito; qualcuno ha scritto che Muriel Box ha avuto molta influenza, non solo come regista. E alcune di queste figure erano anche entrate nella politica progressista. C’è un film in programma intitolato “Essere donna”. Quel film riassume in un certo senso l’intera idea del ruolo delle donne nella Gran Bretagna del tempo di guerra e del dopoguerra, ed è come un appello per la totale integrazione delle donne nei ruoli sociali e per il loro coinvolgimento in tutto, raccontato ovviamente attraverso il linguaggio del cinema.

I know Where I'm Going di Powell e Pressburger
A dare lo spunto per questa retrospettiva è stato un film: A diary for Timothy, “Un diario per Timothy”...
A diary for Timothy di Humphrey Jennings è uno degli ultimi grandi documentari di guerra che in un certo senso si pone una domanda leggermente diversa. Se i documentari precedenti parlavano di come combattere la guerra, il film, girato negli ultimi mesi del conflitto, si chiede cosa succederà dopo. Cosa succede se vinciamo la guerra? E questo bambino nato nel 1945… che tipo di futuro lo attende? Il film guarda già oltre le atrocità e, anche se la guerra non era ancora del tutto finita quando il film è stato girato, evita di mostrarne qualsiasi immagine.
Ho pensato che questo fosse un ottimo punto di partenza per una retrospettiva, che potesse in un certo senso indagare il destino di questo neonato. Cosa gli succede un anno dopo? Cosa gli succede 10 anni dopo? Cosa gli succede quando è un adolescente o un giovane uomo? Quindi è l’indagine sul futuro di qualcuno nato subito dopo la guerra. Per Timothy e il futuro di quella generazione, credo che la prima grande domanda sia l’idea di ricostruzione del paese, perché tutto è in rovina. La spina dorsale del paese è a pezzi e deve essere ricostruita: non solo le città e gli edifici, ma l’intera cultura, il tessuto sociale, i rapporti di classe, l’idea di istruzione, l’idea di salute pubblica, tutto deve essere ricostruito.
Questo processo porta alla creazione e alla costruzione di un nuovo tipo di Gran Bretagna. Per quanto riguarda il processo di ricostruzione… è molto teso, niente è così semplice. Questi film non promettono al pubblico un futuro luminoso. Al contrario mostrano quanto sia difficile, offrendo a volte persino una sorta di prospettiva cupa su questa lotta per il cambiamento e il rinnovamento. Per questo motivo, credo che il cinema britannico dell’epoca sia anche uno dei cinema nazionali più autocritici mai esistiti in Europa.
Cos’è questa autocritica?
Quando guardi i film britannici del dopoguerra, è sorprendente quanto siano autocritici in molti modi diversi. Ad esempio, la critica alla cultura consumistica: all’improvviso, l’idea delle tessere annonarie e del vivere razionato è finita e ora, o attraverso il mercato nero o attraverso la rinascita di una sorta di società capitalista, i britannici possono mettere le mani su qualsiasi cosa vogliano. Ma il tipo di competizione che il capitalismo crea e i suoi lati più oscuri finiscono per tradire le aspettative di chi inseguiva questa sorta di visione da sogno di un futuro diverso dal tempo di guerra. Ancora una volta, alcuni di loro finiscono per morire tra le stesse rovine lasciate dalla guerra.
Per questo vedi la persistenza, l’idea dell’esistenza delle rovine della guerra come motivo visivo nei film britannici. È come un tormentone, una sorta di promemoria continuo. I ricordi, l’impatto della guerra sono ancora presenti. In un certo senso, è come se i personaggi dei film britannici di quel periodo reagissero alla guerra, ancora alla fine degli anni ’50. In questo senso, molti film britannici realizzati in questo periodo storico criticano diversi aspetti della guerra e dell’esperienza del dopoguerra, persino l’eroismo, l’idea di eroismo e di chi sia un eroe. C’è per esempio un film intitolato They made me a fugitive - il titolo è molto eloquente, “Mi hanno reso un fuggitivo” – in cui chi ha reso questo paese un posto migliore in cui vivere, liberandolo dal fascismo, finisce per essere costretto a lavorare nel mercato nero.

I'm All Right, Jack di John Boulting
C’è anche una prospettiva positiva? Che guarda al futuro invece di cercare di affrontare il passato?
Essere autocritici è di per sé qualcosa di estremamente positivo, secondo me, perché non si può andare avanti senza mettere in discussione il proprio passato e il proprio presente. Solo così si è effettivamente sulla strada della ricostruzione. Credo, comunque, sia una caratteristica di quel momento culturale o storico. Se vogliamo però cercare aspetti più positivi dell’esperienza del dopoguerra, credo che l’esplosione della grande tradizione delle commedie britanniche negli anni ‘40 e ‘50 sia un buon esempio.
Non intendo dire che le commedie britanniche siano meno critiche nei confronti del sistema culturale, ma possono farlo in modo meraviglioso, avendo lo stesso mordente di un film noir e di un film poliziesco, ma facendo allo stesso tempo ridere il pubblico. Pongono la stessa domanda, ma in un modo molto esilarante, un tratto molto speciale e molto specifico dell’esperienza del dopoguerra nel cinema britannico.
È sempre difficile restringere la scelta a pochi titoli da consigliare, ma possiamo sceglierne tre che riassumano davvero il senso della retrospettiva?
Prima di rispondere a questa domanda, volevo mandare un messaggio ai cittadini svizzeri.... Dunque, questa è una retrospettiva di 45 film, molti dei quali in 35 millimetri. Ora, credo che Locarno sia l’unico Festival del cinema contemporaneo al mondo che presenta così tanti film classici e ospita retrospettive così estese. È qualcosa di davvero unico. Non succede mai. Ovunque e quando succede, non è sempre su pellicola; quindi, è importante essere consapevoli dell’unicità di questa situazione e di quanto sia fondamentale preservarla, perché sta diventando sempre più difficile proiettare film su pellicola, ma anche accedere al patrimonio cinematografico. Avere un pubblico così attento come quello locale è fondamentale per un programma così vasto e completo come Great expectations.
Per rispondere alla domanda, direi che la maggior parte dei film in programma fa parte di un unico disegno. Quindi avrebbe senso vederli uno dopo l’altro, e sono stati pensati così, giorno per giorno. In modo che il pubblico, guardando quotidianamente i film in programmazione, intraprenda un viaggio ben preciso: sul tema dell’infanzia, sul rinnovamento urbano, sulla ricostruzione delle città e su tante altre cose.
Ma se dovessi indicare un film molto importante per me - e penso che anche il pubblico lo troverebbe interessante perché è l’unico film in programma al di fuori della Gran Bretagna, in Svizzera - è The passionate friends di David Lean. Dopo l’enorme successo di Brief encounter, Lean ha voluto fare un film su una storia d’amore condannata in partenza. È un film molto sottile, pieno di emozioni molto intense. Credo che in pochi l’abbiano visto – è anche uno dei motivi per cui lo stiamo proiettando.
Un altro film in un programma che in un certo senso spiega la fine degli anni ‘50, i dilemmi e le tensioni di quel periodo, i sindacati, gli scioperi, la grande ascesa del capitalismo è una meravigliosa commedia intitolata I’m alright, Jack di John Boulting. Parla di un uomo dell’alta borghesia, che vuole lavorare in una fabbrica che appartiene a un membro della famiglia, ma si ritrova in un certo senso diviso tra i sindacalisti, guidati da un Peter Sellers in uno dei suoi ruoli migliori degli anni ‘50, e la proprietà della fabbrica. Un film molto pungente, che non fa sconti a nessuno, a prescindere dal gruppo sociale o politico a cui appartengono.
Ma credo che il mio preferito in assoluto sia un film di Carol Reed intitolato Odd Man Out: parla di un membro dell’IRA (l’Irish Republican Army), che è stato ferito, sanguina ed è in fuga dalla legge in una Belfast innevata. Con lui, la sua ragazza. Il film racconta le osservazioni e gli incontri di un uomo morente. È così toccante, così barocco, così ricco di dettagli, ed è forse uno dei più grandi film mai realizzati, in qualche modo non apprezzato quanto meriterebbe, ed è un film che, più di qualsiasi altro film britannico degli anni ‘40 e ‘50, ci racconta di quel senso di ansia, di fatalismo che non ci si aspetta dagli inglesi, ma che è presente in molti film. Quell’angoscia esistenziale che provano i personaggi e che forse è uno specchio della loro epoca. E grazie alla retrospettiva possiamo fare un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso questi 45 film, per vedere come vivevano le persone, come sopravvivevano e come superavano le difficoltà.

Tutto pronto a Locarno per il Festival
Il Quotidiano 05.08.2025, 19:00