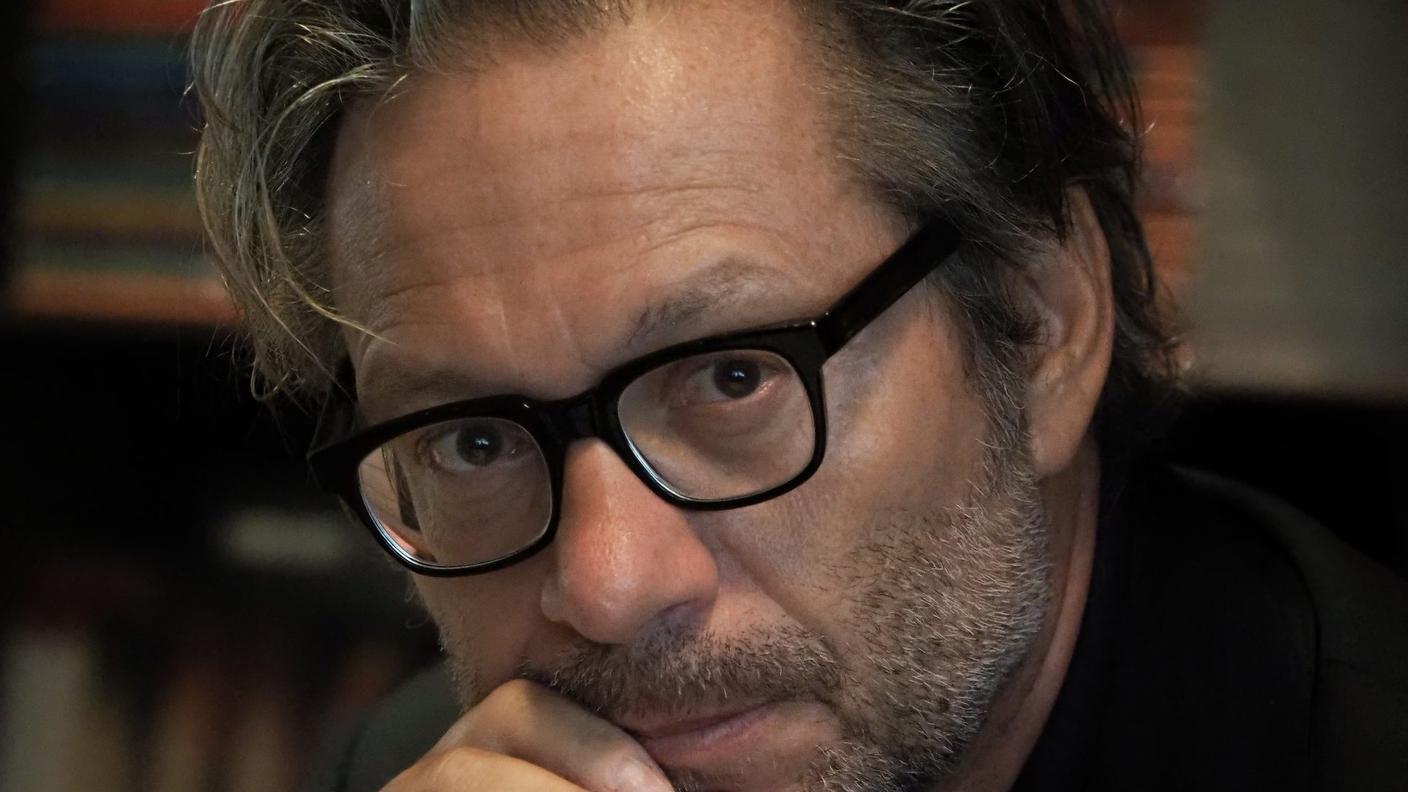Di fronte a un sistema culturale che spesso premia l’omologazione, Alba Donati ha scelto una strada diversa. Poetessa, scrittrice, ex responsabile della comunicazione di una grande casa editrice, oggi è nota soprattutto per aver fondato una piccola ma celebre libreria, Sopra la Penna, nel minuscolo borgo di Lucignana, in Garfagnana. Un luogo che è diventato un caso editoriale e sociale, e il fulcro di un progetto culturale ampio e coerente.
Come è nata l’idea della libreria? È stata una scelta o una necessità?
«Mi ci sono trovata, ma nello stesso tempo desideravo trovarmici. Le due cose sono coincise. Volevo fare qualcosa per il mio paese, ero stanca della città e delle relazioni superficiali. Sentivo il bisogno di tornare a casa, era un desiderio profondo. Poi un giorno, per caso, vedo la parola “crowdfunding” su Facebook. Non sapevo nemmeno cosa fosse, ma scrissi subito un post: volevo che il mio paese avesse una libreria, che i bambini crescessero con il libro come abitudine, non come eccezione. È nato tutto così».
Nel suo bestseller La libreria sulla collina (Einaudi) scrive: «Abbiamo aspettato troppo per essere ciò che desideriamo”. Quanto è importante ascoltare i propri desideri?
«Credo molto. Quando siamo bambini, verso i dieci anni, sappiamo chi siamo. Poi la scuola, il lavoro, la vita adulta ci livellano. Io, da piccola, inventavo storie. Ho vissuto una vita fatta di ostacoli, ho conosciuto anche persone negative, ma poi ho incontrato chi mi ha rimesso sulla buona strada. Molti passano trent’anni a fare altro, lontani da ciò che volevano essere. A un certo punto, bisogna chiedersi: quanto sono distante da quella bambina che ero? Io ho voluto recuperarla».
Scrive anche di esperienze dolorose. Riesce a farlo sapendo che i familiari leggono i suoi libri?
«Sì, assolutamente. Ho letto i miei scritti a mia madre pochi giorni prima che morisse, a 103 anni. Anche a mio padre, nonostante un fallimento di cui non parlavamo. Quando gliel’ho letto, aveva gli occhi lucidi. Credo abbia apprezzato. Non ho nulla da nascondere. È più complesso scrivere di persone vive, fuori dal nucleo familiare, ma nella mia famiglia ho sempre sentito libertà».
Cita spesso la scrittrice Pia Pera. Che legame c’era tra voi?
«Ci siamo conosciute, ma non frequentate. Eppure ha fatto ciò che poi ho fatto anch’io: ha lasciato la città, l’editoria, ed è tornata alla campagna, alla sua casa in Lucchesia. La sento come una capofila. Ha rivoluzionato il modo di pensare il giardinaggio, con uno spirito anarchico e libero. Il suo libro Al giardino ancora non l’ho detto è una delle cose più belle che abbia letto».
Che rapporto ha con la fede?
«Non ho fede nel senso classico. Non mi interessa sapere dove andremo dopo. Ma adoro le persone che incarnano la spiritualità, come Padre Bernardo di San Miniato o Papa Francesco. Condivido il loro sguardo sul mondo. Non sono agnostica: mi pongo il problema della fede. E se lo fai, è già un segno di appartenenza. In fondo, cristianesimo e comunismo – quello umano, non ideologico – mi hanno sempre attratto per gli stessi motivi: la giustizia, l’aiuto reciproco, la solidarietà».
Come ha vissuto sua figlia il cambiamento radicale della sua vita?
«Credo ne sia felice. Certo, ci manchiamo, ma ci vediamo spesso. Abbiamo venduto la casa grande e ne abbiamo presa una più piccola, ma con giardino, per il suo cane. Soprattutto, lei capisce che sto seguendo la mia strada. E questo per me è essenziale».
Com’è nato il festival Little Lucy?
«Come tutto, di notte. Mi sveglio e le idee arrivano. Little Lucy nasce da Little Italy e da Lucignana, che è esposta alla luce tutto il giorno. È un’idea nata insieme a mio marito, Pierpaolo Orlando. È un festival “piccolo”, perché piccolo è ciò che amo: ciò che non invade, che non rovina. Ma è anche un paradosso, perché qui sono venuti ospiti come Folco Terzani o Alberto Manguel. Il festival chiude ogni anno con un cammino spirituale all’eremo di Sant’Anzano. L’obiettivo è portare cultura in un territorio spesso dimenticato, coinvolgere bambini, famiglie, lettori. È il nostro modo per riscattare un pezzo d’Italia che ha dato tanto, anche attraverso l’emigrazione, e che merita di essere al centro della scena».
I Paesi invisibili
Voi che sapete... 15.04.2025, 16:00
Contenuto audio