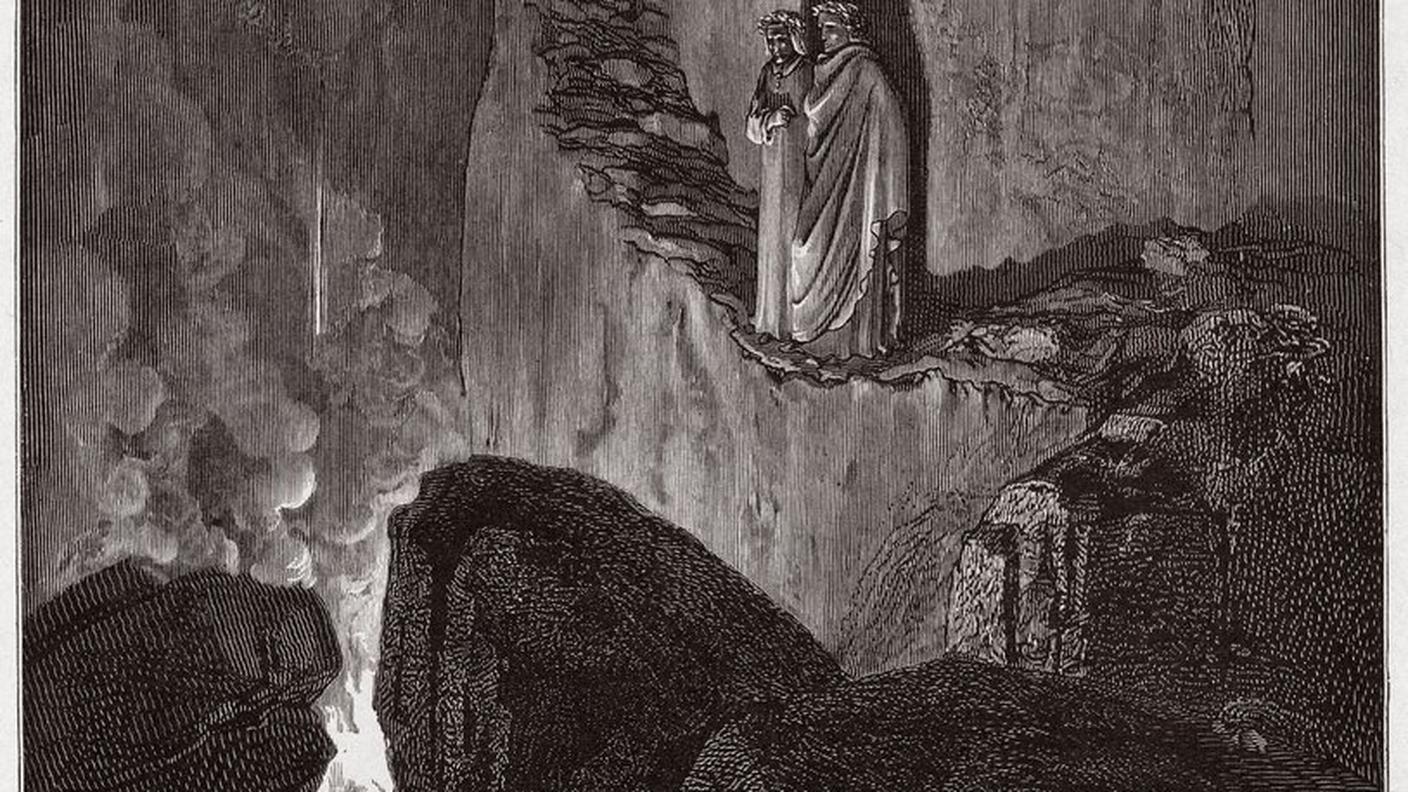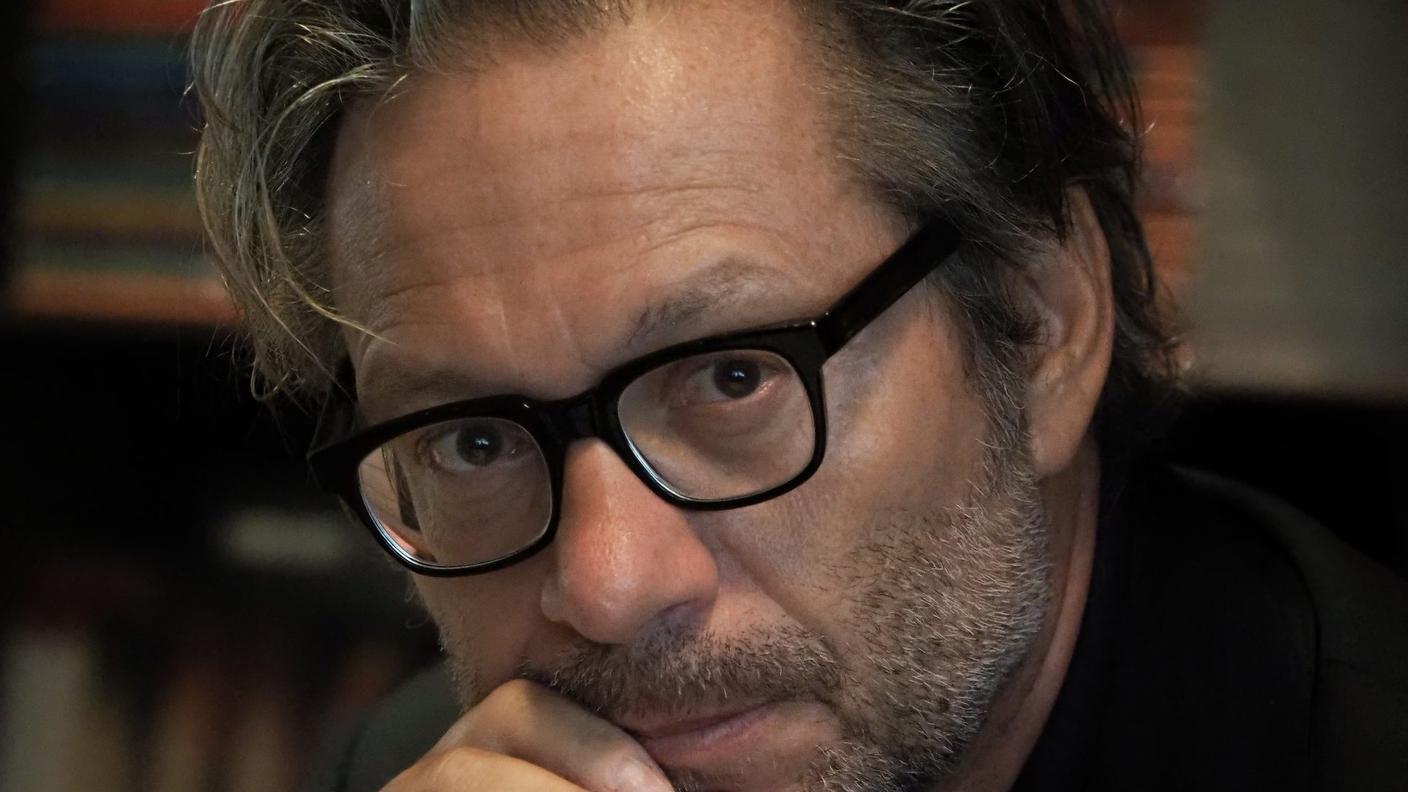Oggi ci crogioliamo nell’illusione rassicurante di vivere in un’epoca in cui tutto è stato ormai spiegato e compreso dal pensiero secolare: la scienza sembra aver svelato i meccanismi della natura e la filosofia aver scandagliato i grandi interrogativi dell’esistenza. Eppure, molto resta ancora oscuro. Ironicamente, è proprio la nostra ignoranza a impedirci di comprendere quanto poco conosciamo davvero. Il confine tra sogno e reale, tra percezione soggettiva e verità assoluta, è molto più labile di quanto ammettiamo.
Il sogno della farfalla: una favola antica
Nel Zhuangzi, un testo taoista attribuito a Zhuang Zhou (IV sec. a.C.), il tema della realtà soggettiva emerge attraverso una semplice storia.
Un giorno Zhuang Zhou sognò di essere una farfalla:
svolazzava felice, ignara di essere Zhuang Zhou.
Si sentiva libera, spensierata, pienamente farfalla.
Poi si svegliò e si ritrovò ad essere Zhuang Zhou.
Ma non sapeva più se era Zhuang Zhou che aveva sognato di essere una farfalla,
o una farfalla che ora sognava di essere Zhuang Zhou
In poche righe, Zhuang Zhou mette in questione la distinzione tra sogno e veglia, tra esperienza soggettiva e realtà oggettiva.
Come possiamo comprendere un’esistenza che percepiamo solo dall’interno, in prima persona, e che invece ci ostiniamo a credere sia una realtà comunicabile, un’esperienza comune e condivisibile? Guardato da questo punto di vista, il sé si rivela essere un concetto debole, incompleto, forse una maschera che cela una realtà ben meno ovvia, da cui sorgono domande.
Chi è davvero, a sperimentare la coscienza? Quanto la mia esperienza dell’esistenza può dirsi simile a quella di un’altra persona — o di una volpe, di un fungo, di un sasso?
Il problema difficile della coscienza
Nella filosofia contemporanea, il tema viene affrontato attraverso il concetto di “problema difficile della coscienza”. Il termine è stato coniato dal filosofo australiano David Chalmers negli anni Novanta.
Chalmers distingue tra il “problema facile della coscienza” – spiegare come il cervello elabora informazioni, attraverso quali circuiti e meccanismi fisiologici – e il “problema difficile della coscienza”, cioè il perché esista uno prospettiva interiore, un punto di vista vivibile solo in soggettiva.
Oggi le neuroscienze possono mostrare, grazie alle scansioni MRI, quali aree del cervello si attivano in un dato momento; ma nessuna immagine potrà mai rivelare che cosa si prova a essere quel cervello, a vivere quel momento.
E dunque questo paradosso ci riporta all’incertezza del “sogno della farfalla” espresso da Zhuang Zhou più di duemila anni fa: come possiamo distinguere con certezza ciò che è reale da ciò che è percepito? Le verità in cui crediamo, quelle che definiscono chi siamo e come agiamo nel mondo, non sono altro che il risultato della nostra percezione soggettiva e limitata. Ma se la realtà è così filtrata, esistono modi per intravedere — almeno per un istante — la trama stessa del reale?
I cinque (o forse trentaquattro) sensi
Tutti noi abbiamo imparato a scuola che siamo dotati di cinque sensi. Questi sensi – vista, tatto, olfatto, udito, gusto – sono i canali attraverso cui interpretiamo il mondo esterno, il nostro modo di “leggere” la realtà. Eppure, la ricerca contemporanea suggerisce che la nostra esperienza sensoriale è molto più ricca e complessa.
La neuroscienziata inglese Tara Swart, nel suo ultimo libro The Signs – The New Science of How to Trust Your Instincts, spiega che la scienza oggi riconosce almeno trentaquattro sensi: non solo quelli classici, ma anche il senso del tempo, della temperatura, dell’equilibrio, della fame, della posizione del corpo nello spazio (la propriocezione) e molti altri. Non è necessario elencarli tutti per capire un punto importante: siamo parte di una realtà ben più complessa e di più difficile lettura rispetto a quanto riconosciamo comunemente. E, ne sono certo, molti altri sensi ancora verrano scoperti negli anni a seguire.
L’autrice prosegue spiegando che la coscienza stessa, fino ad ora tradizionalmente confinata al cervello, potrebbe essere qualcosa di ben più ampio. Sembra infatti che il cervello non produca la coscienza, ma la moduli, come un filtro che trasforma l’infinita complessità della realtà in una versione compatibile con le nostre piccole vite.
Panpsichismo: il ritorno di un concetto antico
Sia in Occidente sia in Oriente, a partire dai tempi più antichi fino ad oggi, è stato riproposto il concetto che ogni essere, animato e no, abbia una coscienza. Non una coscienza come l’essere umano, che trova la sua dimensione essenziale nel pensiero, ma comunque una forma di interiorità, in qualche modo riconducibile a un’energia primordiale e unica, che tutto permea.
Lo stesso concetto era sostenuto dai filosofi dell’Antica Grecia: è il caso di Eraclito (VI-V secolo a.C.), che parla del logos, definendolo «un’intelligenza che pervade l’universo», o di Platone (V-IV secolo a.C.), che nel Timeo concepisce il cosmo come un «essere vivente dotato di anima».
Negli Upanishad (testi filosofici dell’India antica composti tra il IX e il II secolo a.C., massima espressione del pensiero vedico) si parla di una realtà ultima chiamata Brahman - principio assoluto ed eterno, senza né forma né confini. Nel pensiero vedico tutto è riconducibile al Brahman, come descritto in un famoso passaggio:
Come le scintille nascono dal fuoco, così tutti gli esseri provengono da questo Sé.
Brihadāranyaka Upanishad, II.1.20
Nella filosofia moderna questo concetto viene definito con il nome di panpsichismo. Il termine deriva dal greco pan (“tutto”) e psyche (“anima”, “mente”, “soffio vitale”). Questa prospettiva, precedentemente scartata e derisa, sta venendo curiosamente rivalutata da celebri filosofi moderni, in risposta alle più recenti scoperte (e riscoperte) del mondo scientifico.
Che sia il panpsichismo la risposta al “problema difficile della coscienza” per ora nessuno lo può dire con certezza. Cio che è indubbiamente interessante notare è che il tema rimane aperto, e che ciò che oggi molti di noi occidentali di educazione secolare considerano un’illusione – la dimensione ultraterrena o spirituale – continua a essere un’ipotesi assolutamente tutt’altro che da escludere. E se accettiamo l’idea di una dimensione più ampia, dobbiamo per forza accettare anche il fatto forse ancor più misterioso di una coscienza che trascende il corpo fisico, una realtà che molte culture, in ogni epoca storica, hanno considerato ovvia.
L’uomo e il suo rapporto con l’infinito
Le più recenti scoperte scientifiche sembrano dunque confermare (come spesso accade, curiosamente) ciò che da millenni filosofie e religioni di tutto il mondo promettono: la coscienza trascende il corpo fisico.
Sono esistiti ed esistono tutt’ora uomini e donne capaci di accedere a questa dimensione più ampia. L’ipotesi è che tale potenzialità sia dentro ciascuno di noi.
Le ricerche sugli stati non ordinari di coscienza, per esempio condotte sugli effetti delle sostanze psichedeliche, mostrano un dato controintuitivo: durante queste esperienze l’attività cerebrale non aumenta, ma diminuisce. È proprio attraverso questa riduzione, questo “silenzio” del cervello, che intravvediamo la dimensione infinita, attingendo a risposte, intuizioni e immagini a cui non avremmo avuto accesso attraverso i sensi ordinari.
Non sono solo le sostanze psichedeliche, tuttavia, a fornire la reale possibilità di accedere a quegli stati fuori dall’ordinario, ma anche la meditazione, il rilassamento totale e completo, l’abbandono, l’ascolto consapevole, la connessione. E tutte queste sono qualità che possiamo coltivare ogni giorno, in ogni gesto, accompagnati da una guida o semplicemente intrattenendo l’idea di rimanere aperti e curiosi verso le infinite possibilità della vita e il suo modo misterioso di parlarci.
Un’intelligenza oltre la mente
Forse c’è un’intelligenza silenziosa che attraversa ogni cosa. E piano piano sembra che vi ci stiamo riavvicinando. Un’intelligenza che non separa ma unisce, che non si lascia spiegare né a parole né a formule. Vive nel gesto sospeso tra ordine e caos, e per quanto talvolta possa apparire dura, incomprensibile o ingiusta, sembra far parte di noi, come noi facciamo parte di lei.
Gandhi raccontato ai ragazzi
Nella tana del bianconiglio 08.11.2025, 15:45
Contenuto audio