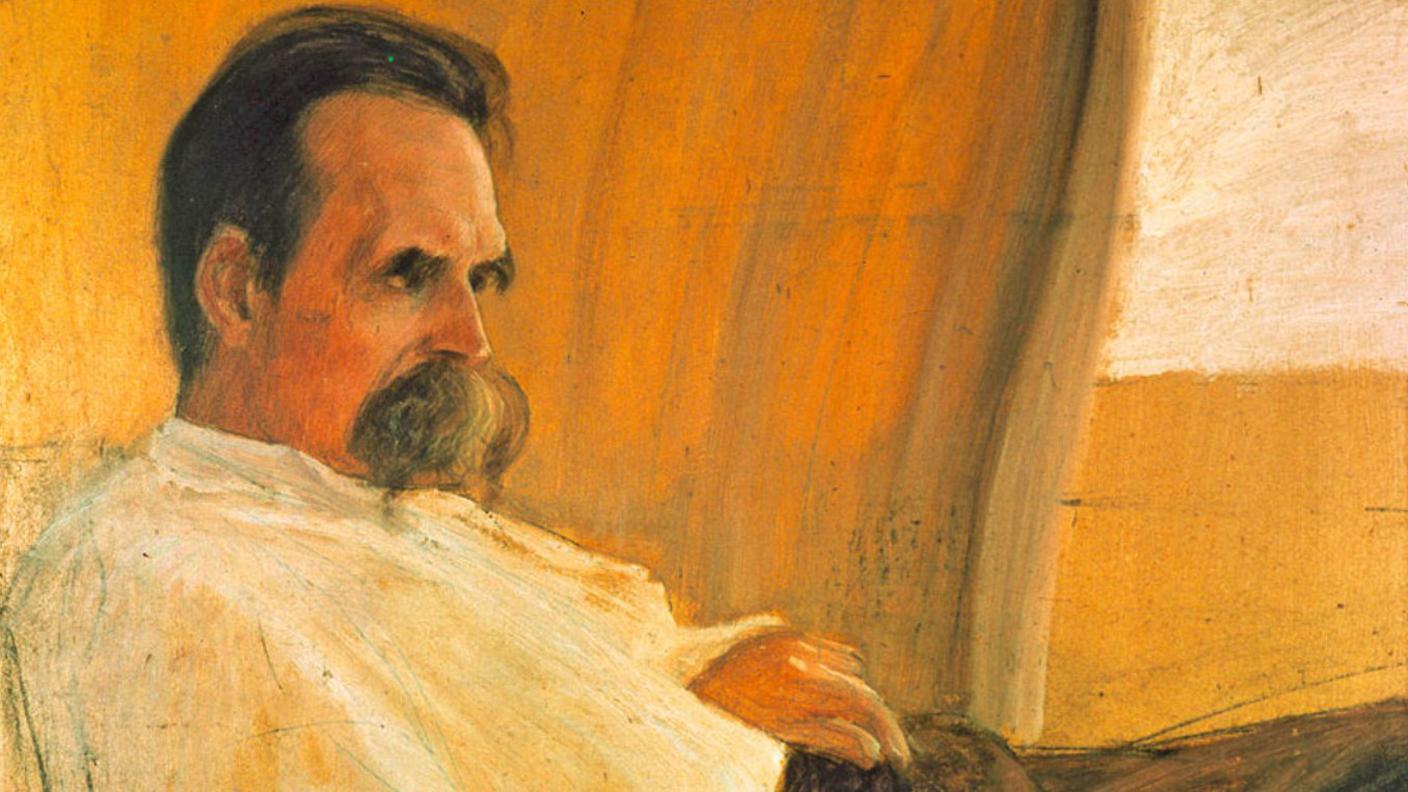In una lunga conversazione di qualche anno fa il Maestro sufi Gabriele Mandel Khan mi disse: «Il sufismo è l’università dell’Islam».
Un’affermazione piuttosto audace, poiché fa del sufismo, la mistica islamica, qualcosa a cui non tutti possono avere accesso (esattamente, diciamo, come accade per l’università). Ma soprattutto un’affermazione che pone la mistica islamica in un rapporto critico con l’Islam maggioritario, perché in qualche modo fa sentire il credente «comune» (quello che segue «solo» i cinque pilastri dell’Islam: dichiarazione dell’unicità di Allah, preghiera quotidiana, pellegrinaggio, elemosina rituale e digiuno a Ramadan) una sorta di credente di livello «inferiore».
Asserire che nella mistica, cioè nelle pratiche spirituali e di studio che caratterizzano un buon sufi, siano «verità» inaccessibili alla pratica convenzionale comporta infatti riconoscere in quest’ultima un limite: il limite che separa, e in una certa misura contrappone, un Islam esteriore da un Islam molto più interiore. O come dicono gli studiosi, il limite che divide l’essoterismo dall’esoterismo.
E cosa divide essoterismo da esoterismo? Cosa separa l’Islam interiore (dei sufi) dall’Islam molto più esteriore della maggioranza dei credenti? Il punto di divergenza fondamentale, che ha spesso determinato questa o quella forma di attrito tra sufismo e Islam «di massa», è proprio in questo discrimine: da una parte il credente «comune» si fa bastare una obbedienza passiva ai dettati coranici e della Sunna, dall’altro il credente «mistico» si concentra in una ricerca attiva di quanto tali dettati trascendono. Insomma, da una parte si trova il popolo «medio» dei credenti, per i quali la dottrina si esaurisce in se stessa, dall’altra si trova il popolo «alto» o «universitario», a cui importa viceversa soprattutto cogliere la sua essenza, spingersi quanto più possibile in prossimità assoluta con l’essenza di Dio (Allah). Al punto da fare affermare a uno dei più controversi sufi della storia, Al Hallaj: «Io sono il Vero, io sono Dio» (Ana al Haqq).
Ora, sarebbe sufficiente questo per spiegare quanto un certo rigorismo formale, un certo letteralismo (come si suol dire) islamico, ovvero un certo modo superficialmente collettivo di intendere l’Islam possa essere stato - e ancora in larga misura sia - disturbato dall’individualismo sufi. Ma in verità il problema del difficile rapporto tra confraternite sufi e istituzioni ufficiali islamiche (con in testa l’università e moschea di Al Azhar del Cairo, vero centro decisionale delle questioni legate all’Islam sunnita), è molto più complesso. Poiché ciò che maggiormente disturba l’Islam istituzionale è la centralità che il singolo individuo (in questo caso il sufi, ma in generale i santi, di solito mal visti dalle istituzioni più ortodosse) assume nel suo rapporto con Dio: una centralità che in qualche modo allontana il credente dalla sua natura di suddito e lo colloca nella insidiosa condizione di scrutatore di Dio (il sufi cerca Dio molto più di quanto il credente comune si limiti ad ascoltarlo o a obbedirgli). Con l’ovvia conseguenza di consegnarlo a quell’«università dello sguardo» che mal si sposa con il significato ultimo della parola «Islam»: Sottomissione.
Insomma, laddove il credente «medio» è tenuto a credere anche senza capire - secondo la massima di Tertulliano, in ambito cristiano, Credo quia absurdum - il credente «alto», il credente sufi, il credente «universitario», oltre che obbedire pretenderebbe di capire. O perlomeno di percepire, di sentire, di «conoscere misticamente» ciò che agli altri si presenta come imperscrutabile.
E oggi questo «dissidio» è ancora molto presente, al punto che i sufi continuano a vivere, a parte qualche confraternita in Turchia e a parte i folkloristici derviches tourners (che si esibiscono più per i turisti che per ragioni mistiche), in uno stato di semi-clandestinità.
L’eresia dei Dervisci
Attualità culturale 15.01.2018, 08:02
Contenuto audio
La natura particolare della pratica spirituale sufi ha dunque dovuto incontrare (e a tutt’oggi incontra, ripetiamolo) mille forme di ostilità e persino di persecuzione. In primo luogo perché è esercitata da comunità «libere» che in qualche misura mettono in pericolo l’idea di una unità inscindibile della comunità dei credenti (riflesso dell’altrettanto inscindibile unicità di Dio). In secondo luogo perché, soprattutto agli occhi del Wahabismo (la religione di Stato saudita) il sufismo fornirebbe una chiave d’accesso paradossale alla trascendenza, in questo modo contraddicendo alla radice la natura totalmente mortale dell’essere umano e del credente. In terzo luogo perché le pratiche rituali sufi sono state viste - in particolare in epoca ottomana, addirittura dal Sultano in persona - come «eretiche» e «di malaugurio»: a partire dal dhikr (la ripetizione ossessiva del nome di Dio) per arrivare al sema (la danza rituale, per esempio dei dervisci).
Nel 1666 molti discepoli del grande Maestro sufi Jalaleddin Rumi (1273) si lasciarono morire perché impossibilitati per anni a praticare le loro danze rituali. Nel XVIII secolo, con l’emergere del Wahabismo, le persecuzioni diventarono all’ordine del giorno: il salafismo (e le costole del Wahabismo che diedero corpo ad Al Qaeda e a Isis) negarono loro la possibilità di convivere in seno all’Islam maggioritario. All’inizio del XX secolo l’Egitto bandì le opere del grande Maestro sufi Ibn Arabi e la Turchia di Atatürk tutti gli ordini e le confraternire che si richiamavano al sufismo, determinando una diaspora in diversi paesi del mondo. (Solo i Naqshbandi, per le loro pratiche riservate a pochi adepti, riuscirono a scampare alle persecuzioni e persistono ancora oggi in Turchia).
La nuova Arabia Saudita
Laser 12.06.2019, 09:00
Contenuto audio
La storia recente non ha mutato granché la situazione. E la domanda che si impone è: per quale ragione una certa rigidità islamica fa tanta fatica ad accogliere le sue voci più alte e ispirate? In parte abbiamo già risposto all’inizio di questo articolo, ma in parte la risposta è altrove.
La risposta è soprattutto nella desolazione di un mondo che si è ormai strutturato in identità collettive sempre più rigide e in antagonismo tra loro. Un mondo sempre più becero - se misurato con i parametri «universitari» del sufismo - e sempre meno sensibile alle istanze della interiorità e dello spirito. Un mondo, insomma, sempre più politicizzato ed economicizzato, che con il Presidente americano di turno ha chiamato crociate le guerre contro Iraq e Afghanistan, che con il sionismo ha chiamato conquista della nostra terra un processo divenuto genocidario, che con il terrorismo islamico ha chiamato al Jihad contro l’infedele occidentale, e via elencando. Quando, da sempre, il meglio che ciascuna di queste religioni monoteistiche ha prodotto è sempre stato nell’individualismo e nello spazio spirituale.
Ma si sa, a fronte delle pratiche elettive, delle pratiche «universitarie», masse e governi fanno corpo unico. E con il pretesto dell’Unicità divina (Tawhid) reclamano per sé il diritto di disporre della libertà degli uomini e foss’anche quella di proclamarsi - semplicemente recitando, praticando rituali sacrificali e girando in tondo nella danza - in grado di percepire qualcosa della Trascendenza.
Evidentemente però la Trascendenza è sempre faccenda a uso e consumo del Potere. La si usa a pretesto per l’oppressione e il dominio e ne si dimentica le infinite possibilità di consegnarsi all’individuo o alla confraternita in cui egli si inserisce. E questo per sottrargli l’unica esperienza religiosa davvero degna di attraversare l’esistenza di un uomo: l’esperienza immediata, diretta e personale di Dio.
Il Medioriente, l’Islam e noi
Millevoci 19.10.2021, 11:05
Contenuto audio