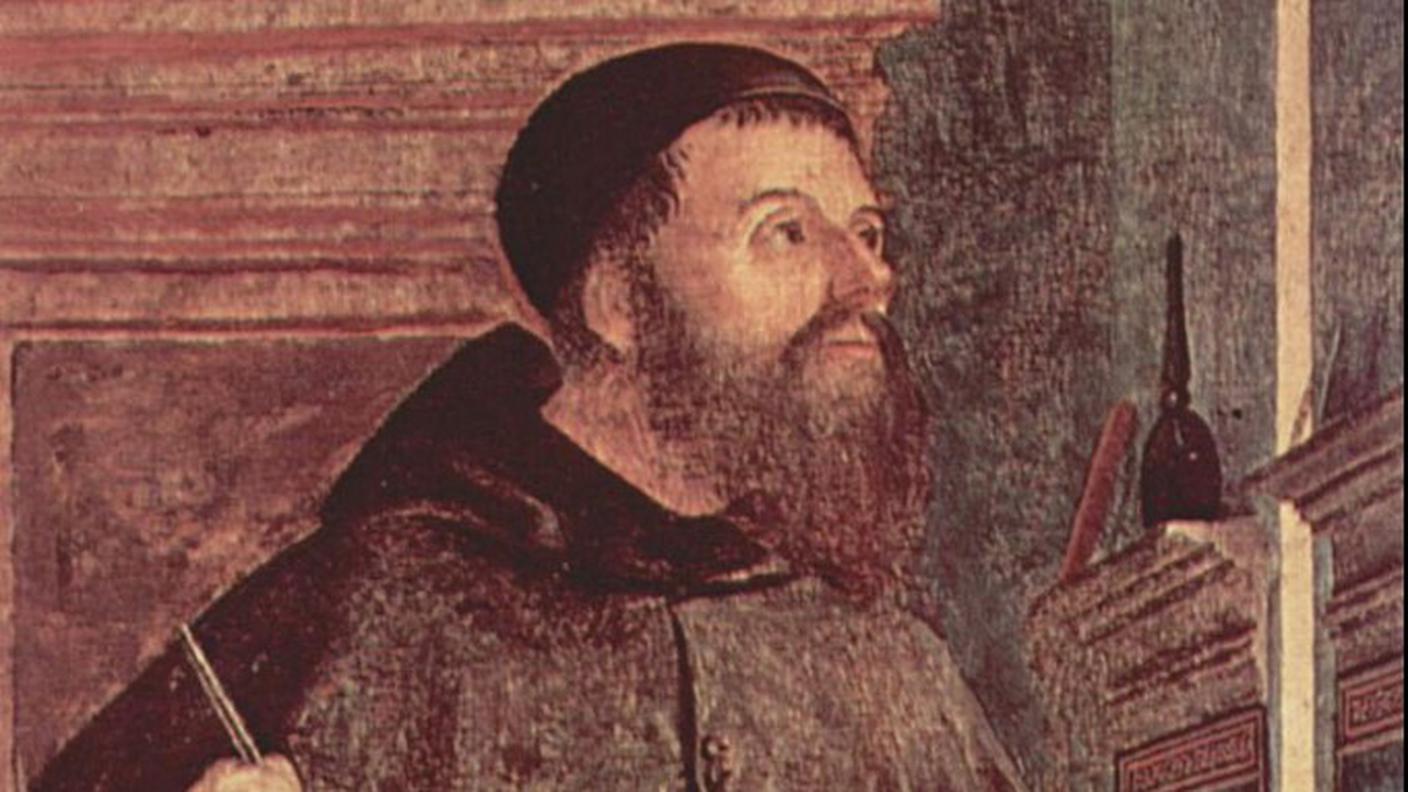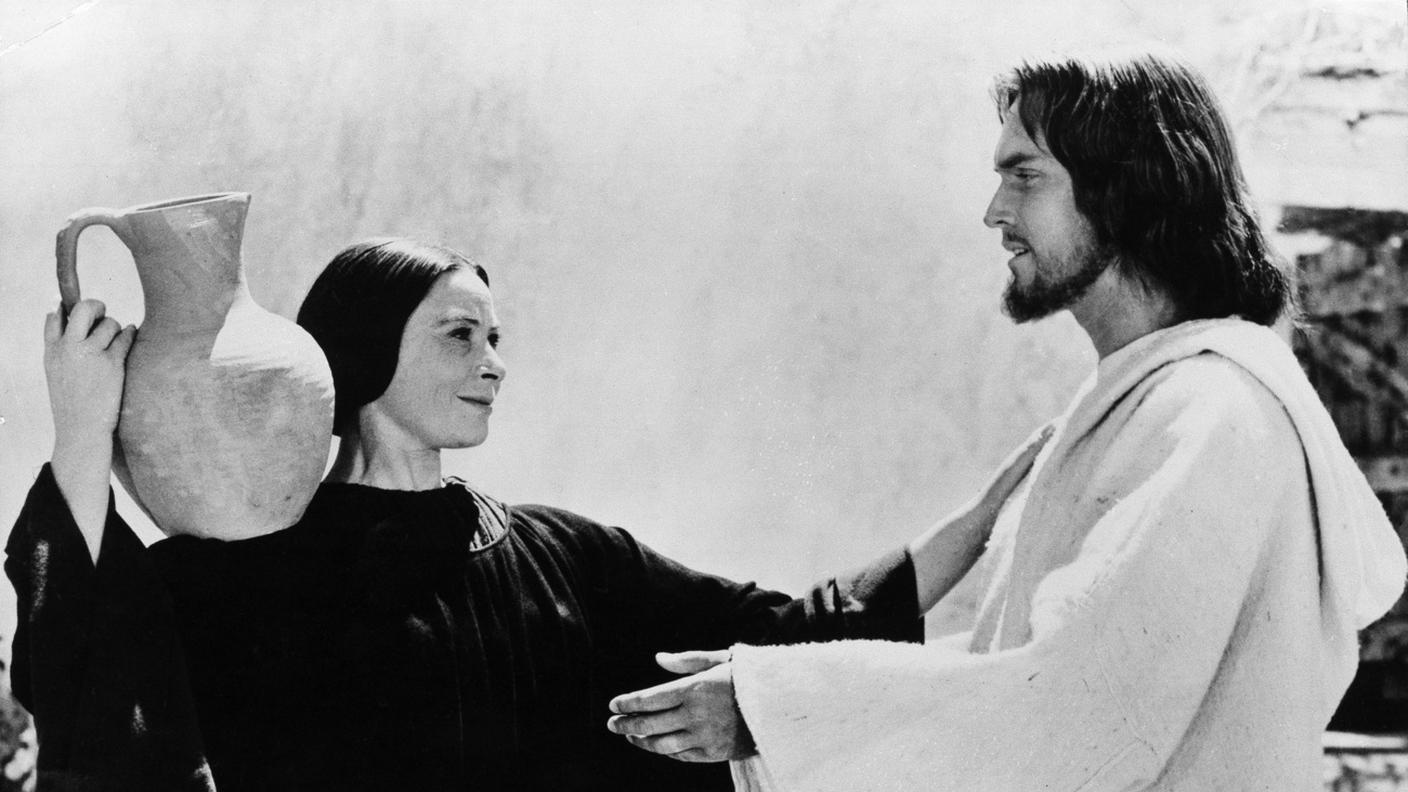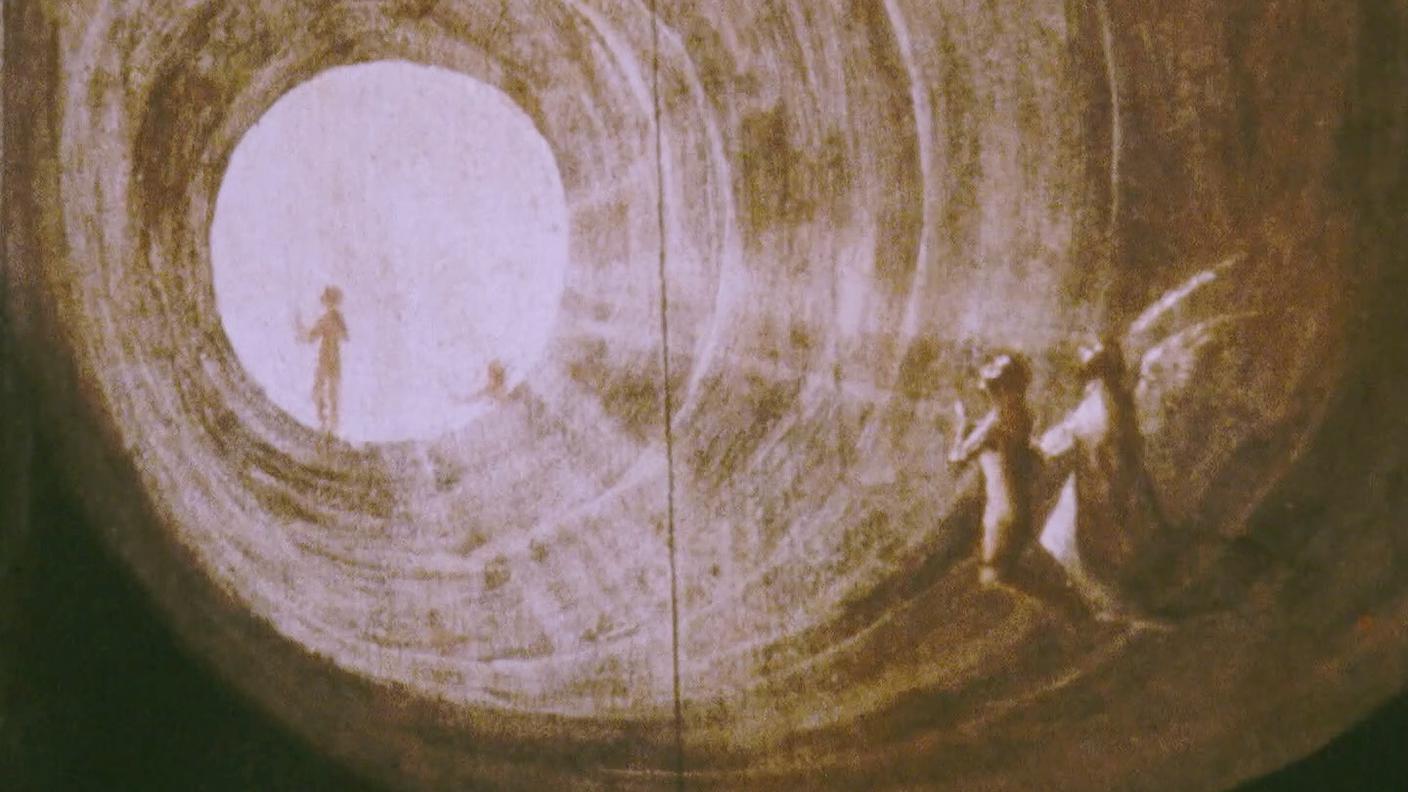Quando l’8 maggio è stata annunciata al mondo l’elezione del cardinale agostiniano Robert Francis Prevost a successore di Pietro, in tanti sono rimasti stupiti per il nome Leone, da tempo in disuso, che il nuovo vescovo di Roma e capo della Chiesa cattolica ha voluto assumere. L’ultimo papa a chiamarsi in questo modo era stato infatti Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, morto il 20 luglio 1903 dopo oltre venticinque anni di pontificato. E a Leone XIII, in quanto papa di quella magna charta della dottrina sociale della Chiesa che è l’enciclica Rerum novarum (15 maggio 1891), ha soprattutto guardato Prevost per la scelta del nome pontificale, come ha lui stesso spiegato, il 10 maggio, nel primo incontro con il Collegio cardinalizio. «Diverse sono le ragioni – ha dichiarato –, però principalmente perché il papa Leone XIII, con la storica enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro». Ma a poco più di due mesi dall’elezione di Leone XIV, nel cui magistero sono pressoché costanti i rimandi espliciti al predecessore di fine ‘800 e ai suoi diversi acta, si può ravvisare una ragione forse più intima, per quanto inespressa, sottesa a tale scelta. Gioacchino Pecci fu, infatti, il papa che più di tutti ebbe particolarmente a cuore i «figli di Sant’Agostino»: lo aveva già spiegato nel 2005 Gian Luigi Bruzzone in uno specifico studio dall’inequivocabile titolo Leone XIII, grande amico dell’Ordine agostiniano.
Molteplici i motivi, che hanno valso questo appellativo a chi, come Successore di Pietro, traghettò la Chiesa nel XX secolo. Le origini del profondo legame tra Gioacchino Pecci e gli Agostiniani, denominati ufficialmente Eremitani di sant’Agostino fino al 1969 – anno in cui fu adottato il vigente titolo di Ordine di sant’Agostino –, sono da ricercarsi nello stesso paese natale del futuro Leone XIII, ossia Carpineto Romano, che dalla seconda metà del ‘500 tributa al vescovo d’Ippona il titolo di protettore. A stabilirne il culto erano stati gli agostiniani del locale convento, che, fondato nell’ultimo decennio del XIII secolo, era stato soppresso a seguito dell’editto napoleonico del 17 maggio 1809. Ma il ricordo dei religiosi era rimasto ben vivo negli abitanti del comune lepino e, in particolare, nei conti Pecci, che sin da subito avevano assunto la gestione dell’ex complesso conventuale e dei connessi beni. Gli agostiniani, che un secolo prima, fra l’altro, avevano radicato la devozione alla Madonna del Buon Consiglio tra i carpinetani, vi avrebbero fatto ritorno il 28 agosto 1888 per espressa volontà di Leone XIII, grazie alla cui munificenza era stata restaurata, abbellita e riaperta al culto la chiesa di Sant’Agostino. Nel medesimo anno l’antico convento, anch’esso del tutto rinnovato, sarebbe divenuto casa di noviziato per le provincie italiane e tale sarebbe rimasto fino al 1928. Bisogna inoltre ricordare come proprio nella terra natale, dove Vincenzo Gioacchino Pecci visse fino all’ottavo anno di età prima di trasferirsi a Viterbo per gli studi presso i gesuiti e, quindi, a Roma presso il padre oramai vedovo, fosse sbocciata la sua filiale pietà verso la Madre del Buon Consiglio, la cui effigie “miracolosa” è venerata dal 1467 a Genazzano, lontano una trentina di chilometri da Carpineto, nell’omonimo santuario agostiniano. A distanza di decenni ne avrebbe accennato lui stesso nello splendido carme in tre distici elegiaci, comparso nel 1896 all’interno della raccolta poetica In Mariam Virginem flosculi e intitolato Iulius adolescens Deiparam Matrem a Bono Consilio supplex implorat: «Assuevi a puero dulcem te dicere matrem, Te prece, te votis sollicitare piis. Mox pubescenti pietas deferbuit aevo: Mens stupet insanis icta cupidinibus. Ast o, tu pueri memor, adsis, Virgo: vocaris Namque boni Mater provida Consilii» (Sin da bambino mi sono abituato a chiamarti col dolce nome di madre, a implorarti con preghiere e suppliche devote. Poi, alle soglie della giovinezza, la pietà si è illanguidita: stordita è la mente sotto i colpi di desideri insani. Ma tu, memore di me fanciullo, aiutami, o Vergine: sei infatti chiamata provvida Madre del Buon Consiglio, nda).
A contatto con gli agostiniani nel primo periodo romano – risale a quegli anni la conoscenza di Pecci con l’allora priore di Sant’Agostino in Campo Marzio, Giuseppe Maria Castellani, che, divenuto vescovo titolare di Porfireone e sacrista dei Palazzi Apostolici, avrebbe partecipato, il 19 febbraio 1843, alla sua consacrazione episcopale come assistente del cardinale Luigi Lambruschini – e poi negli anni tanto della delegazione apostolica a Benevento (1838-1841) – il locale convento duecentesco era tornato in possesso degli Eremitani nel 1822 – quanto della nunziatura in Belgio (1843-1846), dove l’unica comunità sopravvissuta alla bufera delle soppressioni era quella di Santo Stefano a Gand, il futuro Leone XIII avrebbe intensificato e consolidato un tale rapporto soprattutto negli oltre tre decenni di episcopato perugino (1846-1877). Il capoluogo umbro poteva infatti vantare uno dei più numerosi e fiorenti studi generalizi dell’Ordine, in cui, ai tempi dell’arcivescovo Pecci, si distinsero come docenti illustri Giuseppe Aggarbati, Luigi Concetti e, soprattutto, Guglielmo Pifferi. Alla scuola di quest’ultimo, che nel 1887 sarebbe stato nominato da Leone XIII vescovo titolare di Porfireone e sacrista del Palazzo Apostolico, divenendo in quanto tale confessore ordinario del papa, si era formato Luigi Sepiacci. Ordinato presbitero nel 1858 proprio da Gioacchino Pecci, Sepiacci contribuì con i confratelli Agostino Ciasca e Vincenzo Semenza a interessare direttamente l’ex arcivescovo di Perugia, che nel 1878 era assurto al soglio di Pietro, delle sorti degli agostiniani: l’Ordine, dopo un settantennio di politiche di soppressione, incameramento, esclaustrazione in mezza Europa, si presentava infatti fortemente ridotto nei numeri e, al contempo, costretto nelle secche di un più dannoso immobilismo per l’inavvedutezza del priore generale Giovanni Belluomini.
A poco più di due anni dall’elezione Leone XIII passava all’azione, nominando commissario generale Pacifico Antonio Neno, fino ad allora priore provinciale della provincia statunitense di San Tommaso da Villanova, e affidando allo stesso governo e amministrazione dell’intero Ordine. Tra i primi atti il commissario generale, insediatosi a Roma nel febbraio 1881, provvide a rinnovare le massime cariche, nominando, previa approvazione della Congregazione dei Vescovi e Regolari, Luigi Sepiacci procuratore generale, Luigi Mattioli, Agostino Ciasca, Vincenzo Semenza e Paul Hacker rispettivamente primo, secondo, terzo e quarto assistente. L’incarico di segretario generale, precedentemente svolto da Sepiacci, fu invece affidato a padre Angelo Ferrata. A Pacifico Neno – che, nominato nel 1887, a seguito della morte di Belluomini, 82° priore generale da Leone XIII, sarebbe però deceduto, appena cinquantaseienne, il 21 febbraio 1889 – va ascritto il grande merito dell’acquisizione di Villa Cesi, che, ubicata nelle adiacenze di piazza San Pietro, è dal novembre 1882 sede della Curia generalizia e del Collegio internazionale Santa Monica. Va inoltre ricordato che sempre nel 1881, all’età di trentatré anni, era divenuto postulatore delle Cause di beatificazione e canonizzazione dell’Ordine Sebastiano Martinelli, fratello minore dei due agostiniani Tommaso Maria – cardinale dal 1875 – e Aurelio, che, anche una volta eletto priore generale nel Capitolo del 1889, avrebbe esercitato tale carica fino al 1896. Si deve al suo zelo instancabile se, in quell’arco di tempo, Leone XIII canonizzò Chiara da Montefalco, beatificò Alonso de Orozco, John Stone, Josefa Maria de Benigànim, riconobbe il culto ab immemorabili tempore e il titolo di beato ad Angelo da Furci, Sante da Cori, Grazia da Cattaro, Angelo da Foligno, Guglielmo da Tolosa, Giacomo da Cerqueto. Sarebbe invece spettato ad Agostino Zampini, succeduto a Martinelli come postulatore generale, portare a compimento la storica causa di canonizzazione di Rita da Cascia, proclamata santa da papa Pecci durante il Giubileo del 1900. Il 7 ottobre di quell’anno, inoltre, per espressa disposizione di Leone XIII, gli agostiniani tornavano in possesso del complesso pavese di San Pietro in Ciel d’Oro, da cui erano stati estromessi nel 1785, e accoglievano nella monumentale chiesa d’origine longobarda le reliquie di sant’Agostino, ivi solennemente ritraslate dal Duomo della città lombarda. Per l’occasione il papa latinista compose il carme in sei distici elegiaci Doctrinae laus, inciso su una lastra marmorea nei pressi delle spoglie del vescovo d’Ippona.
Dei numerosi religiosi finora citati ben tre furono creati cardinali da Leone XIII, che, in tal modo, è a tutt’oggi il pontefice ad aver ascritto il maggior numero di agostiniani al Sacro Collegio: se Sebastiano Martinelli, che, già nominato vescovo titolare di Efeso e delegato apostolico negli Stati Uniti, era stato elevato alla porpora nel 1901, fu l’unico a sopravvivere a papa Pecci – sarebbe infatti deceduto il 4 luglio 1918 –, Luigi Sepiacci e Agostino Ciasca, rispettivamente insigniti della dignità cardinalizia nel 1891 e nel 1899 dopo aver precedentemente ricevuto la consacrazione episcopale e importanti incarichi in Curia romana, premorirono entrambi al papa della Rerum novarum. Particolare menzione merita Agostino Ciasca, che, considerato a buon diritto l’agostiniano più dotto del XIX secolo, s’impose a tal punto come orientalista e autore di rigorose opere filologiche – basti pensare all’edizione del testo arabo con traduzione latina del Diatessaron di Taziano sulla base di due codici della Vaticana – da essere nominato nel 1891 prefetto dell’Archivio segreto vaticano e nel 1893 segretario della Congregazione di Propaganda Fide.
Un’ultima parola, anche se molte altre considerazioni potrebbero essere fatte, va riservata all’impegno con cui Leone XIII, definito nel 1928 da Bittremieux «verus doctor Marialis» per i numerosi documenti magisteriali sulla Madonna, promosse la devozione alla Madre del Buon Consiglio: approvazione del nuovo Ufficio e Messa per la festa del 25 aprile (18 dicembre 1884); concessione dello scapolare bianco in onore della Mater Boni Consilii con annesse indulgenze (21 dicembre 1893): lo stesso pontefice ne volle ricevere uno, che, impostogli dal confessore Guglielmo Pifferi il 20 aprile 1894, avrebbe indossato fino alla morte; elevazione del santuario di Genazzano alla dignità di Basilica minore (17 marzo 1903); aggiunta dell’invocazione Mater Boni Consilii, ora pro nobis nelle Litanie lauretane (22 aprile 1903). Si potrebbe pertanto dire che anche sotto quest’ultimo aspetto Leone XIV, la cui prima uscita dal Vaticano, il 10 maggio scorso, ha avuto come meta il santuario genazzanese della Madre del Buon Consiglio, dà prova di rifarsi al suo predecessore, “grande amico dell’Ordine agostiniano”.
Rerum Novarum: la chiesa e il mondo operaio
Alphaville 18.06.2025, 12:35
Contenuto audio