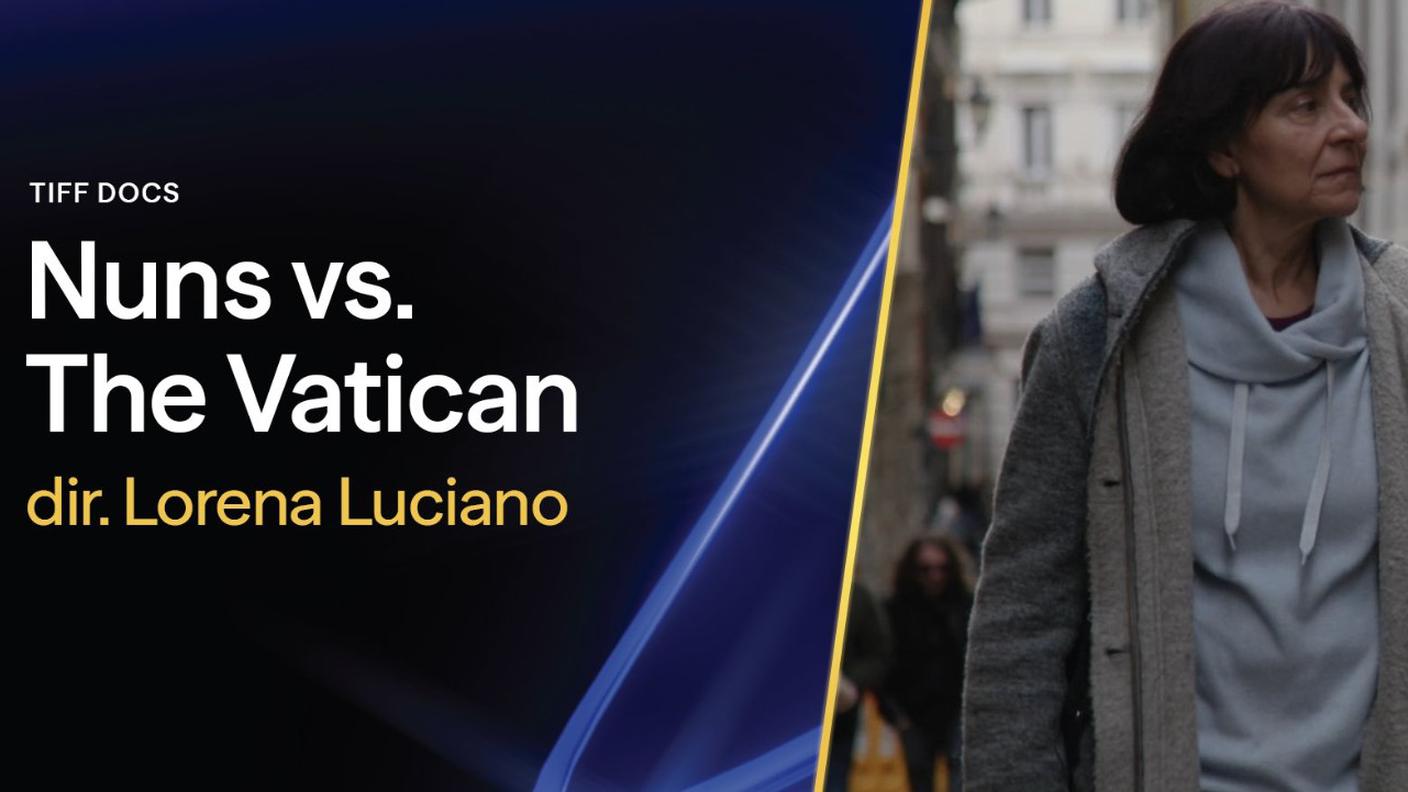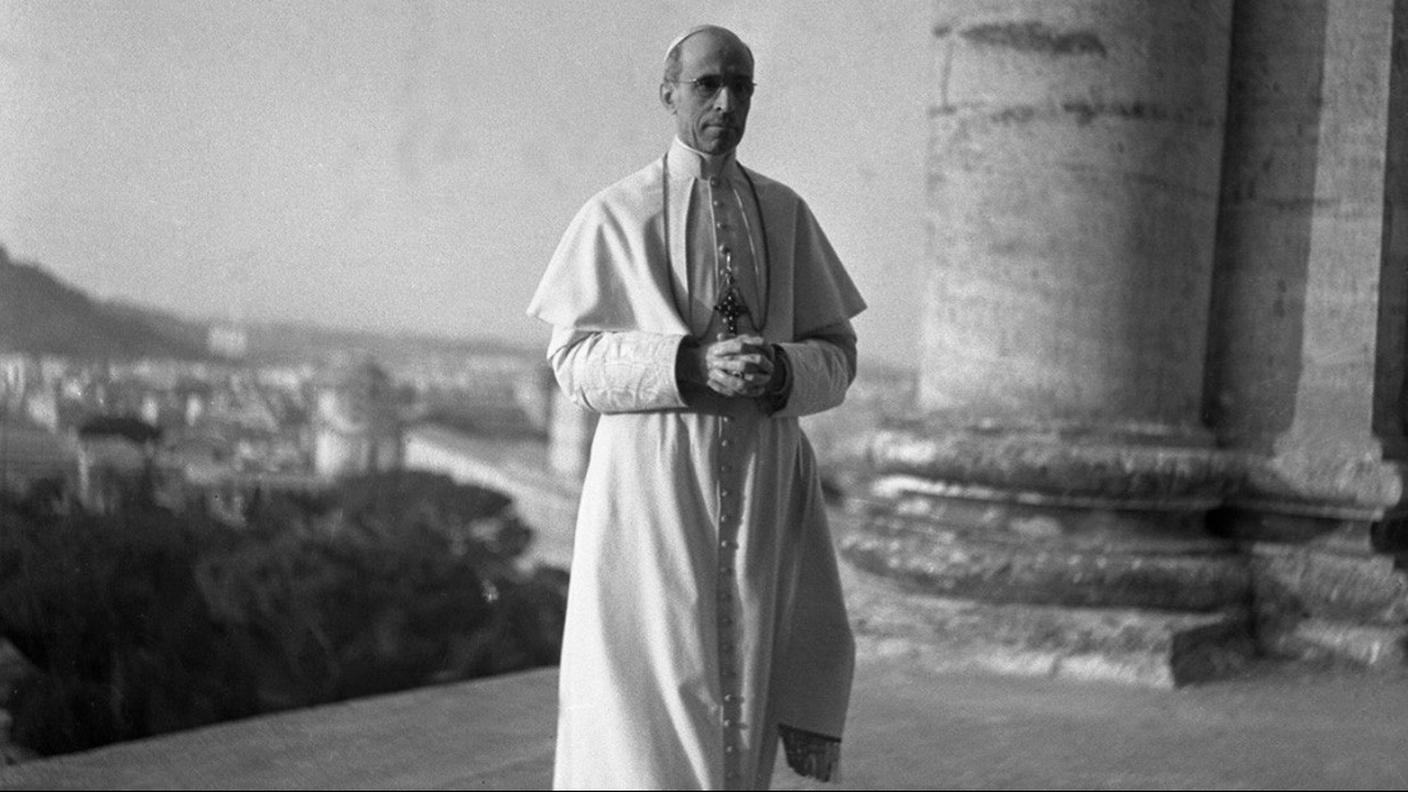Nel panorama ecclesiastico, la necessità di distinguere tra abuso spirituale e abuso sessuale non è solo questione terminologica, ma etica e teologica. Un recente servizio radiofonico di “Chiese in diretta” ha affrontato questo nodo, dando voce a tre figure di rilievo: Lorena Luciano, regista del documentario Nuns VS The Vatican; Federica Tourn, giornalista d’inchiesta esperta del “caso Rupnik”; e Stephan Jütte, teologo e portavoce della Chiesa evangelica riformata in Svizzera, moderatore del simposio “I limiti del sacro” tenutosi alla Paulusakademie di Zurigo.
L’abuso spirituale si manifesta quando una figura religiosa usa il proprio ruolo per manipolare, controllare, soggiogare. Non sempre si accompagna a violenza fisica, ma spesso ne è il preludio. Lorena Luciano, nel suo documentario, raccoglie testimonianze di religiose che hanno subito violenze in ambienti chiusi e gerarchici, dove la parola del superiore è legge. «Il problema non è solo ciò che accade fisicamente, ma ciò che viene fatto passare come spiritualmente giusto», afferma.
Federica Tourn ha sottolineato come il caso Rupnik abbia reso visibile una dinamica ambigua: quella in cui l’abuso sessuale si intreccia con la direzione spirituale, rendendo difficile per le vittime distinguere tra guida e manipolazione. «Serve un linguaggio preciso», ha detto, «che riconosca l’abuso spirituale come forma autonoma di violenza, altrimenti si rischia di non vedere la struttura del potere che lo rende possibile».
Stephan Jütte ha portato la riflessione sul piano teologico, con parole che hanno aperto una prospettiva nuova: «Siamo soliti parlare di abuso spirituale solo in relazione all’insabbiamento di abusi sessuali o alla fase di approccio. Ma l’abuso spirituale è una forma autonoma di abuso di potere, che si verifica quando contenuti religiosi o pratiche spirituali vengono usati per ledere la libertà, l’integrità e l’autodeterminazione di un’altra persona».
Secondo Jütte, il problema non si limita alla condotta individuale, ma affonda le radici nella teologia stessa: «L’abuso spirituale è radicato nelle strutture della nostra teologia, nelle immagini della fede, nei simboli. Quando idealizziamo la vittima, o quando la nostra cultura religiosa predilige l’armonia, il perdono e la riconciliazione, rischiamo di oscurare la giustizia e la verità».
La Chiesa evangelica riformata svizzera, ha spiegato, ha adottato strategie di prevenzione e protezione elaborate da alcune chiese cantonali, proponendole come standard minimo. Ma Jütte è chiaro: «Non bastano buone strategie. Serve una revisione critica dei contenuti teologici e della formazione. Dobbiamo promuovere una cultura in cui il contraddittorio e la richiesta di spiegazioni siano la norma».
Jütte ha riconosciuto che l’abuso spirituale è più difficile da individuare e sanzionare rispetto a quello sessuale. Ma ha anche espresso fiducia: «Se ci impegniamo a rendere visibili le nostre strutture di potere, a indagare le nostre culture religiose, e se ascoltiamo le vittime, che ci parlano delle loro esperienze dirette, allora possiamo realizzare un cambiamento culturale».
Il servizio radiofonico, arricchito da queste voci, ha mostrato come la distinzione tra abuso spirituale e sessuale sia fondamentale per riconoscere le diverse forme di violenza e per costruire percorsi di giustizia. Non si tratta di separare le responsabilità, ma di comprenderle nella loro complessità. Perché solo nominando le cose con precisione si può iniziare a guarire.