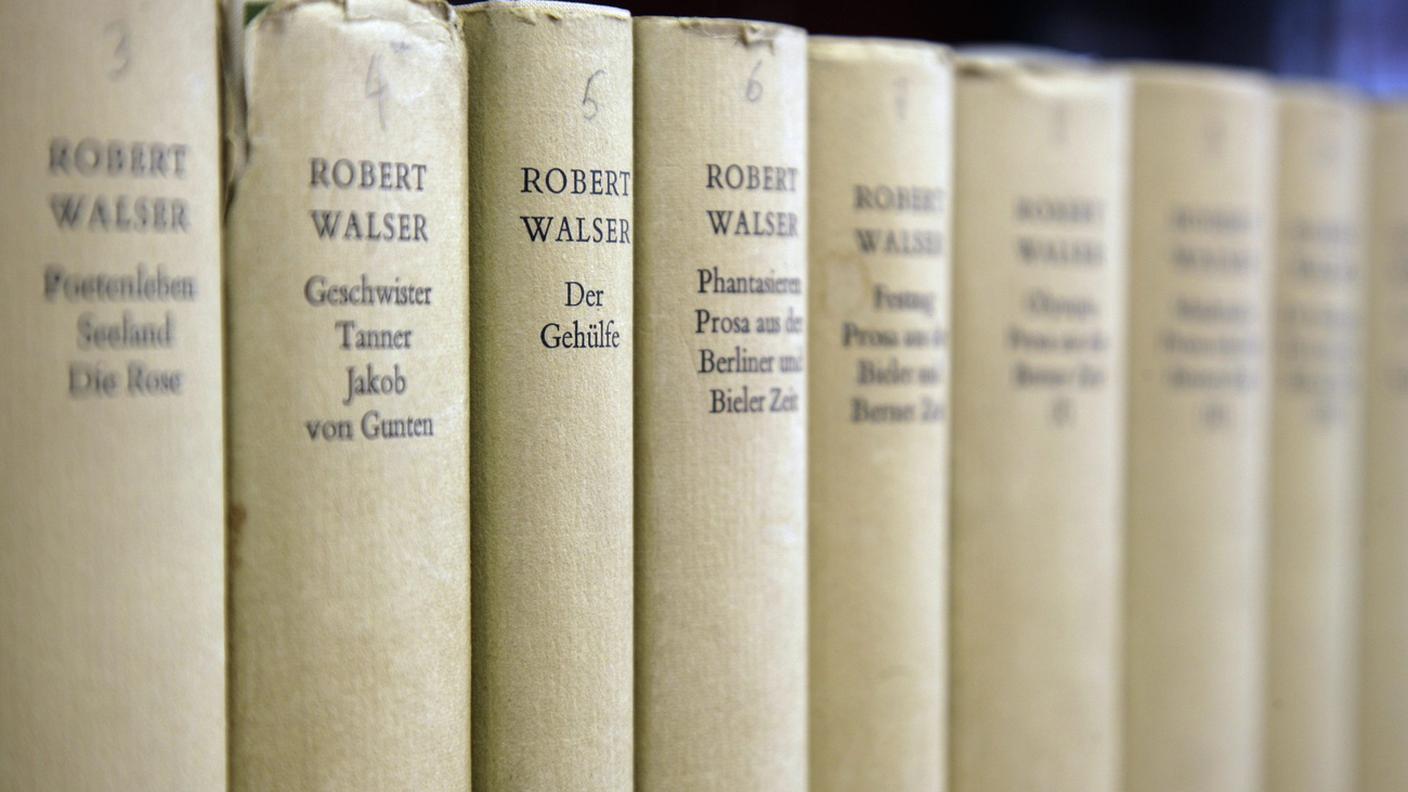Grande alterigia doveva albergare nell’animo di Dante, allorché nelle Epistole (XII, 3.) si definì “predicatore di giustizia” e allorché scrisse l’Inferno elevandosi a giudice delle vite altrui.
Alterigia e anche codardia, giacché si guardò bene dallo sbandierare in piazza le sue sentenze, evitando così di mettere a repentaglio la sua esistenza. Più furbo di un Savonarola, Dante riservò i suoi giudizi alla scrittura, li incatenò in terzine dal piacevole impasto sonoro, dislocando la narrazione in una realtà ultraterrena, come a suggerire l’ipotesi che quei giudizi non fossero suoi, ma espressione di Volontà divina.
Di fatto, però, i giudizi espressi nell’Inferno erano, ovviamente, frutto delle sue personalissime considerazioni, inficiate talvolta anche da bieche frustrazioni e gelosie.
Solo in questo modo si può spiegare l’odio che trasuda dalla prima cantica, in cui Dante non si fa scrupoli a torturare i propri nemici, seviziandoli in modo macabro e crudele, neanche fossero i personaggi di in un film splatter del terzo millennio.
Cesare Garboli definì l’Inferno “il racconto dell’odio”. Un odio mascherato (ancora una volta) in modo codardo sotto le vesti del contrappasso, legge semidivina che consente al fiorentino dal naso adunco di lasciarsi andare alla fantasie più feroci, immaginando i golosi diguazzare nel fango, i corrotti nella pece bollente, i suicidi tra gli sterpi, gli atei in arche di fuoco.
Il sadismo che aleggia nei canti dell’Inferno, seppur riconducibile al concetto della punizione del peccato di stampo veterotestamentario (per cui tanto maggiore è la colpa tanto superiore deve essere la pena) ha un che di passionale e voluttuoso che non si può non ascrivere al sentimento della vendetta. Più che una pena divina, legittimata da un giudizio trascendente, il contrappasso trasuda carnalità e visceralità, smascherando l’origine umana del suo autore, il quale sembra a tratti godere degli spasmi cui condanna i suoi nemici peccatori.
I motivi di questo odio sono molteplici, non da ultimi psicologici, come ha evidenziato Cesare Garboli: “La capacità di odiare nasce in Dante da frustrazione politica, o, più semplicemente, dalla condanna a trascorrere una vita forzatamente inattiva e a parlare in eterno inascoltato. Ma la frustrazione figura talmente sublimata che non è facile, tra le tante bufere e le improvvise schiarite trascendenti, riconoscere il tratto più negativo e creativo della personalità di Dante, la radice della sua esperienza”.
Ma non sono i motivi dell’odio ad interessare qui, quanto piuttosto il suo superamento. Del resto, ogni descensus ad inferos è premessa di rinascita (toccare il fondo per risalire, esprimere il represso per purificarsi).
Nel corso della Commedia, parallelamente al variare del topos, Dante si lascia alle spalle l’odio e volge ad altre acquisizioni. D’altronde, fra l’oggetto pensato e il soggeto pensante c’è sempre un rapporto simbiotico: non è possibile parlare del Paradiso come si parla dell’Inferno e non è possibile provare odio al cospetto della beatitudine celeste.
Il superamento dell’odio avviene sulla sommità del Purgatorio. È qui che Dante si rende conto di aver peccato di superbia e alterigia, di non aver ascoltato, in preda ad una libido di conoscenza (Ulisse), i divieti di Dio, e di essersi sostituito a lui, erigendosi a supremo giudice del mondo e degli altri. È qui che Dante capisce che il mondo non è spiegabile attraverso le sole cause naturali, che non è ascrivibile alle sole acquisizioni umane (Cavalcanti).
Sulla sommità del Purgatorio Dante abbandona i suoi rancori, i suoi giudizi, il suo odio. E in questa condizione di libertà dai propri sentimenti, Dante scopre che la scrittura può essere altra cosa rispetto allo sfogo dell’odio e del represso. La scrittura può essere ascolto.
Laddove non c’è più un io, non c’è più una psiche a generare (e offuscare) idee e sentimenti, la scrittura può servire una realtà ulteriore. E questa realtà ha per Dante il volto e la voce del Dio cristiano, che si manifesta innanzitutto come gratuita e onnicomprensiva espansione d’Amore.
Ecco allora che la scrittura diventa trascrittura dell’amore divino, che pervade l’anima del suo discepolo, mettendogli in bocca le parole da dire, parlando in vece sua: “I' mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch'e' ditta dentro vo significando” (Pg XXIV 52-54).
Che per bocca dei poeti, privati del senno e della volontà, parli la divinità, lo affermava già Platone. E la divinità in Dante si manifesta cristianamente nelle fattezze dell’Amore (come abbiamo visto), ma anche dello Spirito (“[Spirito] entra nel petto mio, e spira tue”, Par I, 19) e della luce: “O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi!” (Par XXXIII, 124-126).
Dante, approdato nel Paradiso, diventa dunque testimone del regno dello Spirito, dove non c’è più posto per l’odio, e dove ogni elemento è pervaso d’amore, quell’amore “che move il sole e l'altre stelle” (Par XXXIII, 145). Qui una luce fulgida sembra irradiare da ogni elemento: dall’aria, dall’acqua, dal cielo, … Luce che ingloba ogni cosa, ricoprendo lo stesso Dante di un fulgido manto : “così mi circonfulse luce viva / e lasciommi fasciato di tal velo / del suo fulgor che nulla mi appariva” (Par XXX, 49-51, si badi che “nulla” in termini mistici è Dio, per cui al pellegrino Dante appariva Dio). Qui, in Paradiso, è tutto un dispiegarsi di luce e amore, e le due entità si sovrappongono: luce che “sola e sempre amore accende” (Par V, 9).
L’intensità di questo Amore è tale da provocare nel pellegrino una cancellazione estatica di sé. Il Dante psicologico, che abbiamo riscontrato nella prima cantica, non è che un ricordo. La conversione è compiuta: Dante è ormai con Dio in Paradiso (Lc 23, 43). E qui contempla estaticamente la Sua gloria, senza mediazioni, faccia a faccia, in una visione-comunione che placa ogni dolore (“amor di vero ben pien di letizia /letizia che trascende ogni dolzore”, Par XXX, 41-42), che “queta ogne intelletto” (Par XXVIII, 108).
Dante, nel Paradiso, è tutt’uno con lo Spirito. Questa sua intima comunione viene descritta in modo mirabile nell’endecasillabo“s’io m’intuassi come tu ti’inmii” (Par IX, 81). Un endecasillabo che esprime il concetto di transustanziazione, di dileguamento del corpo e di assunzione dello Spirito. Così come lo esprimono i verbi di matrice alchemica: inluiarsi, insemprarsi, inventrarsi, insusarsi o transumanar. Tutti verbi coniati ex-novo da Dante per sottolineare la compenetrazione fra l’umano e il divino, fra il terreno e l’ultraterreno.
Ecco dunque la parabola che si cela fra le pieghe della Commedia: la parabola di un uomo che da hater si trasforma in mistico. E questo semplicemente volgendo il proprio sguardo al cielo, sollevandolo dal fango dell’Inferno allo splendore del Paradiso.
"Chi ama la terra sarà terra, chi ama Dio sarà Dio”, diceva Agostino. Il solo pensare Dio (pensare il Bene, descrivere il Paradiso) significa avvertirne l’amore. Perché Dio è Amore, un amore che ha la forza di trasformare l’amante nell’Amato, di trasumanarlo, di indiarlo. L’amore è il motore della coincidenza fra l’io e Dio: "A chi mi amerà, Io manifesterò me stesso ed egli sarà una sola cosa con me ed Io in lui” (Gv 14, 23).