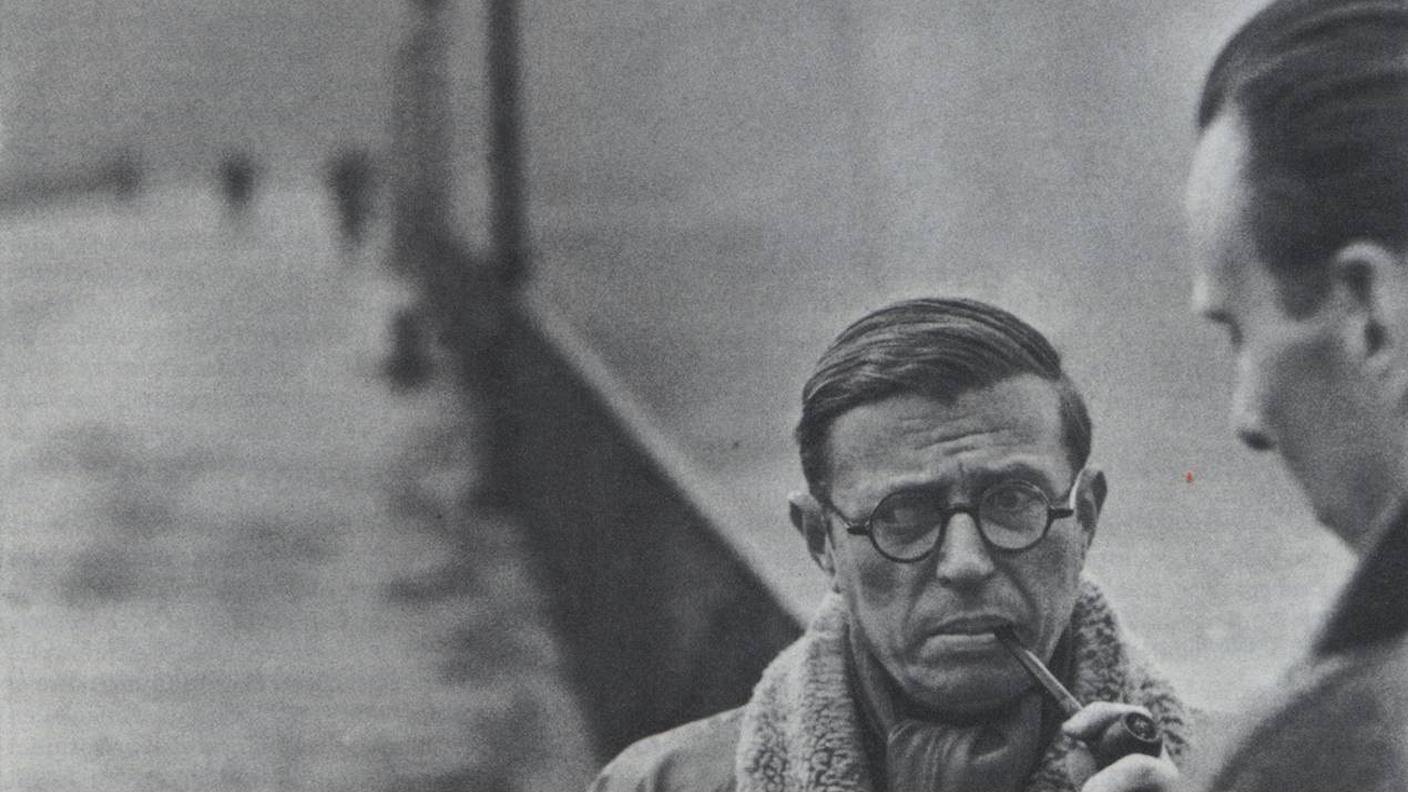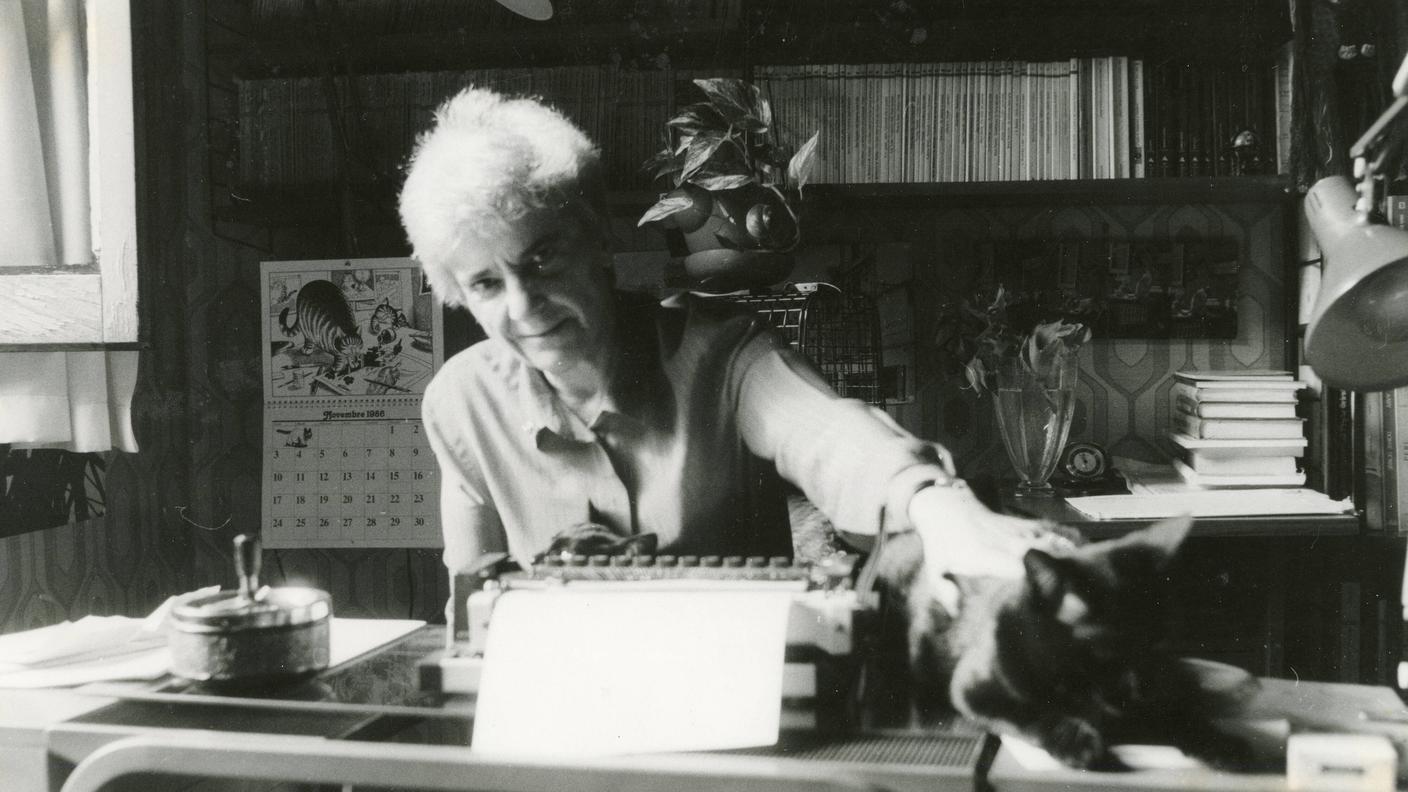Adonis, al secolo Ali Ahmed Saïd Esber, nato in Siria il 1 gennaio del 1930, è probabilmente l’intellettuale e letterato arabo più letto e influente a livello globale. Adonis non è in effetti solo un grande poeta, ma è quella penna autorevole e impietosa che denuncia le derive della religione, l’involuzione oscurantista del mondo arabo e il suo declino politico e culturale. Il suo recente “Violenza e Islam” ha suscitato un ampio dibattito per la sua tesi di fondo particolarmente scomoda che vede, pur senza sottacere l’impatto di elementi esterni come la politicai internazionale, un legame stretto tra la dottrina stessa e le derive prevaricatrici e liberticide. Fuggito nel 1956 a Beirut, vive dal 1985 in esilio a Parigi.
Adonis ospite di Rete Due - 07.10.2016
RSI Cultura 08.10.2016, 22:19
La poesia è ribellione
Per Adonis la poesia, ingabbiata nei secoli dal controllo teocratico, è tale e autentica, solo se sovverte l’ordine delle cose, del pensiero, delle regole, del senso. La grande tradizione delle poesia ribelle risale al periodo degli Omayyadi (il califfato di Damasco a cui seguì nel 750 d.C quello abbaside, che regnò a Bagdad fino alla conquista delle città da parte dell’armata turco-mongola nel 1258) recuperando quello spirito di trasgressione che permette la creazione e che apre la strada verso l’ignoto. Non furono pochi i poeti che si ispirarono a Imru al - Qays che per Adonis è il capostipite della ribellione poetica, il vero iniziatore della poesia araba. Come Abû Mihjan al-Thaqafi, amante del vino in barba alla proibizione coranica o il grande (secondo Adonis) Abu Nuwâs che rompe con la tradizione grazie all’esercizio del mujûn che può essere associato alla pratica del libertinaggio. Per Nuwâs il mujûn permette il ribaltamento dei valori stabiliti, in una dialettica in cui si susseguono negazione e affermazione, distruzione e rinascita. Adonis si iscrive dunque nella tradizione di Abû Nuwâs che “celebra il paradiso terreno e rifiutando la nozione di divieto, sostituendo il mujûn alla religione, ha infranto l’imposizione delle leggi e annunciato l’avvento della libertà”. Lo spirito impersonato da queste correnti è -come facile capire- lo stesso che viene progressivamente negato dall’Islam per il quale il sapere perfetto del Corano incarna la verità e conduce ad essa. Il totalitarismo ideologico è per il poeta paralizzante: liberare il pensiero è la premessa per liberare la società e la politica che, anche quando pensa di essersi affrancata dalla matrice religiosa (ma che ne è in realtà sostanzialmente figlia), ha portato nel mondo arabo solo verità assolute, declinate nelle varie forme storiche, dall’arabismo, al nazionalismo, al marxismo. Il pensiero arabo dominante, ci dice Adonis, possiede una struttura religiosa anche quando crede di farne a meno. La religione e le sua articolazioni ideologiche come fondamenta del declino di una civiltà, sostiene il poeta. Si deve dunque decostruire, separare finalmente il culturale dal religioso, superare l’appiattimento che ostacola il pluralismo, “dare radici alla differenza”. Interrogare la vita, la realtà, senza ostacoli e preconcetti. La cultura araba traendo la sua identità dal connubio lingua/religione (indissociabili poiché il Corano è stato rivelato in arabo) rimane così insabbiata nel passato, perché la rivelazione è totalizzante, immutabile, definitiva. E’ “il passato che non passa, l’identità che si riduce a una ripetizione, il tempo fossilizzato di una psiche sofferente” sintetizza Houria Abdelouaded coautrice con Adonis di “Violenza e Islam”.
Violenza e Islam: incontro con Adonis (di R. Antonini)
Rimbaud e il misticismo
Non è certamente un caso che una delle figure di riferimento di Adonis sia Arthur Rimbaud. Il grande poeta francese dell’800 ha in effetti saputo rompere con la tradizione e in quel suo viaggio verso l’ignoto ha disertato il suo spazio culturale di riferimento “cartesiano e euclideo” in una straordinaria presa di posizione per sfuggire alle costrizioni, ideologiche e linguistiche. Quel celebre “io è un altro” di Rimbaud ricalca per Adonis l’esperienza dei grandi mistici arabi avversati dall’ortodossia musulmana. Per il mistico la verità non si riassume nella Sharî’a (la legge rivelata) che è solo apparenza, immagine sensibile contrapposta all’essenza. La verità è altro: nascondimento, approdo nell’ignoto. L’esperienza mistica come la scrittura surrealista mira a svelare l’ignoto. Il mistico intraprende un viaggio mentre per il musulmano ortodosso si tratta solo di imitare un modello al quale non vi è nulla da aggiungere e oltre il quale non vi è nulla da scoprire. Il mistico ha un'altra scrittura che non è quella coranica, mira a purificare l’interiorità non ad imporre normative. Il misticismo, come ci racconta Adonis, fu una grande esplosione culturale nel cuore della società islamica, e non solo araba. “Strappò il pensiero” alle costrizioni della giurisprudenza (Fiqh) e della legge (Sharî’a) proiettandolo verso lidi inesplorati: la poesia mistica è interrogazione dell’essenza umana, del mistero dell’esistenza. Il discorso su questa esplorazione ci conduce attraverso le pagine delle pubblicazioni di Adonis, sia saggi sia raccolte poetiche, a comprenderne i pericoli per chi, nella società araba ma anche più in generale islamica, considera il concetto di identità nel quadro di una concezione chiusa, bloccata che esclude l’altro, il diverso. L’alterità si trasforma in minaccia, l’altro è ripudiato: o assimilazione all’ideologia religiosa o rifiuto. Mentre per l’uomo della jâhiliyya (termine originariamente peggiorativo con cui l’Islam degli inizi designò l’epoca che l’aveva preceduto) la lingua “era una magia luminosa” , con i il passare del tempo per l’arabo musulmano si è tramutata in dono di Dio, immutabile di conseguenza. E’ in questo contesto che Adonis ci spiega il perché la poesia araba, dalla grande tradizione, è diventata noiosa, scontata “monotona e piatta”.
Opere Adonis
Un freno allo sviluppo, la logica della violenza
Un società fondata sulla Rivelazione è per natura condannata a ripetere il passato. Il mutamento assume una connotazione negativa. L’anteriore è il modello, l’ulteriore può tuttalpiù cercare di imitarlo. Come per la poesia e la lingua, anche per la società e per la civiltà, la commistione del religioso in tutte le declinazioni della vita sociale e politica, porta all’immobilismo, al tentativo continuo di ripetere la memoria e le tradizioni. Il grande islamologo sufi francese Abdelwahab Meddeb, scomparso due anni fa, condivideva l’analisi di Adonis: il mondo arabo islamico ha progressivamente perso terreno e verso la fine del XVIII secolo i musulmani stessi cominciano a prendere coscienza di non essere più all’altezza dell’occidente. E’ in questa fase che nasce il risentimento arabo alla base di alcune tracimazioni radicali. Perché il risentimento è proprio di chi riceve ma non è più in grado di dare. Da qui, ci dice sempre Meddeb, nasce la cultura del no, del rifiuto dell’altro. Il mondo arabo islamico perde terreno, la creatività passa progressivamente altrove. E così le scoperte scientifiche. Terreno fertile all’integralismo oscurantista che guarda solo indietro. Cultura reattiva e non proattiva. Il ritorno del velo ne è una delle tante manifestazioni. Storicamente è proprio nel XVIII secolo che possiamo individuare una delle maggiori correnti di rifiuto del cambiamento, con la riscoperta da parte di Abd al-Wahab (da cui il wahabismo) del pensiero di Ibn-Hanbal capostipite nel IX sec di una delle correnti più intransigenti dell’Islam sunnita (l’hanbalismo per l’appunto, una delle 4 scuole giuridiche del sunnismo) . Secondo Meddeb fu proprio questa corrente a fissare il principio della consustanzialità della sfera politica e di quella religiosa. Un principio dalle conseguenze perniciose e nefaste, come racconta Adonis in “Violenza e Islam”. Sì perché per il poeta L’Islam non è in realtà religione di pace e di misericordia. Al contrario: la violenza è insita nella dottrina monoteista. E nell’Islam più che altrove, con il su spirito tribale e una lettura letterale della parola divina. “Su 3000 versetti 518 vertono sul castigo” ricorda il poeta che oltre al Corano cita alcuni hadith (i detti del profeta che formano la Sunna) particolarmente cruenti, che vengono utilizzati per giustificare pesante violazioni dei più elementari diritti umani nei paesi governati da regimi islamisti. A 86 anni la voce di Adonis rimane vivida e decisa. Per questo è un escluso, lui di famiglia alawita siriana considerato come un kafir , un pericoloso miscredente. “Il pensatore che desidera ripudiare la visione classica promossa dalla religione non è più ammesso a far parte della comunità. Viene accusato di tradimento e apostasia”. Ma lui è un combattente. E non intende tacere.
Poesia civile e poesia d'amore (a cura di Marco Alloni)
Contenuto audio
Adonis (1./5)
Blu come un'arancia 28.01.2013, 01:00
Adonis (2./5)
Blu come un'arancia 29.01.2013, 01:00
Adonis (3./5)
Blu come un'arancia 30.01.2013, 01:00
Adonis (4./5)
Blu come un'arancia 31.01.2012, 01:00
Adonis (5./5)
Blu come un'arancia 01.02.2013, 01:00