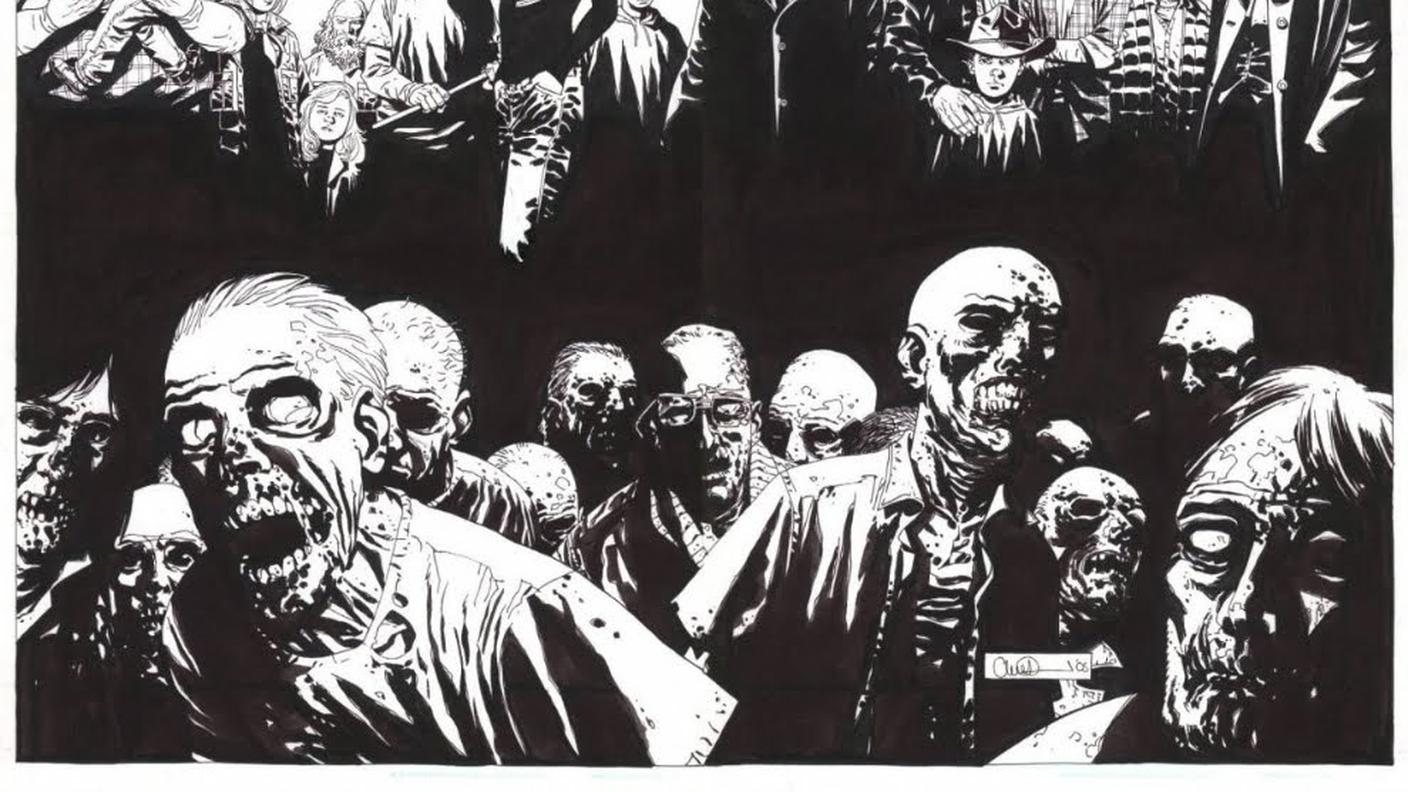Tra i tanti prodigi di cui è stata capace Marguerite Yourcenar nell’elaborare Memorie di Adriano, tre mi sembrano in particolare degni di nota: aver prestato uno spirito “femminile” a un personaggio maschile, aver messo in scena l’improbabile equilibrio tra vita pubblica e vita privata, laddove uno storico dell'antichità, ma anche del presente, si sarebbe fermato al livello della mera esistenza ufficiale di Adriano, e averci regalato il ritratto della coincidenza tra grandezza e umiltà.
Sono naturalmente solo alcuni dei molti pregi di questo libro, che oscilla tra il memoriale, il romanzo epistolare e la biografia poetica, la ricostruzione di un impero (al tramonto) e la confessione intima di un uomo (al limitare dell’esistenza). Ma su questi tre punti vale forse la pena spendere qualche parola.
M.Yourcenar intervistata da Bernard Pivot (1979)
Lo spirito “femminile.” Lungi dall’essere una “femminizzazione” di Adriano, quella della Yourcenar è una straordinaria impresa in cui l’imperatore riesce a essere raccontato, pur nella sua evidente virilità, al femminile. O per meglio dire, a essere calato nei panni di un Io narrante maschile che raccoglie, con perfetta naturalità, quella che potremmo chiamare la sensibilità femminile. Eroico, coraggioso, colto, intelligente e pragmatico, Adriano è infatti più delicato e complesso di quanto ci si aspetterebbe da un imperatore. E lo è perché la Yourcenar indaga nell'intimo, come probabilmente solo uno spirito femminile o una donna è in grado di fare, scoprendo amori, passioni, inclinazioni e vizi che la declinazione eroicizzante del personaggio ha sempre trascurato.
Ecco allora come Adriano, proprio perché snidato dallo sguardo di un’autrice e non di un autore, si svela in tutta la sua più segreta intimità: sia per come ha agito (e siamo al piano dell'ufficialità) sia soprattutto per come ha pensato, ha sentito, ha interpretato spiritualmente la vita. Una mise en abîme, si potrebbe dire, che ci consegna l’immagine di un condottiero non meno attento alle sottigliezze del cuore che alle ragioni del potere o della politica, e che nel farsi stesso di questo memoriale diventa, proprio in virtù dello scandaglio della Yourcenar, un uomo spogliato dei paramenti e degli stereotipi della gloria e della guerra per svelarsi nella nuda esattezza della sua natura di uomo.
Ritratto di Adriano, 117 ca, Museo Nazionale di Roma
E siamo così, quasi naturaliter, al secondo punto: la rappresentazione della dimensione privata di chi, per statuto e ruolo, ha assunto quasi obbligatoriamente, o esclusivamente, un rilievo pubblico. Qui la penna della Yourcenar coglie quintessenze che, se uno storico o un biografo avrebbe al più potuto ventilare, l’autrice francese è in grado di portare al centro della rappresentazione: come se Adriano fosse eminentemente l’insieme delle piccole e personali circostanze che ne fecero, nei decenni, l’emblema della potenza di Roma e del suo inesorabile declino.
E questo è un dato che riporta la ricostruzione storica della Yourcenar allo specifico narrativo: raccontare, raccontando un imperatore, che l’essenza incontrovertibile di chiunque abbia abitato la Storia, qualsiasi posizione abbia assunto in essa, è la sua umanità. Pubblico e privato non solo si intrecciano, ma addirittura si equivalgono, come a suggerire che né l’uno è superiore all’altro né l’uno può prendere luce altrimenti che attraverso l’altro.
In tale prospettiva, la ricostruzione storica della vita di Adriano è quasi meno rilevante del discorso che la sottende, a partire dalla considerazione che gli elementi (potremmo dire, le molecole) che definiscono la Storia e i suoi protagonisti sono sempre elementi privati, che solo a un dipresso diventano pubblici e di interesse pubblico.
Tale operazione, in un certo senso fisiologica a ogni opera narrativa degna di questo nome, diventa però, nel libro della Yourcenar, qualcosa di ancor più profondo: un’operazione morale. E in questo senso parlare di coincidenza tra grandezza e umiltà implica riconoscere che, laddove un romanzo è in grado di indicare le radici di una personalità, a qualunque ambito del politico essa appartenga, ha colto il suo mandato: mostrare che una psicologia non è nell’evidenza dei fatti in cui si esplica, ma prima di tutto nelle articolazioni che la caratterizzano interiormente. E qui la figura di Adriano, nella auto-rappresentazione che ne dà la Yourcenar, assume i tratti della figura paradigmatica: quella che rivela la propria grandezza proprio grazie all’umiltà da cui prende forma.
M.Yourcenar sulle Memorie di Adriano (intervista di Bernard Pivot, 1979)
Questi tre aspetti, che naturalmente non esauriscono i pregi del capolavoro della Yourcenar, riportano a un assunto che in qualche modo spiega perché tanto fascino Memorie di Adriano abbia suscitato nel corso dei decenni: che la verità di uomo va indagata, molto prima che nella sua esteriorità, nell’intimo delle sue più recondite fibre umane. E che laddove un uomo diventa simbolo e leggenda è perché ogni tratto della sua personalità era già in nuce un’anticipazione psicologica, animica, interiore e spirituale della sua parabola di leggenda. Insomma, il libro è a suo modo una archeologia dello spirito, laddove spirito dell’uomo e spirito della Storia coincidono e vita di un uomo e vita di un impero si ritrovano nella stessa essenza.