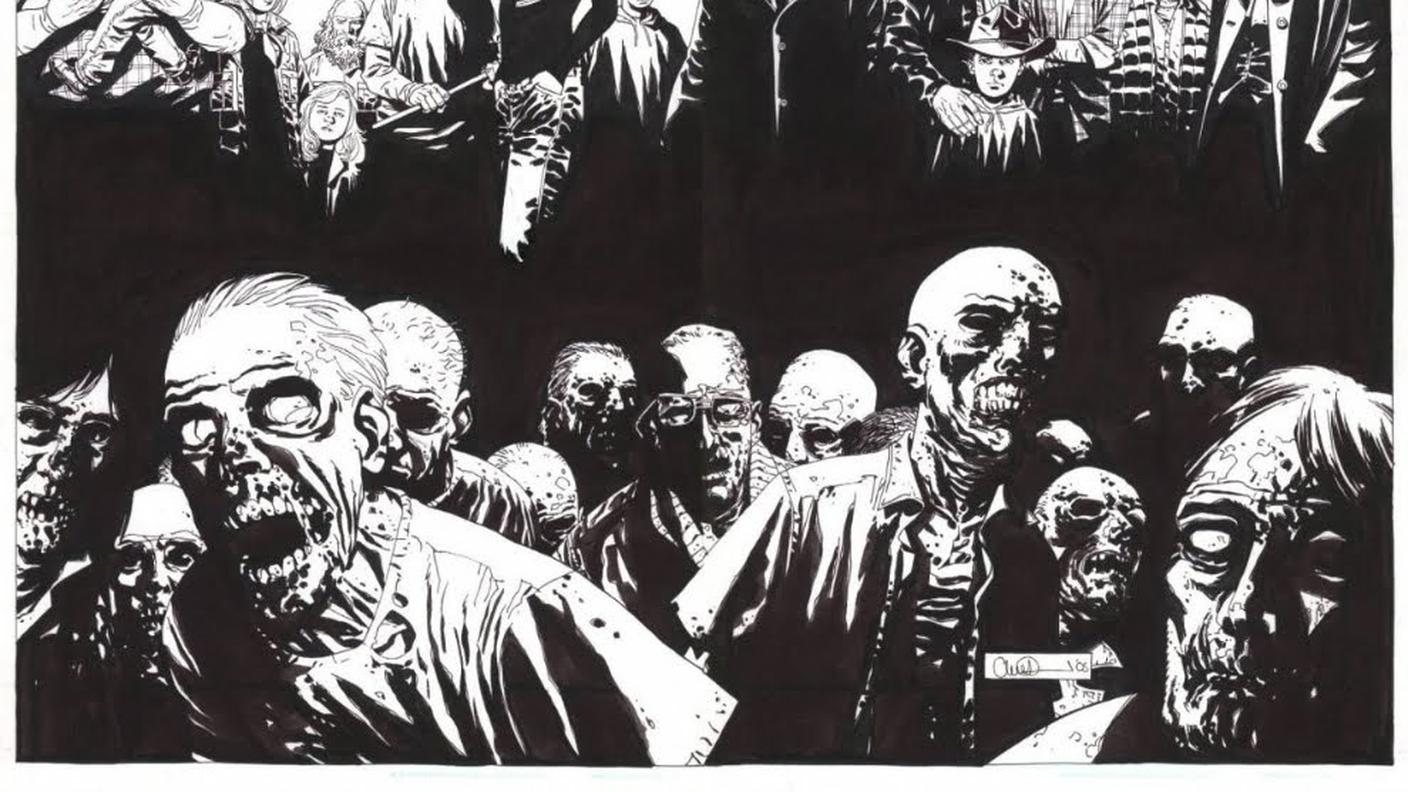Jhumpa Lahiri, nata a Londra da genitori bengalesi, cresciuta negli Stati Uniti, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2000 con la raccolta di racconti L’interprete dei malanni, ha insegnato scrittura creativa a Princeton e oggi al Barnard College della Columbia University. Dal 2012 ha iniziato a scrivere in italiano, lingua che ha abbracciato con passione e rigore, diventando anche traduttrice di autori italiani come Domenico Starnone.
Nel suo nuovo libro Perché l’italiano?, edito da Einaudi, Lahiri esplora il ruolo della traduzione nella sua vita e nella sua scrittura, motore di una metamorfosi linguistica e personale che ha raccontato a Alphaville.

"Perché l’italiano? Storia di una metamorfosi" di Jhumpa Lahiri, Einaudi
Cristina Artoni: Com’è nato questo amore per la traduzione?
Jhumpa Lahiri: Scrivendo questo libro mi sono resa conto che la traduzione è sempre stata parte della mia vita. Sono nata tra due lingue e due culture. Scrivere in italiano mi ha fatto riflettere su tutte le lingue che mi abitano. Tradurre è diventato un modo per completare ciò che faccio come scrittrice.
Cos’è Perché l’italiano? Un saggio, un’autobiografia, una riflessione…
È un libro difficile da definire. Racconta un periodo trasformativo della mia vita. È un libro sulla metamorfosi. Possiamo prendere questa parola, questo concetto, in quanto metafora della traduzione: è quello che succede quando vogliamo trasformare un testo in un’altra lingua. Ma è anche il percorso della vita, a essere per forza pieno di cambiamenti, di trasformazioni.
Un libro sulla traduzione, che è esso stesso tradotto. Un bel cortocircuito.
Perché l’italiano? raduna una serie di saggi che avevo messo insieme lungo l’arco di sette anni. Gli anni dopo il mio primo periodo a Roma, quando avevo già cominciato a scrivere in italiano, e avevo cominciato l’esperienza di tradurre dall’italiano, con il primo romanzo di Domenico Starnone. Questi saggi sono stati in parte scritti direttamente in italiano, in parte in inglese. Quando il libro è uscito nell’edizione inglese era già un testo bilingue, e avevamo anche messo in appendice un paio di saggi in italiano. Si tratta in qualche modo anche di un progetto collettivo, perché non c’è un solo traduttore, ce ne sono quattro. Che a molto a che fare con l’idea che la traduzione non è mai qualcosa di definitivo, è sempre un tentativo... sempre uno che prova, poi c’è un altro che dice: “ma forse questa cosa potremmo cambiarla...” e così via.
Lei racconta che, anni fa, le prime volte in cui ha provato a scrivere in italiano, ha avuto difficoltà perché, scrive, «L’inglese, come un ringhio inatteso, mi riafferrava con i denti». Come ha infine domato questa bestia?
Beh, perché poi il rapporto cambia... tutto, cambia. Appunto, di nuovo il filo rosso di questo libro. La metamorfosi. Anche il mio rapporto con l’italiano ormai è diverso... Ho avuto anche paura di lasciare l’Italia, avevo paura di tornare in America. Avevo paura di perdere la lingua e di essere subito fagocitata da un altro paese. Sono tornata in America con quella paura, che oggi non ho più, perché oggi mi muovo fra Stati Uniti e Italia con ritmo molto regolare. Non ho più quel tipo di titubanza.
Nel libro cita Antonio Gramsci. Cosa l’ha colpita, del suo rapporto con la traduzione?
Leggendo con attenzione le Lettere dal carcere appare chiaro il ruolo fondamentale della traduzione per Gramsci, come filosofo. C’è questa dimensione palesemente politica della traduzione: la rivoluzione vuol dire tradurre, trasformare, spostare, smantellare e ricreare. Questa è la traduzione, e anche la rivoluzione.
Lei riporta le parole del traduttore americano di Italo Calvino, William Weaver, che in un’intervista ha detto che era facile tradurre Calvino, perché scrive con un linguaggio letterario universale che si presta naturalmente alla traduzione. Ecco, lei è d’accordo? E quali sono le caratteristiche di un linguaggio letterario universale?
Credo che questa idea nasca dal fatto che Calvino non ha voluto appartenere al 100% a un solo idioma. Lui sfuggiva sempre a ogni categoria, come del resto ogni artista, e spero anche come ogni persona... Comunque, nel suo caso, tutta la sua formazione, il suo rapporto fortissimo con la letteratura e con la lingua francese, ha plasmato una lingua personale, priva di un baricentro linguistico specifico.
La chiusura della prima parte del libro è dedicata al suo progetto di traduzione dal latino all’inglese delle Metamorfosi di Ovidio, che lei descrive come «il sole». Quale luce le trasmette quest’opera?
Tutta la luce che serve per per vivere, per sopravvivere. Per me è proprio il centro di tutto. Ci trovi dentro tutto e di più, trovi il modernismo, il mondo arcaico, l’antologia, l’attualità... trovi l’oggi e anche ieri.
Il libro sembra suggerire che siamo anime complesse, in cui le influenze culturali possono stratificarsi, e tutti questi bagagli sono essenziali, li possiamo prendere o perdere... E questa riflessione arriva in un mondo in cui l’identità è di nuovo ritagliata dentro confini stretti, dove c’è molto patriottismo, ad esempio. Lei invece spariglia le carte, e suggerisce che le lingue che l’accompagnano siano di fatto strumenti di libertà.
Assolutamente. Le lingue sono una bussola per muoversi, non per trovarsi. La bussola che porti in giro per dire: ok, dove mi trovo? Però non per andare verso casa, perché non mi interessa. Non mi interessa il punto di origine, nella vita ci sono strati... è tutto molto stratificato, poi tornano elementi che pensavi di aver lasciato riposare, anche buttato. Invece poi ritornano, e questo è molto interessante.
Perché l’italiano?
Alphaville 26.06.2025, 11:45
Contenuto audio