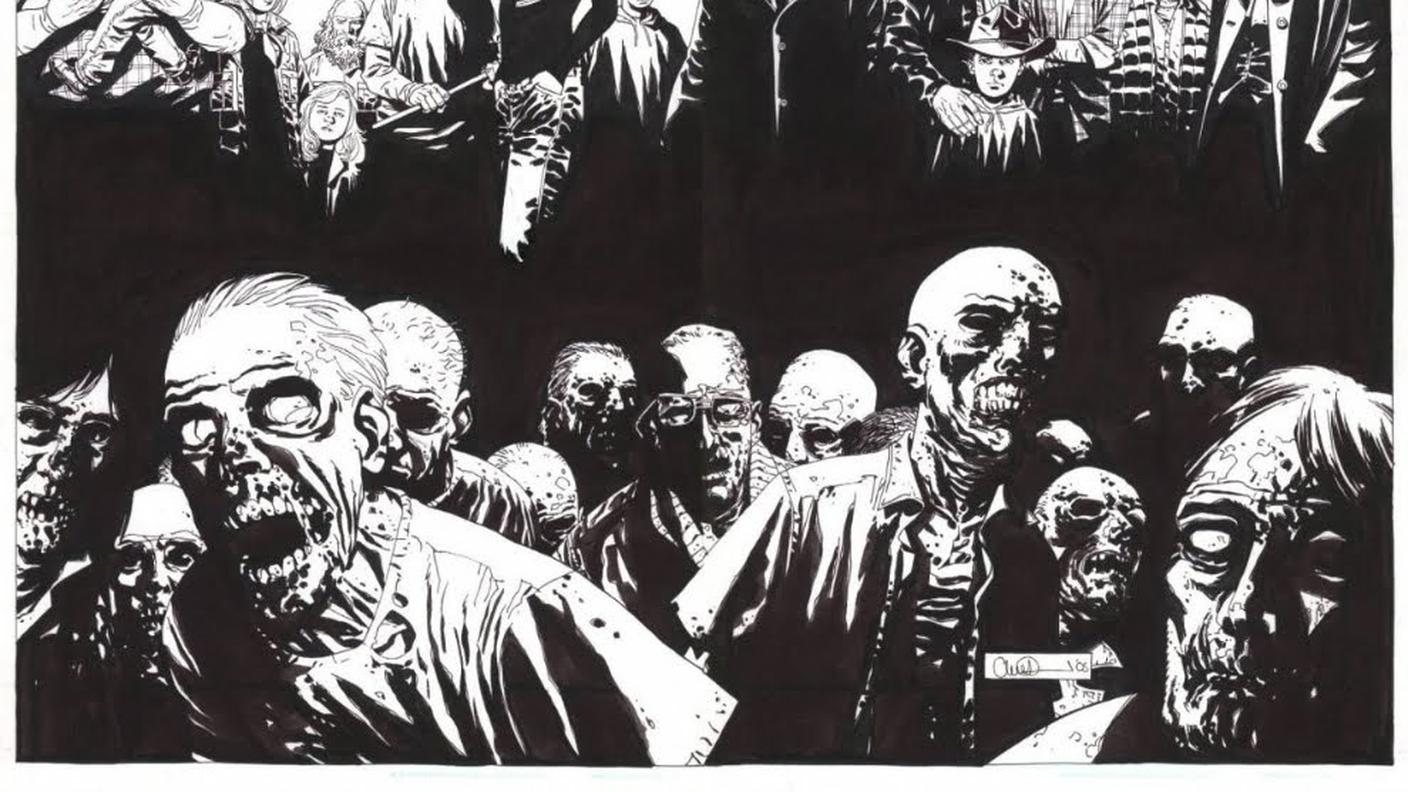Marco Lodoli è uno scrittore garbato, non ha mai tentato l’opera estrema. Si è sempre collocato in quel margine della letteratura dove il racconto – e lui è eminentemente uno scrittore di racconti – pretende di essere soprattutto un’espressione di riserbo, di sospensione, di elusione del giudizio.
Non fa eccezione il suo romanzo breve I fannulloni, che Einaudi propose quasi un quarto di secolo fa. Un libro tenero, gentile, a suo modo onirico, sicuramente poetico, in cui la sensibilità dell’autore – in un certo senso la sua empatia – si cala quasi in punta di piedi nelle vicende svelandole nella loro piccola irrealtà.
Dunque un autore coerente, se non altro con l’idea che un certo minimalismo formale può essere accompagnato (o preceduto) da un minimalismo ancora più emblematico: quello morale. Lodoli non cerca in effetti di strafare, di forzare la narrazione verso i piani alti della riflessione, di azzardare una Weltanshauung altrimenti che intimistica. Preferisce veleggiare sul mare quieto del quotidiano, con quel tanto di “vento immaginativo” che ne scuote la superficie. Preferisce non dire se non quanto appare alla sua sensibilità e al suo onirismo.
Per cui ecco dipanarsi, nei Fannulloni, una storia che, malgrado il titolo, rimane mille leghe al di qua di Fellini, ricordando semmai una arguta e compassata fiaba per bambini o, volendo essere generosi, un apologo alla Collodi o alla Calvino.
Siamo a Roma. Il vecchio pensionato Lorenzo raccatta tra i nullafacenti di Stazione Termini un giovane arabo di nome Gabèn, che per ironia della sorte (ma Lodoli forse non lo sa) significa “vigliacco”. E insieme, nonostante quel nome così poco congruo col personaggio, si avventurano nelle balordaggini più spericolate. Gabèn si improvvisa di volta in volta pugile, cantante, ambasciatore e quant’altro. E Lorenzo lo asseconda come ad assaporare i palpiti di un anarchismo, o di una spensieratezza giovanilistica, che aveva abbandonato da anni.
Morale? Secondo il nostro assunto – per il quale al minimalismo formale corrisponde, nei libri di Lodoli, quasi sempre un minimalismo morale – nessuna morale significativa traspare dal racconto. Siamo più modestamente – e l’umiltà è uno dei tratti caratteristici anche del Lodoli “maestro di periferia” – di fronte a un vecchio improbabile e a un altrettanto improbabile immigrato dall’Africa che si cimentano in non meno improbabili esercizi di ottimismo esistenziale.
Alla banalità della vita borghese, dei suoi schemi e delle sue restrizioni, si oppone così un’ansia di goliardia (in un certo modo altrettanto borghese) che si risolve in una spavalda e picaresca audacia di farsi valere contro ogni logica e ogni conformismo.
E fin qui Lodoli sembra non aver ricalcato se non la più elementare tradizione ludico-poetica che, da Boccaccio all’Aretino, passando per Calvino e Gadda, è giunta fino a Fabrizio Dentice e a Stefano Benni.
Senonché, oltre che epigono o gregario di questi autori – maestri del paradosso, dell’ironia e della comicità – Lodoli si è involontariamente fatto precursore di molti contemporanei: suggerendo, nel suo duplice minimalismo formale/morale, che la narrativa potrebbe avere un aspetto tanto più lodevole quanto più allusiva e meno critica, quanto più onirica e meno polemica.
E questa inconsapevole “lezione” rischia di essere una delle oscure origini di quella che potremmo chiamare, riferendoci al presente, letteratura sensazionalistica o letteratura a effetto: entrambe varianti di quella non-letteratura che si sarebbe tentati di far rientrare nel grande alveo della letteratura d’intrattenimento.
Se osserviamo la vicenda di Fannulloni da una prospettiva sociologica o culturalistica – o ancora meglio da un’angolatura critico-filosofica – ci accorgiamo infatti che i temi che vi sono ventilati sono tutti trattati con quel senso dell’esotico (diremmo dell’esotismo che ammicca alla banalità) che mutatis mutandis ha finito per permeare gran parte della non-letteratura attuale. Gabèn è un migrante, è un vagabondo, è un precario, è un senza fissa dimora, è un potenziale (e reale) ladro. In una parola, è tutto ciò che in un quadro di elementare evidenza corrisponderebbe alla realtà dei poveri clandestini che ciondolano per le nostre città. Ma Gabèn non appare, in Fannulloni, come espressione del disagio o della tragedia. Al contrario: prima ancora di essere totalmente irrazionalizzato, viene oleografizzato.
Egli è sotto sotto buono, egli è fantasioso e talentuoso, egli è una risorsa per tutti coloro che si sono rassegnati all’invecchiamento e alle regole sociali e anagrafiche della disillusione. Ma i migranti semplicemente non sono così. E i vecchi non sono come Lorenzo. E quel che accade nella realtà non è così candidamente edificante come nel libro.
Niente di male, si vive anche di fantasie e di sogni. E la poesia può anche limitarsi a innaffiare di poeticismo il dolore e l’emarginazione. Ma superato un certo livello di inverosimiglianza, putroppo, si rischia di spostare l’asse del comico dai suoi grandi significati metaforici e allegorici (come in Cervantes o Rabelais) a una temibile inclinazione alla irresponsabilità euristica, cioè a quella banalità dell’esotismo che più che insegnarci a riconoscere la realtà attraverso l’irrealtà o l’irrealismo, tale realtà la oleografizza fino a tradirla nella sua essenza.
Un “errore” letterario, se vogliamo chiamarlo in questo modo, che è diventato tanto diffuso da permeare quasi completamente quella non-letteratura il cui compito fondamentale si direbbe ormai ridotto a dimenticare la vita invece di illuminarla.