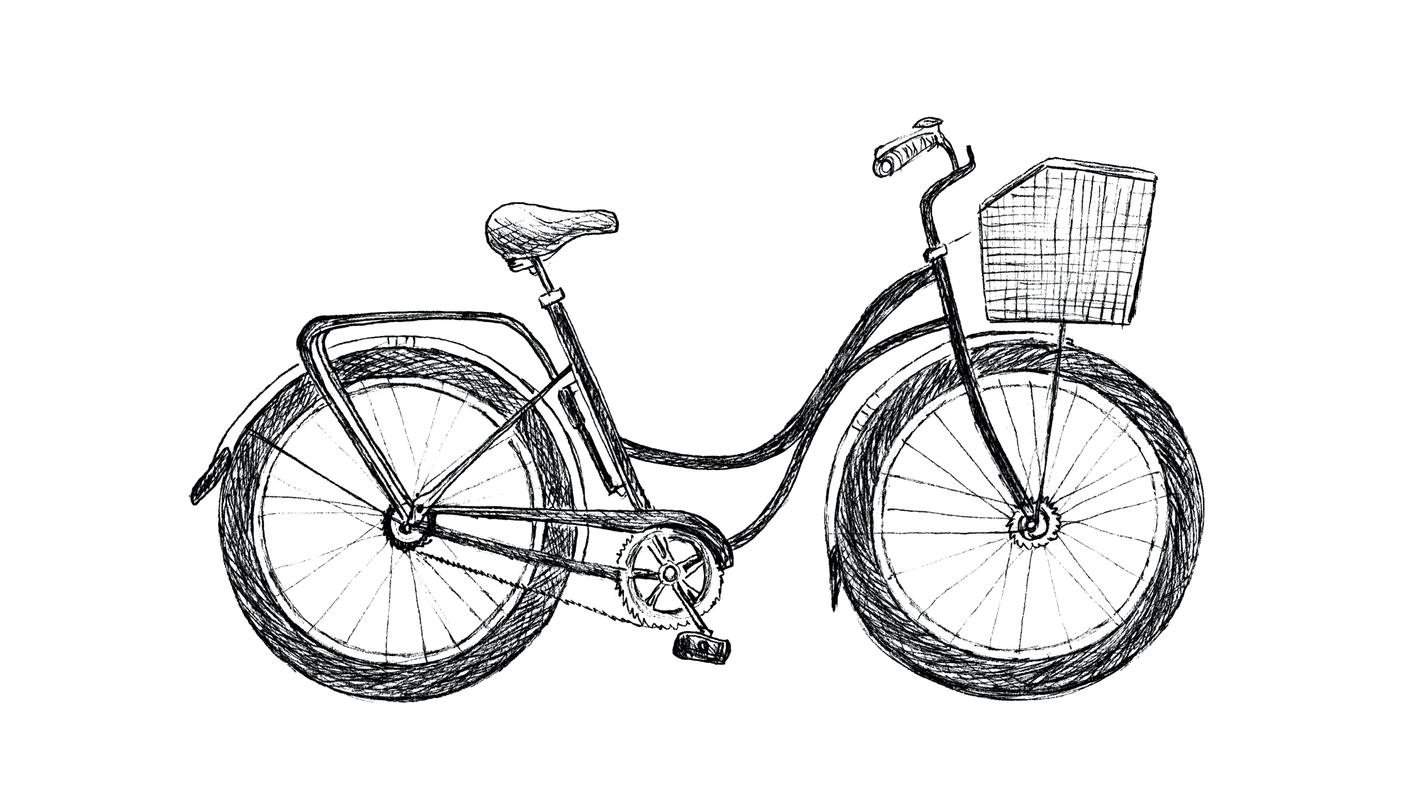È capitato molto raramente che un grande scrittore sia riuscito a condensare in una metafora, una frase oppure un apologo il senso complessivo della propria opera. Sicuramente non ci è riuscito un grandissimo come Thomas Mann, che negli ultimi anni di vita riassunse in questo modo il rapporto tra I Buddenbrook, il romanzo d’esordio pubblicato a soli 26 anni, e la restante produzione di quasi mezzo secolo: «Forse con quell’opera la mia “missione” si è esaurita, e mi è toccato solo di riempire in modo dignitoso e interessante il resto di una lunga esistenza. Con questo non voglio comunque sminuire, da ingrato, lo sviluppo che la mia stessa vita ha avuto dopo quell’invenzione giovanile». Il passo è contenuto in un saggio del 1948 dedicato alla genesi del Doctor Faustus, il più “disperatamente tedesco” (secondo le sue stesse parole) dei suoi romanzi tedeschi, ed è un tipico prodotto di quella falsa e menzognera modestia che si può forse perdonare - e di fatto si perdona- solo ai grandissimi.
Il caso di Ernst Weiss, medico e scrittore moravo di origine ebraica e lingua tedesca, grande amico di Franz Kafka, costituisce un’eccezione alla regola, proprio insieme a Kafka e al breve apologo intitolato Gli alberi, pensato originariamente nel 1905 nei giardini di Villa Carlotta, sul Lago di Como, ma poi riscritto e inserito nell’edizione dei racconti del 1913. Sono poche righe, ma di una bellezza davvero assoluta: «Perché siamo come tronchi nella neve. Posano leggeri, in apparenza, tu pensi di poterli smuovere con un lieve tocco. Invece no, non puoi, perché sono confitti al suolo. Ma, vedi, anche questa è soltanto apparenza».
Per quanto riguarda Weiss, la metafora è contenuta nel Boëtius von Orlamunde, un lungo racconto del 1928, noto anche col titolo Der Aristokrat (L’aristocratico), che riprende talune atmosfere de I turbamenti del giovane Törless di Robert Musil, Sotto la ruota di Hermann Hesse e Jakob von Gunten di Robert Walser. Il protagonista è l’ultimo discendente di una nobile famiglia, che viene educato in un collegio molto severo e ha la costante sensazione di vivere come un tuffatore nel preciso momento in cui si getta dal trampolino e rimane sospeso nel vuoto. La suggestione visiva è stata ripresa dai New Order, gruppo storico del rock elettronico anglosassone, i cui concerti si aprono con le immagini di alcuni tuffatori sospesi nel vuoto e il preludio de L’oro del Reno di Richard Wagner. Non deve stupire, perché il libro è molto conosciuto nei paesi anglofoni.
L’io narrante Boëtius von Orlamunde, pressappoco a metà del racconto, riferisce la sensazione del tuffatore in questi termini: «E’ importante, nei pochi secondi della caduta, mantenere l’equilibrio. Non bisogna perdere l’autocontrollo mentre si cade. L’altezza conta poco. Non molto diverso dev’essere il precipitarsi della Morte nell’universo vuoto, senza fondo, che si apre davanti a noi. E’ terribile accingersi al salto tremanti di paura, le gambe ti vengono meno e precipiti come un uccellino bagnato dalla pioggia. Il tuffatore pavido arriva giù tra i dolori più atroci e riceve dalla superficie dell’acqua una botta tremenda. Questo non deve succedere. Là dove l’animo non riesce, può arrivare la volontà».
L’esistenza nel tempo viene insomma paragonata a una continua caduta che non è possibile arrestare, ma forse è possibile controllare e modellare, trasformando la caduta stessa in una traiettoria parzialmente armoniosa, dotata di un senso o almeno di una Biegung, una “curvatura”, come dice l’io narrante riassumendo la metafora. L’opera narrativa di Weiss, che nei paesi di lingua tedesca è stata pienamente riscoperta soltanto in occasione del centenario della nascita, riproposta dal prestigioso editore Suhrkamp, mentre in ambito italofono è ancora in larga parte negletta o comunque sottovalutata, si presenta nel suo complesso come un’unica variazione su questa metafora: un continuo tentativo di “curvare” la caduta, imprimendole una direzione e uno stile. Viene da pensare al meraviglioso incipit di Passo d’addio di Giovanni Arpino: «La vita è stile o errore».
Nato il 22 agosto 1882 a Brno (Brünn, secondo la toponomastica germanica dell’Impero Absburgico), allievo di Freud, Ernst Weiss compì gli studi di medicina a Vienna, lavorò per un periodo a Berna ed esercitò la professione di chirurgo fino al 1920. Anche per lui, come per molti scrittori della sua generazione, il primo conflitto mondiale costituì una cesura molto netta e una ferita mai completamente rimarginata. Per quanto pacifista e sostenitore dell’internazionalismo, Weiss vi partecipò volontariamente come ufficiale medico sul fronte orientale, il teatro bellico più feroce e cruento, poi eternato nella celebre lirica Grodek di Georg Trakl col suo non meno celebre incipit: «A sera risuonano i boschi autunnali / d’armi letali, le auree distese / e gli azzurri laghi, e dall’alto il sole / rovina all’orizzonte, più oscuro; la notte abbraccia / guerrieri morenti, il furioso lamento / delle loro bocche in frantumi».
Come ufficiale medico, gli toccò tra l’altro -anche se la circostanza non è suffragata da prove incontrovertibili- di curare il soldato Adolf Hitler da una presunta cecità isterica causata da un’intossicazione da gas iprite, un evento che lo segnò profondamente e in seguito reinventò (o forse inventò, in una sorta di allucinata proiezione immaginativa) nella sua opera più famosa, il romanzo Il testimone oculare, scritto nel 1938 e pubblicato postumo nel 1963. Ha scritto Weiss, introducendo il personaggio riconducibile a Hitler: «Furono pochissimi quelli che cercai di studiare, di capire nel fondo della loro psiche, di curare in un modo o nell’altro, di guarire; tra questi, un cieco di guerra, agitato, snervato dall’insonnia, un caporale del reggimento bavarese List, di ordinanza presso il comando di reggimento, A.H.». Comunque sia, la figura e l’immagine di Hitler, con la diabolica capacità di «fare leva sulle tre caratteristiche fondamentali dell’essere umano: la bestialità, la debolezza e la viltà», come ha scritto in un altro passo de Il testimone oculare, lo accompagnarono e perseguitarono fino alla morte.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/Franz-Kafka--1829416.html
Mentre in Germania si stava preparando la salita al potere della canaglia nazista, Weiss lasciò la pratica medica, si dedicò interamente alla letteratura e scrisse una nutrita serie di romanzi e racconti apparentemente legati alle tematiche dell’espressionismo allora in voga, ma soprattutto tenuti insieme da un filo conduttore costituito dall’esplorazione impietosa delle zone più oscure dell’animo umano: “l’immondo grembo sempre gravido”, per riprendere un’espressione poi coniata da Brecht ne La resistibile ascesa di Arturo UI, che genera in continuazione dittature, totalitarismi, volontà di potenza e sopraffazione.
E’ all’interno di una simile prospettiva che vanno circoscritti e accostati romanzi non propriamente consolatori come Franziska, lo sconvolgente Animali in catene, ambientato nei sordidi bassifondi di Vienna, l’ancora più sconvolgente La prova del fuoco, storia di una progressiva riduzione al grado zero dell’umano che ha molti punti di contatto con La metamorfosi di Kafka, e infine Il testimone oculare, nel quale l’esperienza autobiografica -poco importa fino a che punto realmente vissuta- diventa la cifra simbolica di un’intera epoca e fornisce lo spunto per una profonda riflessione sulla “curvatura” dell’esistenza umana, sulle infinite casualità che si raggrumano e si coagulano nel destino individuale e collettivo.
Cosa sarebbe successo se un medico ebreo non avesse guarito il caporale A.H. del reggimento bavarese List? Per quale motivo la vittima può diventare carnefice, e viceversa? Dove finiscono l’innocenza e la colpa, e dove comincia l’espiazione? Cosa sarebbe successo, se… Il pensiero corre inevitabilmente a un romanzo come Contro-passato prossimo di Guido Morselli e alla cosiddetta “drammaturgia della casualità” (Was wäre, wenn…) di Max Frisch, due autori che hanno ripreso molte suggestioni contenute ne Il testimone oculare.
Per quanto Il testimone oculare rimanga un libro bellissimo e di straordinario impatto, il vero capolavoro di Weiss è forse il meno conosciuto Georg Letham, medico e assassino, pubblicato nel 1931. E’ la storia, raccontata in prima persona, del medico Georg Letham, patologo e batteriologo, che viene accusato di uxoricidio e inviato in una colonia penale nei Tropici, dove imperversa un’epidemia di febbre gialla. Il processo per uxoricidio si conclude con la condanna alla detenzione in una località non meglio precisata del Sud America, dove Letham lavora in un ospedale epidemiologico e propone di curare le malattie virali con un metodo molto originale ma altrettanto rischioso, che provocherà strane reazioni nei pazienti e metterà a dura prova la sua ritrovata (e forse solo apparente) umanità.
Più ancora che Il testimone oculare, il racconto della vicenda di Georg Letham è un’autentica discesa negli inferi dell’animo umano, che Weiss introduce con una serie di considerazioni che esprimono la sua scettica e disincantata visione del mondo: «All’uomo imperfetto non è risparmiato di assistere allo spettacolo assai più imperfetto della storia mondiale. Crudeltà e insensatezza: ecco i risultati della nostra esperienza, osservazioni che si ripetono fino alla noia, durante la breve parabola della nostra esistenza. E’ possibile serrare gli occhi al cospetto di questa sapienza essenziale? Eterna necessità dell’individuo, cui si oppone la spietata lotta di tutti contro tutti, sofferenza, dolore dell’anima, torture inenarrabili, accompagnate da una bruta forza cieca».
Nel 1933, quando la canaglia hitleriana si impadronì della Germania e la “peste bruna” cominciò pericolosamente a diffondersi, Weiss non poté che intraprendere la via dell’esilio e scelse Parigi, la capitale europea dell’emigrazione, dove visse alcuni anni di relativa tranquillità. Il suo amico ed estimatore Thomas Mann, con l’aiuto di Eleanor Roosevelt, era riuscito a procurargli un visto per gli Stati Uniti, ma evidentemente il ricordo e lo spettro di Hitler avevano scavato troppo a fondo nell’animo di Weiss, che si tolse la vita il 15 giugno 1940 in una squallida stanza d’albergo, il giorno dopo l’ingresso delle truppe tedesche nella capitale francese.
Tra le sue carte, insieme a Il testimone oculare, fu trovato un lungo racconto intitolato Jarmila, poi pubblicato negli anni Settanta. La vicenda ruota attorno al personaggio di Jarmila, una giovane contadina boema che scatena un vortice di passioni. Ma quella di Jarmila è in realtà una semplice storia nella storia, che si inserisce all’interno di un racconto più ampio e non privo di un’evidente spicco simbolico, anche perché è caratterizzato dalla costante presenza di un “orologio guasto” che segna “un tempo assurdo” in una Praga più che mai kafkiana.
L’immagine dell’orologio guasto che segna un tempo assurdo dice davvero tutto di Ernst Weiss. Non meno di Thomas Mann e dello stesso Kafka, ma senza l’elusiva e dubitosa fiducia di Mann nell’ironia e la quasi infantile passione di Kafka per un’assurdità che si sfrangia nel grottesco e nel ridicolo, anche in Weiss c’è la percezione di un totale sfasamento spazio-temporale: la “curvatura” non riesce a mitigare la caduta, la volontà non arriva “dove l’animo non riesce”. E’ precisamente per questo motivo che un altro suo ammiratore, Hermann Hesse, aveva detto di lui: «Conosce in tutta la sua profondità la malattia del nostro tempo», facendo eco proprio a Kafka, che lo aveva giustamente definito «uno scrittore straordinario».
Ernst Weiss, in effetti, è uno scrittore straordinario, tutto da riscoprire nella sua vibrante e talora sinistra attualità, ma anche nella sua dolorosa e in fondo eterna verità umana e poetica. Una verità che lo stesso Weiss ha plasticamente espresso in questo altro passo di Georg Letham, medico e assassino, che potrebbe trovarsi ovunque nelle sue opere ed esprime l’impossibile “curvatura” della caduta: «In questo mondo retto dall’ordine, chi riesce a penetrarne la ragione? Già, penetrarne la ragione, arrivare alla comprensione: ecco quel che si tenta dai primi giorni agli ultimi, senza mai venirne a capo».
Franz Kafka, “Il ponte”
Colpo di poesia 30.08.2021, 22:00
Contenuto audio