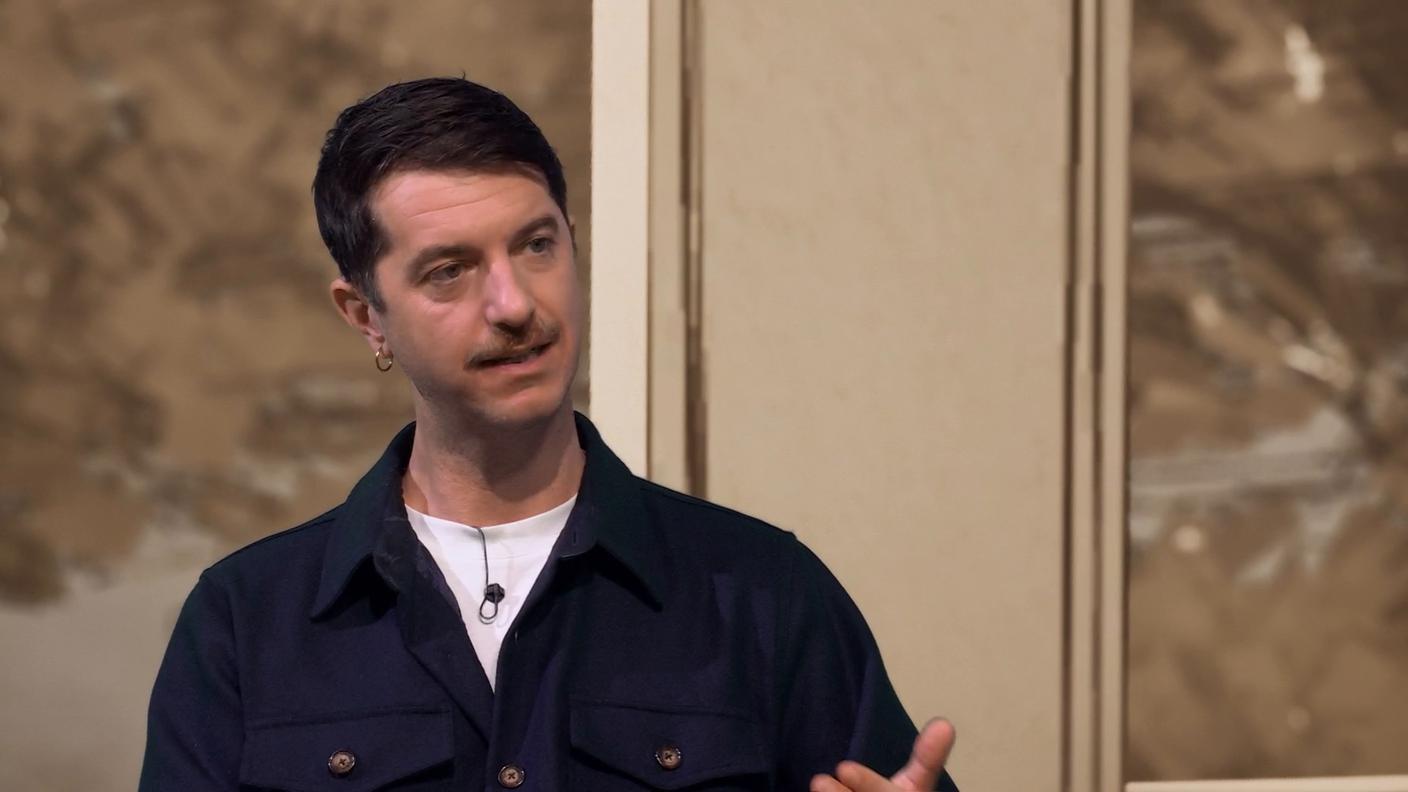Nel 2024 Valeria Roma ha esordito con il saggio Ignorare l’assenza. La letteratura palestinese nell’immaginario italiano (Meltemi Linee). Nel libro la studiosa non fa sconti; parlando di Pasolini, per esempio, ricorda di quando l’autore diresse il docufilm Sopralluoghi in Palestina per Il Vangelo secondo Matteo. Sottolinea come Pasolini vi sfoggiasse «un repertorio concettuale di chiara matrice coloniale e velato di paternalismo», semplificando anche il ritratto dei palestinesi come sottoproletari o «contadini irrimediabilmente legati a modi di vita arcaici».
Come evitare gli errori del passato? Mettendosi in ascolto. Benché l’Occidente non sia un campione in tal senso.
Narrativa palestinese
Proprio di voci silenziate parla la vicenda di pochi anni fa (2023) attorno al bellissimo libro di Adania Shibli, Un dettaglio minore. La scrittrice palestinese doveva essere premiata nel contesto della Fiera di Francoforte (forse il più noto evento librario per il commercio di diritti esteri, nonché incontro mondiale di addetti ai lavori). L’evento di premiazione slittò tra le polemiche. Adania Shibli aveva avuto l’ardire di nominare troppi tabù tutti assieme: il razzismo, il sessismo, la guerra, lo stupro e nello specifico lo stupro di guerra. Il romanzo è riuscito comunque a farsi ascoltare, e ha vinto il Booker Prize.
Premi librari e opportunità politica
Alphaville 17.10.2023, 12:35
Contenuto audio
In Un dettaglio minore siamo nel 1949, un anno dopo la Nakba, e un’adolescente palestinese viene catturata da soldati israeliani, violentata, uccisa e sepolta sotto la sabbia. Niente è più da scrittrice che il desiderio di disseppellire, invece. Per ogni silenzio c’è una voce che sussurra, un canto che preme per uscire - un libro. Un dettaglio minore sembra la risposta agli interrogativi che si poneva Hemingway sullo stupro di guerra, in Per chi suona la campana (nel corso di un dialogo delicatamente feroce tra il protagonista e una giovane donna).
Ma la letteratura palestinese non è solo trauma, è anche e soprattutto resistenza.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/Jenin-dentro-il-campo-profughi--2585802.html
Tra i contemporanei spicca l’opera di Susan Abulhawa, in particolare il suo Ogni mattina a Jenin.
Notevolissima la produzione di Mahmud Darwish: Una trilogia palestinese; Murale; Stato d’assedio; La saggezza del condannato a morte e altre poesie; Il giocatore d’azzardo; Il sogno dei gigli bianchi; Inni universali di pace dalla Palestina. Elogio dell’ombra alta; Undici pianeti; Come fiori di mandorlo o più lontano; Il letto della straniera; Una memoria per l’oblio; Oltre l’ultimo cielo. La Palestina come metafora; La mia ferita è lampada ad olio; Perché hai lasciato il cavallo alla sua solitudine?; Meno rose.
Darwish fu costretto all’esilio forzato, come un altro grande autore, Ghassàn Kanafàni. Tra gli scrittori rimasti in patria, Émile Habìbi. Tra le scrittrici, Sahar Khalìfah, Salem Salwa.
Non si può non menzionare Ibrahim Nasrallah, che ha vinto l’Arabic Booker Prize nel 2018. Oppure Odeh Amarneh e il suo Memoria di un ragazzo di serie B; e ancora, Liana Badr, con L’occhio dello specchio e con Le stelle di Gerico.
Poesia palestinese
La poesia palestinese merita poi un approfondimento a parte.
Si afferma come genere dominante dopo il 1948, e fin da subito emergono i temi del sumud, della resistenza. Come nella famosa Resteremo qui (Hunā bāqūn) di Tawfik Zayyad:
Resteremo qui
Noi custodiremo l’ombra del fico e degli olivi […]
Se saremo assetati spremeremo il deserto
E mangeremo polvere se avremo fame
Ma non ci muoveremo!
Qui abbiamo un presente, un passato e un futuro…
Tawfik Zayyad, Resteremo qui
Per aver fatto parte di festival poetici, Tawfik Zayyad fu arrestato. Successe anche ad Hannah Ibrahim. In carcere per la poesia, non smettevano di scrivere. È questo il caso di Rashid Hussein, che Mahmoud Darwish definiva “la stella” (Najm).
La letteratura palestinese non si lascia ingabbiare nella postura narcisistica della vittima e sa guardare oltre sé stessa, per un’alleanza internazionale, anticoloniale, tra resistenze.
Schietta e rappresentativa la poesia di Salem Jubran, che chiamava in causa l’ipocrisia di Jean-Paul Sartre: l’intellettuale era schierato da antirazzista sulla questione algerina ma connivente e silenzioso su quella palestinese.
Se un bambino venisse ucciso, e i suoi assassini gettassero
il suo corpo nel fango,
lei non proverebbe rabbia? Cosa direbbe?
Io sono un figlio della Palestina,
muoio ogni anno,
vengo ucciso ogni giorno,
ogni ora.
Avanti, guardi bene la varietà di nefandezze,
osservi ogni foto, ogni immagine
la meno orribile è quella del mio sangue che scorre.
Dica qualcosa:
Perché questa improvvisa indifferenza?
Allora, cos’è, non ha niente da dire?
Salem Jubran, A Jean-Paul Sartre
Vale la pena ricordare anche Rafeef Ziadeh che, nel 2011, in risposta a un giornalista che le aveva chiesto perché i palestinesi «insegnassero l’odio ai loro figli», scrisse la poesia Noi insegniamo la vita, signore (“We teach life, sir”), e la recitò a Londra:
Oggi, il mio corpo era un massacro trasmesso in TV.
Oggi, il mio corpo era un massacro che doveva stare dentro frasi ad effetto e un numero limitato di parole.
Oggi, il mio corpo era un massacro trasmesso in TV che doveva stare dentro frasi ad effetto e un numero limitato di parole pieno di statistiche per replicare con risposte ponderate.
E così ho perfezionato il mio inglese e imparato le risoluzioni ONU.
Eppure, mi ha chiesto: “Signora Ziadah, non crede che tutto si risolverebbe se solo smetteste di insegnare tanto odio ai vostri figli?”.
Pausa.
Cerco dentro di me la forza per essere paziente, ma la pazienza non è esattamente quello che ho sulla punta della lingua mentre le bombe cadono su Gaza.
La pazienza mi ha appena abbandonato.
Pausa.
Sorriso.
Noi insegniamo la vita, signore.
Rafeef ricordati di sorridere...
Pausa.
Noi insegniamo la vita, signore.
Rafeef Ziadeh, Noi insegniamo la vita, signore.
C’è poi Remi Kanazi, classe 1981, cresciuto negli Stati Uniti e quindi influenzato da una serie di tendenze contemporanee della miglior poesia antirazzista (si pensi alla grande Warsan Shire): un ritmo che ricorda l’hip hop, martella e interpreta le commistioni di luogo, di temi, di forma. Nella poesia Nakba, Remi Kanazi dice:
lei non aveva dimenticato
noi non abbiamo dimenticato
noi non dimenticheremo
nelle vene radici
di ulivi
torneremo
non è una minaccia
né desiderio
speranza
o sogno
è una promessa
Remi Kanazi, Nakba
Se i poeti palestinesi hanno scritto e sono stati arrestati, e in carcere hanno scritto ancora, c’è perfino chi è sembrato vivo, vivissimo, anche nella morte. È il caso della voce di Refaat Alareer, che ancora riecheggia nella sua If I die. Docente di letteratura all’università islamica di Gaza, scrisse infine in inglese per necessità di farsi comprendere anche nei luoghi in cui certe voci s’è tardato ad ascoltarle.
Se io dovessi morire
tu devi vivere
per raccontare
la mia storia
per vendere tutte le mie cose
comprare un po’ di stoffa
e qualche filo,
per farne un aquilone
(magari bianco con una lunga coda)
in modo che un bambino,
da qualche parte a Gaza
fissando negli occhi il cielo
nell’attesa che suo padre
morto all’improvviso, senza dire addio
a nessuno
né al suo corpo
né a se stesso
veda l’aquilone, il mio
aquilone che hai fatto tu,
volare là in alto
e pensi per un attimo
che ci sia un angelo lì
a riportare amore
Se dovessi morire
che porti allora una speranza
che la mia fine sia una storia!
Refaat Alareer, Se dovessi morire
Refaat Alareer è stato ucciso a dicembre 2023, a 44 anni, da un aereo israeliano. La sua fine è stata una storia, ce lo aveva detto. Non perché sapeva che sarebbe morto, ma perché ha scelto quel che poteva scegliere: una dignità che sa riecheggiare per molto più tempo della violenza delle bombe. Non è stato, e nessuno dovrebbe essere mai, un dettaglio minore.