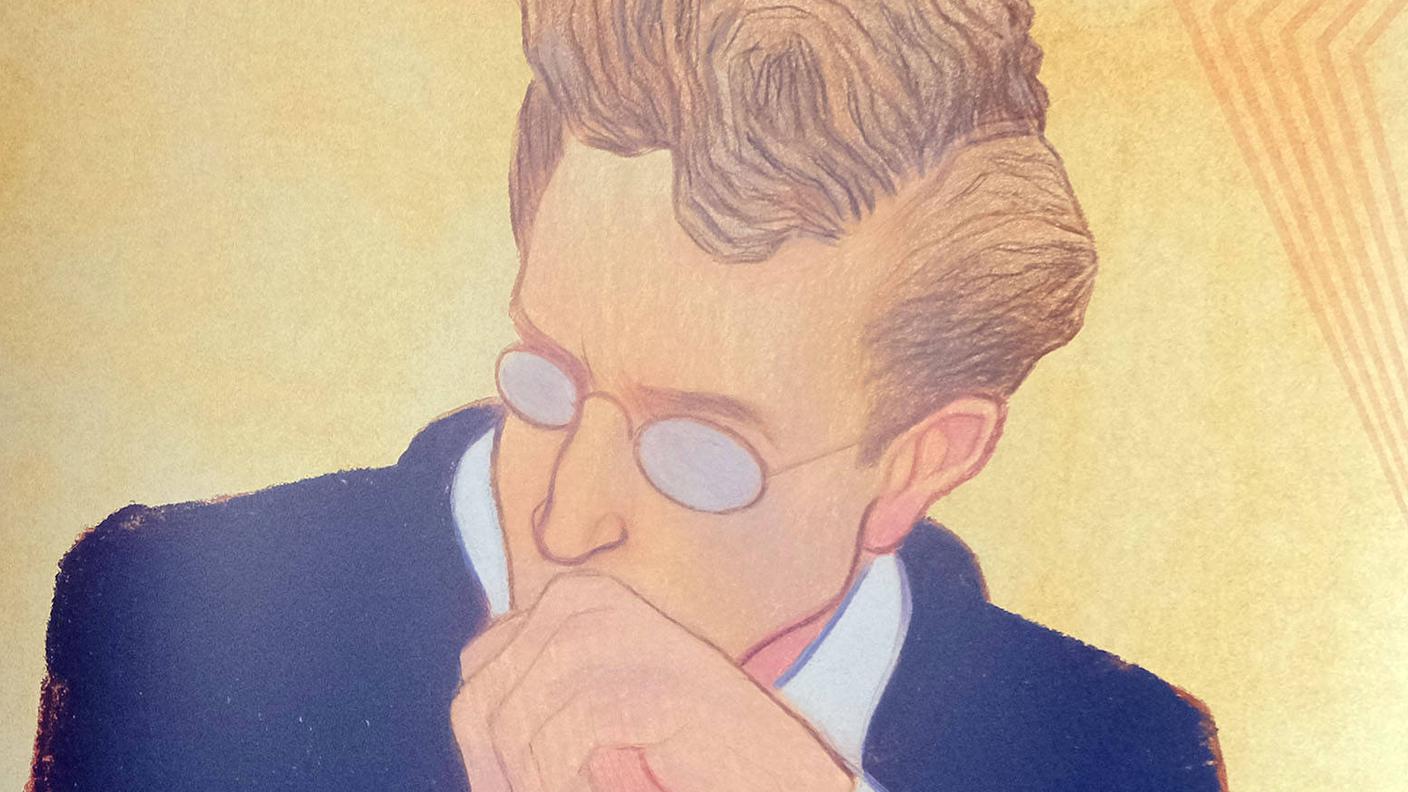Lukas Bärfuss ha fatto dell’autofiction uno dei suoi punti di forza, alla stregua di illustri contemporanei come Emmanuel Carrère. Ma se nello scrittore francese questa è finalizzata al racconto della realtà in maniera prettamente narrativa, investigativa e fascinante, nell’autore di Hagard, Koala e Il cartone di mio padre (per menzionare gli ultimi tre, pubblicati nei bei volumi dell’Orma editore), l’autobiografia si unisce al saggio storico, alla filosofia, a un attivismo politico severo, e comunque a una revisione.
Quel che accade con lo scrittore svizzero infatti è che dalla sua vita (tutto fuorché banale) ci fa poi volare lontano – in Amazzonia o nell’Impero Romano – per riuscire a comprendere almeno un po’ le complessità dell’uomo contemporaneo. E se in Hagard e Koala l’essere umano è rappresentato da animali selvatici simbolo di libertà – libertà di essere selvaggi agendo in Hagard, e libertà di essere pigri rinunciando in Koala – ne Il cartone di mio padre, il mondo naturale lascia il posto a quello degli oggetti, delle cose.
"Il cartone di mio padre" di Lukas Bärfuss, L'Orma Editore (dettaglio di copertina)
Il cartone in questione è uno scatolone da traslochi, quello delle banane, ed è l’eredità del padre del protagonista (che corrisponde a Bärfuss stesso per gran parte del personaggio). Eredità che l’uomo, in 25 anni, non ha mai aperto o voluto aprire. Forse perché ingombrante, ma forse anche perché finora ha sempre fatto – felicemente o meno – senza. Parliamo infatti di un padre assente, vagabondo, incorreggibilmente bugiardo, spiantato e reietto.
Questo è il punto di partenza del romanzo: un incontro, una resa dei conti con un cartone che è il passato, dell’autore e di molti. Arriva per tutti il momento in cui bisogna fare pulizia, aprire scatole e vasi ben nascosti negli anfratti delle nostre case, sopravvissuti a traslochi e rinnovi, e farci, appunto, i conti.
Il romanzo, soprattutto, è occasione per Bärfuss di una profonda riflessione sull’eredità, ma anche sull’ossessione dell’origine e le conseguenti ingiustizie sociali, attraverso Darwin e Levi-Strauss, le cui idee ne L’origine della specie e Storia della famiglia vengono passate al setaccio e smontate. La riflessione ruota intorno al concetto secondo il quale la discendenza e l’origine determinano in larga misura la nostra felicità nella vita, denunciandone il meccanismo. Questo porta l’autore a un’avversione totale per l’origine, e in generale per l’ossessione di definirsi attraverso i propri antenati.
Rapporti di potere e status sociale sono inevitabilmente, nella nostra società, determinati dai nostri antenati; sono le origini nazionali, culturali e famigliari a determinare i privilegi, e quel che è peggio è che queste appartenenze sono regolamentate anche dalle leggi. Ma questa ingiustizia non è una legge naturale, anzi, è il frutto di una narrazione scorretta e soggettiva, che ha fatto breccia nella Storia e oggi si è radicata nelle nostre menti a tal punto da diventare verità.
Premiato lo scrittore Lukas Bärfuss
Telegiornale 09.07.2019, 22:00
Chi racconta la Storia sono di solito i vincitori e mai i vinti, a loro quindi il compito e l’onore di comporre un passato a loro guisa, inventando anche di sana pianta. Così come fece Giulio Cesare con il concetto di germano, che in realtà non è mai esistito prima, e che tuttavia resiste se ancora oggi si dice Studi di germanistica.
Darwin è stato colpevole poi, nella sua Origine, di sottolineare come la concorrenza vinca sulla collaborazione, ma se si vuole cambiare il mondo si dovrebbe pensare una dimensione cooperativa della società.
Bärfuss non fa sconti alla civiltà occidentale che da sempre si crede superiore («un Olimpo verso il quale tutti anelano e respirano»), si interroga con estrema lucidità sulla crisi di questo modello e ne demolisce alcuni concetti fondanti, come la proprietà privata e le sue disastrove derive.
Il pensiero critico di Lukas Bärfuss è spietato e deciso, a tratti disturbante, ma lucido e necessario.
Forse nasce dalla sua storia famigliare, forse da un’analisi della Storia dell’Occidente alla luce di quanto accade nel mondo (guerre e crisi climatica, per dirne due), fatto sta che questo pensiero critico lascia una speranza per il futuro, un margine di manovra, una possibilità d’azione – rinnegare i padri, pensare orizzontale – e di parola – la comunicazione e la lingua sono qui fondamentali – che non sempre leggiamo in questa epoca catastrofica e catastrofata. La sua visione è ironica: per parlare dell’aderenza da ritrovare tra leggi e realtà afferma che viviamo in una società che ha a cuore la proprietà privata ma non conosce il concetto di spazzatura privata, a differenza di sua nonna, che di spazzatura non ne produceva.
E visto che abbiamo scomodato la nonna, torniamo all’autofiction, raccontando parte della biografia di Lukas Bärfuss, il cui passato non si discosta molto da quello del protagonista de Il cartone di mio padre. Quando aveva quattro anni, infatti, i suoi genitori divorziarono: la madre aveva lasciato il padre perché non più entusiasta di avere un marito criminale, e aveva deciso di crescere il piccolo Lukas da sola.
Bärfuss da adulto dichiarerà che la famiglia è formata soprattutto da figure elettive esterne, persone che si amano e che ci formano, ma che non per forza devono essere i nostri genitori. Insomma, secondo l’autore, oggi non serve avere un buon rapporto con la madre per essere cresciuto in maniera amorevole.
Lo stesso vale, racconta la sua storia, per l’eredità. Quella che ne segnò positivamente il suo destino fu inconsapevole e casuale. Una sera mentre portava a spasso il cane all’età di otto anni, gli operai che stavano svuotando l’appartamento di un uomo defunto gli regalarono un’enciclopedia in 25 volumi. Lukas scoprì il potere dei libri, e imparò tanto, che a dir suo la scuola gli divenne infernale. Mentre ciò che venne dopo, la vita per strada, fu vera libertà. Se ne andò di casa a 15 anni, visse di espedienti e divani, sfuggendo al controllo dei servizi sociali. Quel che gli mancava di più, paradossalmente, erano proprio i libri, che trovava nella biblioteca comunale. Passò attraverso diversi impieghi – rappresentante di tabacco, giardiniere – e una volta assunto come libraio (dove vivere, se non tra i libri?) iniziò a scrivere per il teatro, arrivando rapidamente al successo.

Promuovere la traduzione
Moby Dick 13.09.2025, 10:00
Contenuto audio
Commentando una delle frasi finali del romanzo, «La mia origine resta incerta, non potrei esserne più felice», Bärfuss ha spiegato – in occasione del suo incontro con il pubblico a Babel 2025 – che tutti siamo una massa di bastardi, siamo materia viva. E soprattutto, non sappiamo tutto. La storia di qualsiasi famiglia viene infatti tramandata al suo interno in maniera vincente: si mitizza il passato, si nascondono i fatti scomodi. Riflettere quindi sulle proprie origini è un’occasione per reinventarsi, perché «non è la famiglia a fare di noi ciò che siamo!».