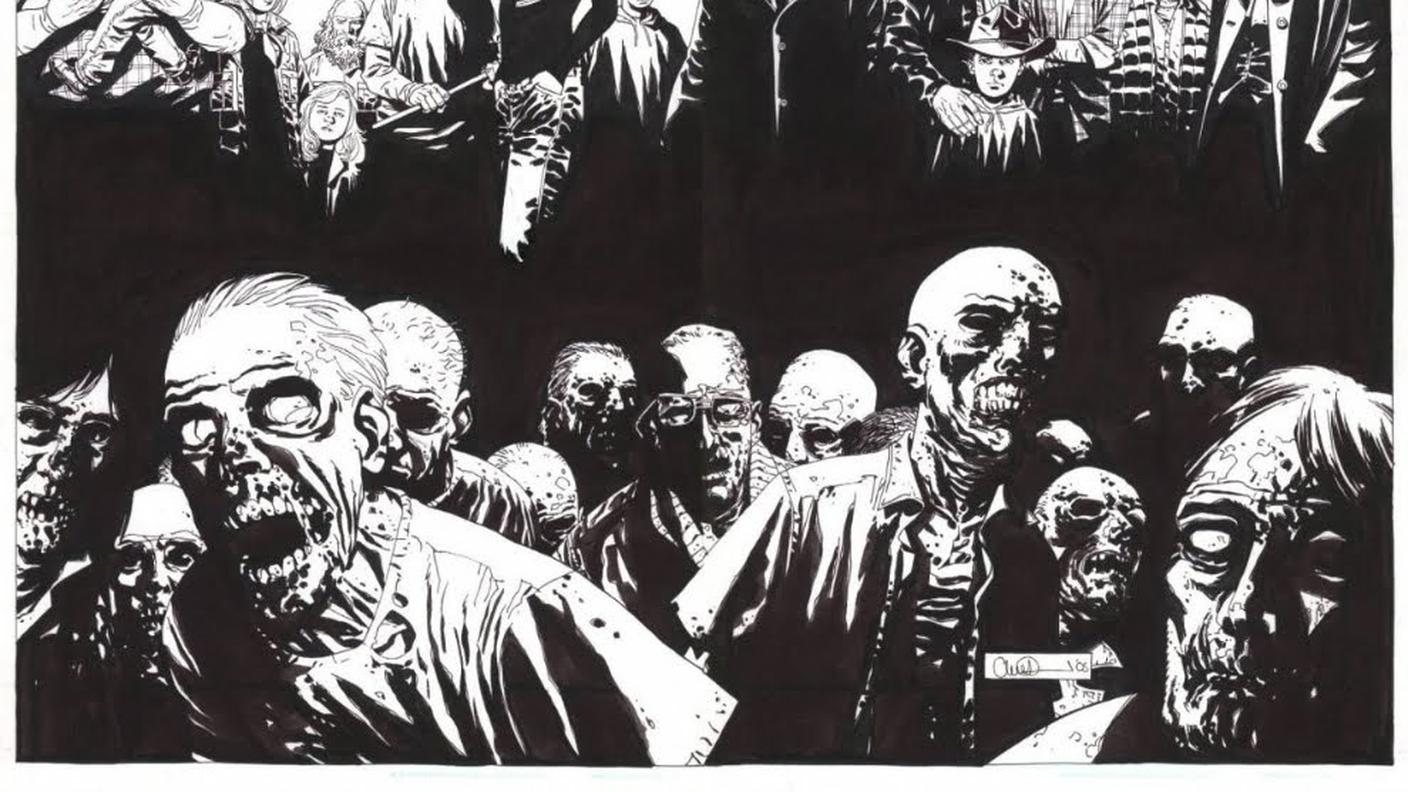È un romanzo curioso, quello che Paolo Di Paolo ha scritto per dissezionare i giochi segreti della memoria, i suoi tranelli, le sue invenzioni: Romanzo senza umani. Curioso perché scritto su registri tra loro molto diversi, che in un certo senso spiazzano continuamente il lettore. Si passa da una lingua molto alta, letteraria, a tratti persino elegiaca, a un linguaggio estremamente piano, da romanzo pop, in cui a farla da padrone è quasi sempre il dialogo più stringato ed essenziale.
Ma curioso anche perché, nella sua composizione frammentaria, nel farsi a tratti ermetico ed enigmatico del discorso, costruisce una singolare corrispondenza tra un evento geologico storicamente datato e le insondabili intermittenze della memoria, sia del protagonista che dei deuteragonisti che gli ruotano intorno.
Quale evento geologico? Il protagonista – uno storico di nome Mauro Barbi, che decide di ritornare sui luoghi di quell’evento – ce ne parla dapprima solo per vaghe anticipazioni e solo in seguito con maggiore dovizia di dettagli. Si tratta della glaciazione del Lago di Costanza del 1572, dovuta a un cambio repentino di clima, a un raffreddamento improvviso quanto inesorabile.
Ora, cosa c’entra un lago ghiacciato, per di più di cinque secoli fa, con le intermittenze della memoria e in genere con la nostra vita personale di contemporanei? È in questa sottile corrispondenza che Di Paolo costruisce la sua narrazione. Il nesso non è infatti immediato né scontato, ma in qualche modo è anche irrecusabile: come può giungere a glaciazione – diciamolo chiamo, come può letteralmente scomparire – un immenso bacino d’acqua per opera delle mutazioni climatiche – ovvero per opera di una manifestazione fisica del tempo – così può letteralmente scomparire, o quanto meno mutarsi drasticamente, il ricordo degli altri nei nostri confronti, ovvero la memoria che essi serbano di noi e che noi serbiamo di loro.
Si potrebbe dire: il tempo può portare a glaciazione le cose, ma anche i ricordi.
Ed è quello che accade appunto nel romanzo di Di Paolo, che lungo tutto il suo percorso sembra in definitiva echeggiare sempre la stessa domanda: che cosa rimane di noi, dopo anni o decenni, nel pensiero altrui? Ovvero: come funziona la memoria?
È una domanda che non a caso induce Paolo Di Paolo a rievocare il grande scrittore Javier Marìas, che a proposito di questa stessa memoria diceva: Non esiste nessuna memoria collettiva, l’unica memoria esistente è quella individuale.
In effetti la cosiddetta memoria collettiva è più che altro un auspicio, un desiderata: il dispiegarsi dentro di noi del passato è viceversa un fenomeno personale, individualissimo, soggetto a mille condizionamenti, a mille rielaborazioni, a mille tranelli del pensiero e del sentimento. Tanto che alla fine è inesorabile domandarsi, come fa Barbi: Cosa ricordano gli altri di noi?
Lo storico, in genere – e Mauro Barbi in particolare – si ritrova così, dopo aver maneggiato per tutto il tempo il passato, anche quello più remoto, delle antiche glaciazioni naturali, a doversi misurare con un presente che da quel passato prende forma. E paradossalmente proprio da questo balzo dalla lontananza alla vicinanza, dall’incognito al noto, dal remoto al presente, qualcosa di fondamentale si perde: il passato non rimane, il passato si sbricola, la sua apparente e fluida capacità di protrarsi al di là di se stesso si gela. E a noi arrivano solo scampoli ormai quasi inservibili alla nostra vita.
Gli stessi scampoli che Barbi cerca di recuperare da mail inviate quindici anni prima, ma che inesorabilmente gli restituiscono solo frattagli e immagini, parole e gesti (e persino persone) che con quelle frequentate e magari amate in passato non hanno sostanzialmente quasi nulla a che vedere.
Romanzo senza umani è allora un romanzo delle perdite irrimediabili, un romanzo a suo modo proustiano, in cui – là attraverso una madelaine, qui attraverso un lago ghiacciato – passato e presente si offrono a uno strano fenomeno: nello stesso modo in cui si riuniscono e si fondono e confondono... si perdono.
E come si intrecciano, fondono e confondono i tempi e le persone, i ricordi e la loro dissoluzione, così nel romanzo di Di Paolo si sollevano e inabissano nella memoria nomi di autori, personaggi storici, libri e personaggi letterari che hanno costellato il passato di Barbi: quasi a ribadire che nemmeno nel solido, rassicurante mondo della parola scritta – o diciamolo pure, della Storia scritta una volta per tutte – si può mai dire che sia stata fissata nel tempo e nello spazio (e soprattutto nella memoria) e dunque scritta una volta per tutte.
Romanzo della nostalgia, saremmo tentati di definirlo, Romanzo senza umani è certamente un romanzo – in flagrante contraddizione con il titolo – pieno di umani. Ma in pari tempo non lo è affatto: perché gran parte di questi umani non lo sono più, sono dissolti in una nebulosa lontana, vaga e inafferrabile, sono diventati quasi non umani, ovverossia si sono congelati, perdendo la loro natura di esseri viventi e tramutandosi in vestigia della perdita. Quindi, se il titolo è apparentemente contraddittorio, allude infine a una dissoluzione del ricordo che fa degli umani la loro fatale negazione.
“Romanzo senza umani”
Alice 28.10.2023, 14:35
Contenuto audio
“Alice” in diretta da Soletta
Alice 31.05.2025, 14:35
Contenuto audio