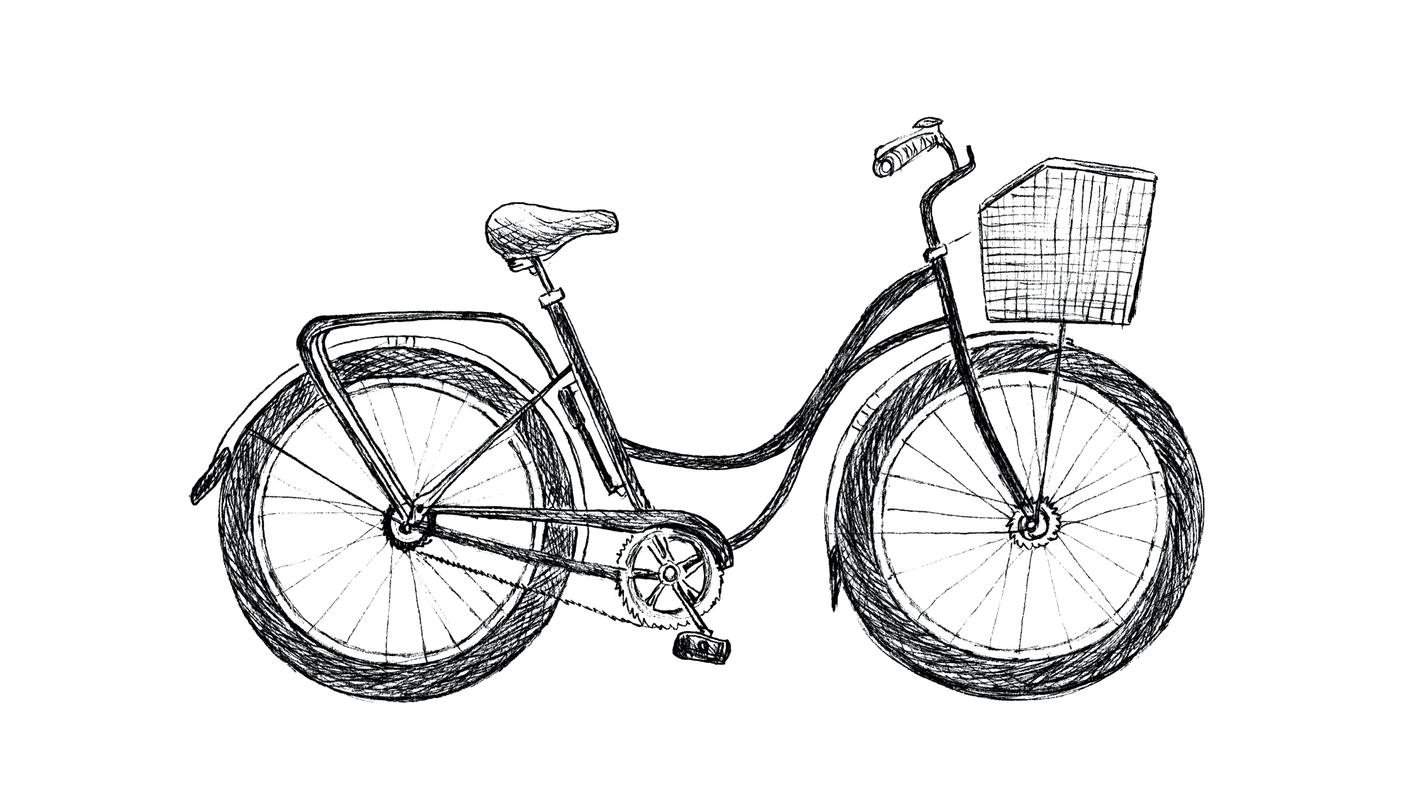Potrà sembrare un paradosso, ma la definizione più bella e centrata dell’originalissima poetica di Silvio D’Arzo non è stata fornita né dall’autore stesso, né dai molti studiosi che dopo la morte prematura (nato nel 1920 a Reggio Emilia, Ezio Comparoni -Silvio D’Arzo fu il più utilizzato tra i suoi tanti “nom de plume” come narratore e saggista- morì di leucemia a soli 32 anni nel 1952) hanno contribuito alla riscoperta e alla giusta valutazione della sua opera, che nel panorama complessivo del Novecento italiano, più nello specifico nel contesto letterario dell’immediato dopoguerra e del nascente neorealismo, fornisce davvero l’impressione di un meteorite proveniente da chissà dove.
La definizione è contenuta infatti in una cortese ed elegante lettera di rifiuto di Aldo Garzanti, l’editore al quale il giovanissimo D’Arzo, nel 1942, aveva proposto la pubblicazione di alcuni racconti e romanzi, tra i quali l’incompiuto (ma nel senso nobile e “schubertiano” del termine) “Essi pensano ad altro”, che come gran parte della sua opera venne pubblicato postumo. Dopo averne elogiato il «non comune modo di scrivere e la felicissima espressione artistica», Garzanti si addentra nel nucleo della poetica di D’Arzo e rileva alcuni sostanziali difetti: «Il vostro continuo dissolvere ogni affermazione di vita nel suo opposto, nel non essere, crea una martellante e ossessionante allucinazione. Il lettore spinge avanti lo sguardo con la speranza che questa nebulosità sfoci nell’azione risolutrice e risanatrice, ma le pagine continuano inesorabili il loro tormento, senza che giunga, come un riposo, il colpo d’ala liberatore».
Dissoluzione, allucinazione, nebulosità, pagine inesorabili: i termini e le espressioni utilizzati da Garzanti individuano alla perfezione il tratto distintivo del mondo poetico del giovanissimo scrittore. Ma è necessario rovesciarne la valenza, perché sono proprio la sospensione, il non detto, l’approccio dubitoso ai dati del reale, il rifiuto della “religione dei fatti” e il sospetto (ricavato dai romanzi dell’amatissimo Henry James) che tutto sia come una chiacchiera distratta in un “salotto al crepuscolo”, la continua e irrisolta dialettica tra le varie istanze della vita (quelle che la liberano ma la dissolvono e quelle che la sostanziano ma la irrigidiscono) e infine la mancanza del «colpo d’ala liberatore» a fare la grandezza e l’originalità della produzione narrativa di Silvio D’Arzo. Era certamente difficile capirlo a suo tempo, in una stagione culturale sfociata inevitabilmente nel neorealismo e nel tentativo di fissare nuove coordinate esistenziali. Adesso, invece, ormai consapevoli che il celebre “mot juste” flaubertiano è un’irraggiungibile utopia, risulta molto più facile, quasi naturale. Perché non ci è più dato di credere nell’«azione risanatrice e risolutrice» né nel «colpo d’ala liberatore».
E’ principalmente per questo motivo che Silvio D’Arzo ci sembra oggi molto più attuale rispetto ad altri pur grandissimi autori dell’epoca, che senza dubbio gli furono superiori per consapevolezza letteraria e intrinseca qualità di scrittura (basti pensare agli “astratti furori” di Elio Vittorini, ad esempio, oppure a Cesare Pavese, solo per citare i due nomi più importanti).
Uno scrittore del rango di Gianni Celati, che gli è particolarmente vicino e affine non solo per motivi geografici, ha espresso in maniera molto penetrante l’attualità delle opere maggiori di D’Arzo, il già ricordato “Essi pensano ad altro”, l’altro romanzo “All’insegna del Buon Corsiero” e soprattutto il racconto “Casa d’altri”: «D’Arzo ci comunica l’idea che il mondo sia una scena dove ci si sente come in casa d’altri, o come in una camera d’affitto dove niente ci appartiene, perché si è prodotta una frattura nel modo di interiorizzare i luoghi per sentirli “nostri”. L’illusione che esista un territorio davvero “nostro”, ai nostri tempi esiste solo come retorica di una ascesa sociale, arma pubblicitaria nell’anonimato di massa. L’adesione a un luogo, ora, si dà piuttosto come esilio in uno spazio separato, dove si affronta la faticosa esperienza di essere individui. Il che significa che il nostro posto è soltanto là dove si è capitati per caso, “come altri abitano una stanza d’albergo”».
Lo scrittore e “lettore di provincia” Comparoni alias D’Arzo (lo pseudonimo proviene dall’aggettivo dialettale “arzan”, “reggiano”) deriva questa percezione della vita come esilio da Baudelaire, che vedeva il tipico carattere della modernità nel sentimento di vivere sempre da estranei, come dispersi nel «grande deserto degli uomini», e dai grandi narratori anglosassoni come Conrad, Stevenson e il già ricordato Henry James, che hanno tradotto in nuove forme narrative la concreta e insieme simbolica esperienza del vivere come esilio e straniamento.
“Essi pensano ad altro” e “All’insegna del Buon Corsiero” rivelano un talento incredibilmente precoce e la capacità di gestire con superiore maestria una trama estremamente complessa, densa di rimandi, allusioni, raffinate e talora inquietanti simbologie (il diavolo funambolo in “All’insegna del Buon Corsiero”). Ma l’autentico capolavoro, proprio perché riassume tutti i limiti segnalati da Aldo Garzanti, è senza dubbio “Casa d’altri”, uscito qualche mese dopo la morte dell’autore. Eugenio Montale lo aveva definito «il racconto perfetto», mentre un altro lettore di spicco come Giorgio Manganelli vi aveva ravvisato gli estremi di una «tragedia teologica». Nel 1954, un regista di spiccata sensibilità come Alessandro Blasetti ne trasse un episodio del film “Tempi nostri”.
Perché “Casa d’altri” è perfetto? Perché è un racconto “sul niente”, che porta quasi a compimento il vecchio sogno di Flaubert. In un villaggio dell’Appennino emiliano, entro la cornice di una natura pietrosa e selvaggia, c’è Zelinda, un’anziana lavandaia che sottopone al parroco del luogo una domanda cruciale sul senso dell’esistenza (cosa accade all’anima in caso di suicidio). La risposta non arriva, e allora Zelinda continua a vivere nella sensazione di essere in “casa d’altri”, nella normale estraneità dell’esilio, fino a quando capisce che la risposta -l’unica possibile, l’unica veramente umana- consiste proprio nel silenzio, nella vita che non va da nessuna parte, nell’infinito svanire da cui nascono i racconti e le storie: «I fatti -ha scritto D’Arzo alla fine di un breve saggio dedicato a Henry James- sono falsi e gratuiti come tutti i fatti, se non si fa apparire riflessa una lunga serie di giorni senza nome. Anno per anno, tutta quanta una miseria storia quotidiana. Perché niente che non abbia una storia può essere vero. Solo i fantasmi non hanno storia. E sono fantasmi».