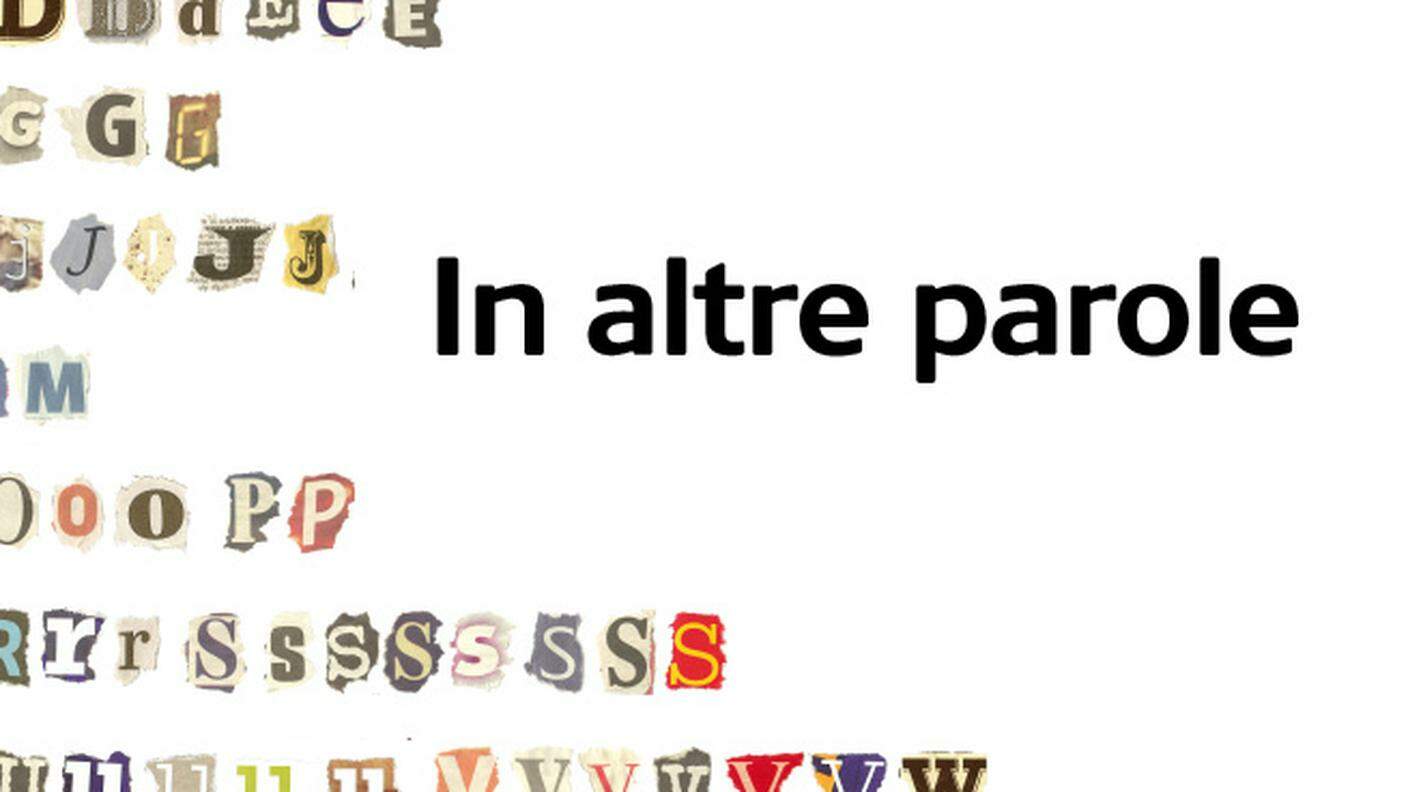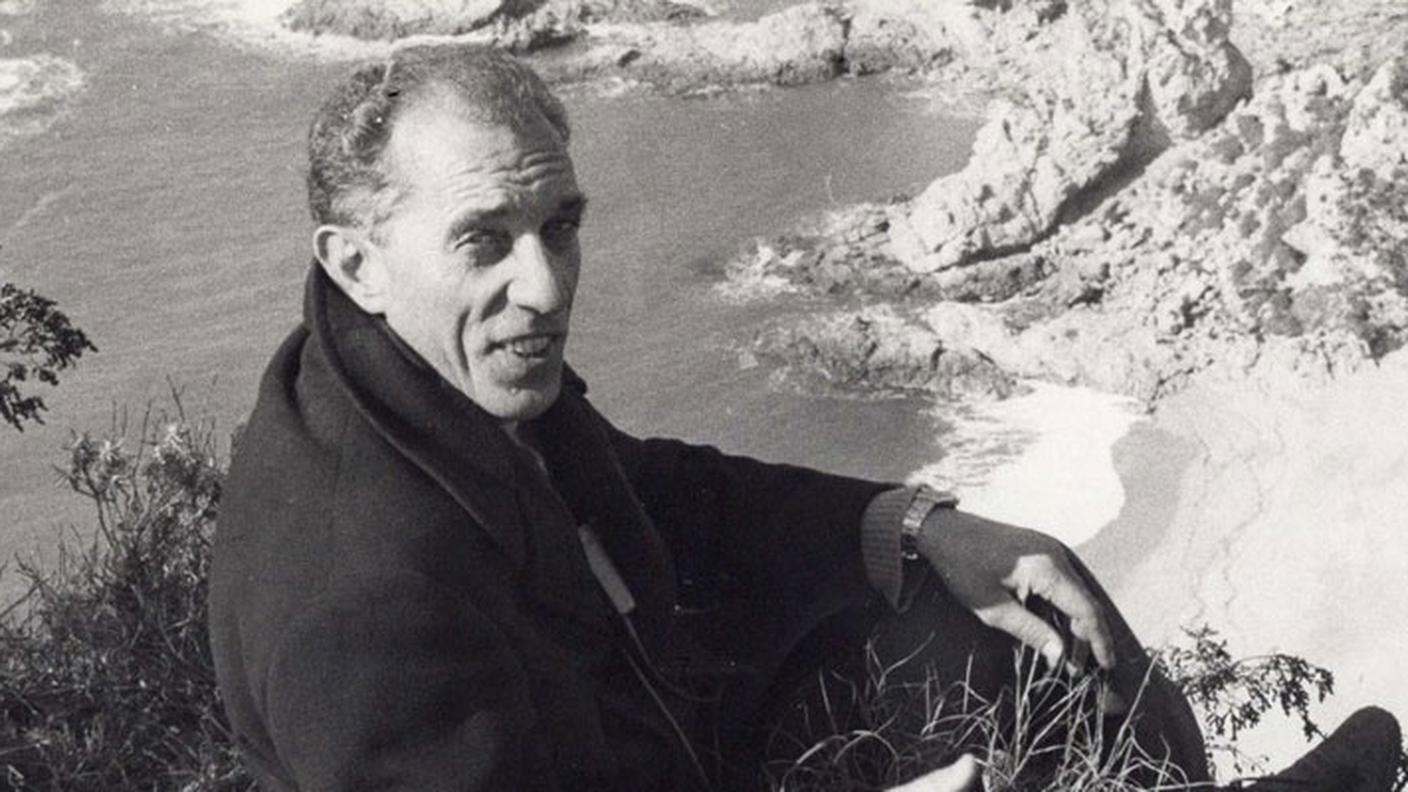«...tutto si mette in moto come una corrente sotterranea che butta i germogli, un germinal anticipato che ci getta in collettivi e riunioni e si vede che nelle osterie c’è qualcosa di nuovo, forse soltanto più voglia, ma non so bene di cosa»
Pier Vittorio Tondelli ricordava così in Altri libertini l’aria che si respirava a Bologna all’inizio della seconda metà degli anni Settanta del ‘900, quando prese corpo quel movimento di studenti e di giovani proletari che in Italia divenne il motore della rivolta politica e culturale del 1977.
Complice l’Università e in particolar modo il DAMS, il corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo nato nel 1971, la città in quel tempo era divenuta infatti il punto di incontro di zingari felici, come li aveva cantati Claudio Lolli, ossia di angeli ribelli che, pur coltivando il sogno di una rivoluzione palingenetica come avevano fatto i loro fratelli maggiori (gli ex-sessantottini), non erano più disposti alla militanza tradizionale fatta di dogmi e di sol dell’avvenire: per loro, la rivoluzione doveva essere immediata nella quotidianità della vita di tutti.
Il nuovo movimento, facendo proprie le intuizioni espresse in Anti–Edipo. Capitalismo e schizofrenia del 1972 dai filosofi francesi Gilles Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari (1930-1992), si ripropose così di mettere in circolazione flussi deliranti, cioè pensieri capaci di de/lirare (dal latino delirare, uscire dal solco) il messaggio dominante del lavoro, dell’ordine, della disciplina per la trasformazione della vita.
Dossier: Gilles Deleuze
In occasione dei 100 anni dalla nascita
Contenuto audio
Credere al reale (1./5)
Alphaville 05.05.2025, 12:05
L’Anti- Edipo (2./5)
Alphaville 06.05.2025, 12:05
Cinema 1 e Cinema 2 (3./5)
Alphaville 07.05.2025, 12:05
Il Teatro (4./5)
Alphaville 08.05.2025, 12:05
Il libro Millepiani (5./5)
Alphaville 09.05.2025, 12:05
In questo contesto (che nel tempo vide anche violenti scontri di piazza, la morte dello studente Francesco Lorusso e i carri armati nelle vie di Bologna - ma questa è una storia parallela che meriterebbe una trattazione a parte), per iniziativa di un collettivo formatosi all’interno dell’ambiente universitario bolognese, nel maggio 1975 prese vita la rivista A/traverso. Tra i principali collaboratori e fondatori ci furono personalità come il filosofo Franco Berardi “Bifo“ (1949) e il giornalista Maurizio Torrealta (1950) che, tra l’altro, di lì a poco realizzarono Radio Alice, l’emittente simbolo del movimento del ‘77.
Il collettivo si autodefinì maodadaista. Con l’unione di due tradizioni radicalmente distanti, il Dadaismo, avanguardia del XX secolo che enfatizzò la sovversione artistica, l’anti-borghesismo, l’irrazionalità e il rifiuto delle istituzioni artistiche tradizionali, e il Maoismo (in particolare la Rivoluzione Culturale cinese), che mirò a una trasformazione sociale e politica radicale attraverso lo smantellamento delle vecchie strutture culturali e la partecipazione di massa alla “costruzione” della nuova cultura, A/traverso volle infatti proporre la sovversione dell’ordine del discorso in opposizione al discorso dell’ordine e, parallelamente, l’abolizione dell’arte separata dalla società.
100 anni di Dadaismo
Telegiornale 05.02.2016, 21:00
Il programma di A/traverso si fondò sulla pratica creativa della scrittura, intesa come un atto sovversivo collettivo capace di incidere sulla realtà. A/traverso si impegnò a promuovere una massificazione dell’avanguardia mirata a far sì che l’arte e la produzione culturale diventassero componenti integrali della pratica rivoluzionaria. La rivista divenne così un laboratorio di trasgressione e rinnovamento della parola, sviluppato sulla base delle teorie di post-strutturalisti come Foucault, Barthes, Lacan, Artaud, oltre ai già citati Deleuze e Guattari.
Per alcuni intellettuali il collettivo A/traverso fu l’ultima avanguardia artistica del Novecento e anche l’Università di Yale nell’ultima sezione del proprio archivio dedicato alle avanguardie del secolo scorso ha inserito l’omonima rivista.

Franco "Bifo" Berardi, 2017
«Ora forse ci siamo: le nuove generazioni parlano e vivono nella loro pratica quotidiana il linguaggio (ovvero la molteplicità dei linguaggi) dell’avanguardia... la pratica della manipolazione eversiva dei linguaggi e dei comportamenti [ha] abbandonato le edizioni numerate, le gallerie d’arte, le cineteche e si [è] fatta strada attraverso la musica dei Beatles, le immagini psichedeliche di Yellow Submarine, le canzoni di Jannacci, i dialoghi di Cochi e Renato».
Questa considerazione la scrisse Umberto Eco (1932-2016), all’epoca direttore all’Università di Bologna dell’Istituto di comunicazione e spettacolo. Eco in quel movimento riconobbe infatti un inedito soggetto politico autonomo, lontano dalle tradizionali analisi della sinistra e dalle sue parole d’ordine, che metteva in scena la propria soggettività senza più identificarla nella forma monolitica dell’ideologia, ma articolandola in un mélange di bisogni, di immaginari, di desideri.
20.1.1973 - Umberto Eco
RSI Cultura 03.08.2025, 08:14
Contenuto audio
L’intellettuale entrò in rapporto dialettico con A/traverso perché intuì che, come le avanguardie di inizio secolo, utilizzava il linguaggio non per definire un programma politico, ma per sabotare la razionalità discorsiva in chiave di sovversione politica. A differenza degli avanguardisti d’antan che avevano progettato un futuro senza agire un cambiamento concreto nel loro presente (a parte i futuristi), nel gruppo bolognese Eco riconobbe invece la volontà tangibile di rendere coincidenti segno e gesto, parola e azione.
A/traverso, secondo il semiologo, era però espressione di una semiotica della crisi nella quale i segni non servivano più a costruire significati condivisi, ma rappresentavano la frammentazione e la disillusione preveggente di un’intera generazione che si avviava verso la frantumazione delle utopie determinata di lì a poco dalla real politik neoliberista. Naturalmente lo sguardo di Eco non fu acritico e nel suo libro Sette anni di desiderio pubblicato nel 1983 (La nave di Teseo, 2024) sono leggibili molte delle considerazioni che dedicò a quella stagione e che qui non possiamo riportare per ragioni di spazio.
Ciò che oggi è interessante, però, è constatare come il mondo intellettuale (oltre a Eco, ricordiamo Pasolini, Calvesi, Arbasino, ecc.), nei decenni scorsi fosse presente nel dibattito e nell’analisi della realtà quotidiana offrendo continui spunti di riflessione. Un aspetto che, per quanto necessario e urgente, spesso sembra purtroppo scomparso nel nostro presente fatto di bla-bla da talk-show.