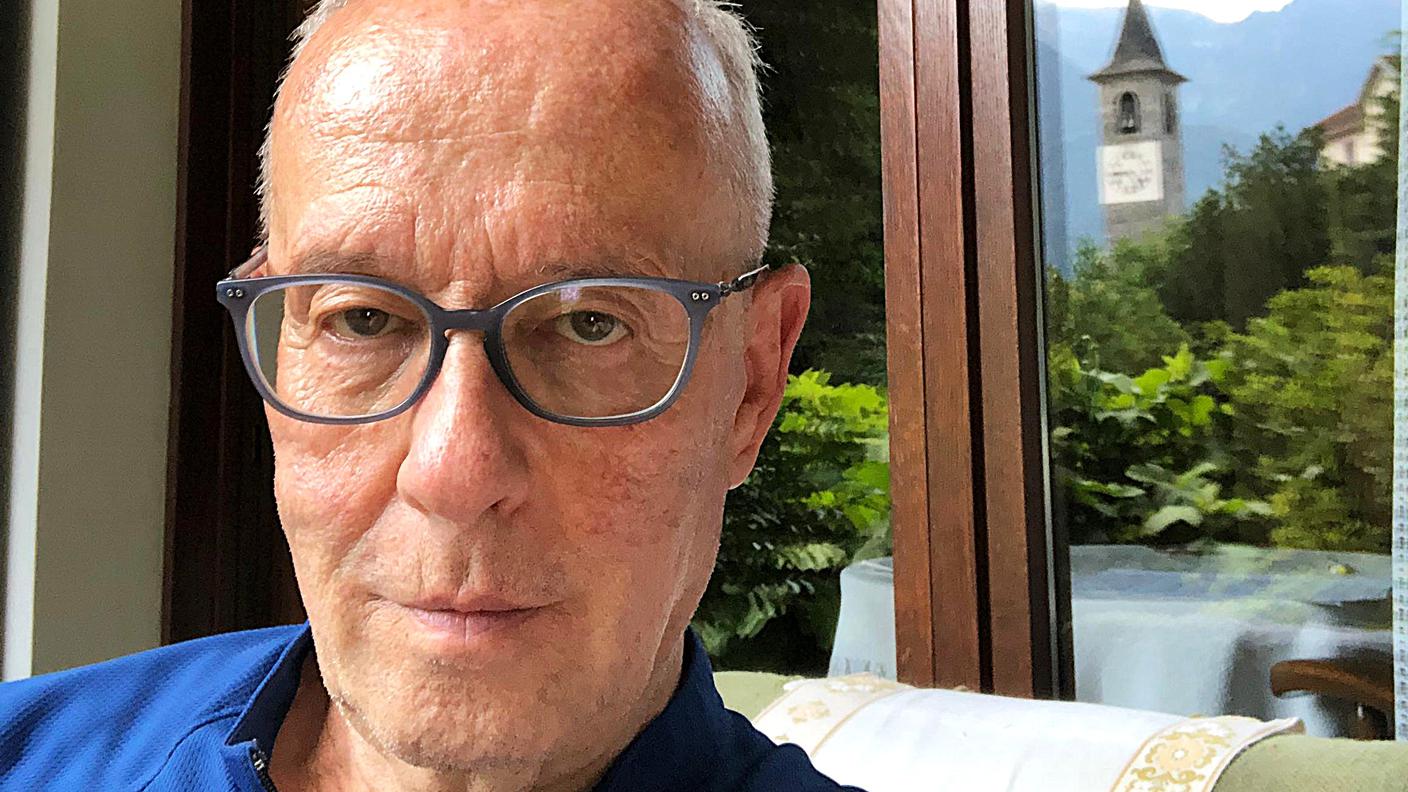La meritocrazia è una partita truccata: chi vince dice che è tutto regolare. In Italia e in Svizzera, è diventata il mantra preferito di politici, editorialisti e riformatori scolastici. “Premiare il merito!” gridano, come se bastasse un voto alto o una buona condotta per scalare la piramide sociale. Il campo da gioco, ci dicono, è livellato. Ma non è così: è inclinato. E pure scivoloso.
Il mito è semplice e seducente: chi si impegna, chi ha talento, chi “ci crede davvero”, ce la fa. Il successo è la ricompensa naturale del merito. Il fallimento? Colpa tua. Non hai studiato abbastanza, non hai fatto abbastanza, non sei abbastanza. È una narrazione perfetta per chi sta in cima: trasforma il privilegio in virtù, la fortuna in valore. E chi è in basso? Si consoli con un bel “potevi fare di più”.
Ma la realtà è un’altra. Come ci ricorda Robert Frank nel suo libro Success and Luck (2016), il merito è spesso il frutto della fortuna: genetica, ambiente familiare, opportunità. E la fortuna non è distribuita equamente. In Svizzera, ad esempio, il sistema scolastico è considerato un modello di efficienza meritocratica. Ma uno studio dell’Università di Berna ha dimostrato che l’accesso ai percorsi formativi più promettenti dipende meno dalle capacità e più dalla classe sociale di origine. Tradotto: se nasci nei piani bassi, ti parcheggiano in un apprendistato con poche prospettive. E da lì, difficilmente ti muovi.
In Italia, la situazione è simile, ma con più retorica. La scuola è il luogo dove il merito dovrebbe brillare. E invece, come scrive Erika Petrella nella sua tesi all’Università di Padova, la valutazione meritocratica è tutt’altro che oggettiva: è intrisa di giudizi, percezioni, aspettative. Il merito scolastico è spesso il riflesso del capitale culturale della famiglia, come già denunciavano Bourdieu e Passeron negli anni ’70. Chi arriva con l’habitus giusto, vince. Gli altri arrancano.
Il Punto. Merito e meritocrazia
Alphaville 26.10.2023, 12:35
Contenuto audio
E non è solo questione di equità. È anche una questione di effetti collaterali. Studi psicologici mostrano che credere nella meritocrazia rende le persone più egoiste, meno solidali e più inclini alla discriminazione. In un esperimento condotto in Cina, chi credeva di aver “vinto” un gioco di abilità tendeva a tenere più soldi per sé nel successivo gioco di condivisione. L’idea di essere “più bravo” legittima l’egoismo. E in aziende che dichiarano di adottare la meritocrazia, i manager premiavano più gli uomini che le donne, anche a parità di performance. Il paradosso è servito: più credi di essere giusto, meno ti accorgi di essere ingiusto.
La meritocrazia è una bugia elegante. Come ogni ideologia, giustifica lo status quo. Spiega perché ognuno è al posto che occupa. Ma offre anche una lusinga irresistibile: se ho successo, è perché lo merito. Se sono ricco, è perché valgo. La meritocrazia trasforma la proprietà in lode, la disuguaglianza in superiorità morale. È il principio distributivo più autocelebrativo che esista.
"Parliamone!"
Alphaville 29.11.2022, 12:30
Contenuto audio
E così, ogni traguardo – dal diploma alla carriera artistica, fino al conto in banca – diventa prova di virtù. E ogni fallimento, segno di difetto. Chi è in basso nella scala sociale merita di restarci. Ecco perché i dibattiti su chi è “self-made” o su cosa sia “privilegio” diventano roventi: non si discute solo di chi ha cosa, ma di quanto credito morale si può rivendicare.
In questo quadro, dire che il successo dipende dalla fortuna è quasi un insulto. Sminuisce il merito, nega l’identità. Ma è proprio questo che dobbiamo fare: smettere di credere alla favola.
La meritocrazia non è solo falsa. È dannosa. Alimenta l’egoismo, la disuguaglianza, l’indifferenza. E va abbandonata, sia come descrizione del mondo, sia come ideale sociale. Perché nessun campo da gioco è davvero livellato.
Oltre la meritocrazia…
RSI Plusvalore 22.10.2021, 12:20
Contenuto audio