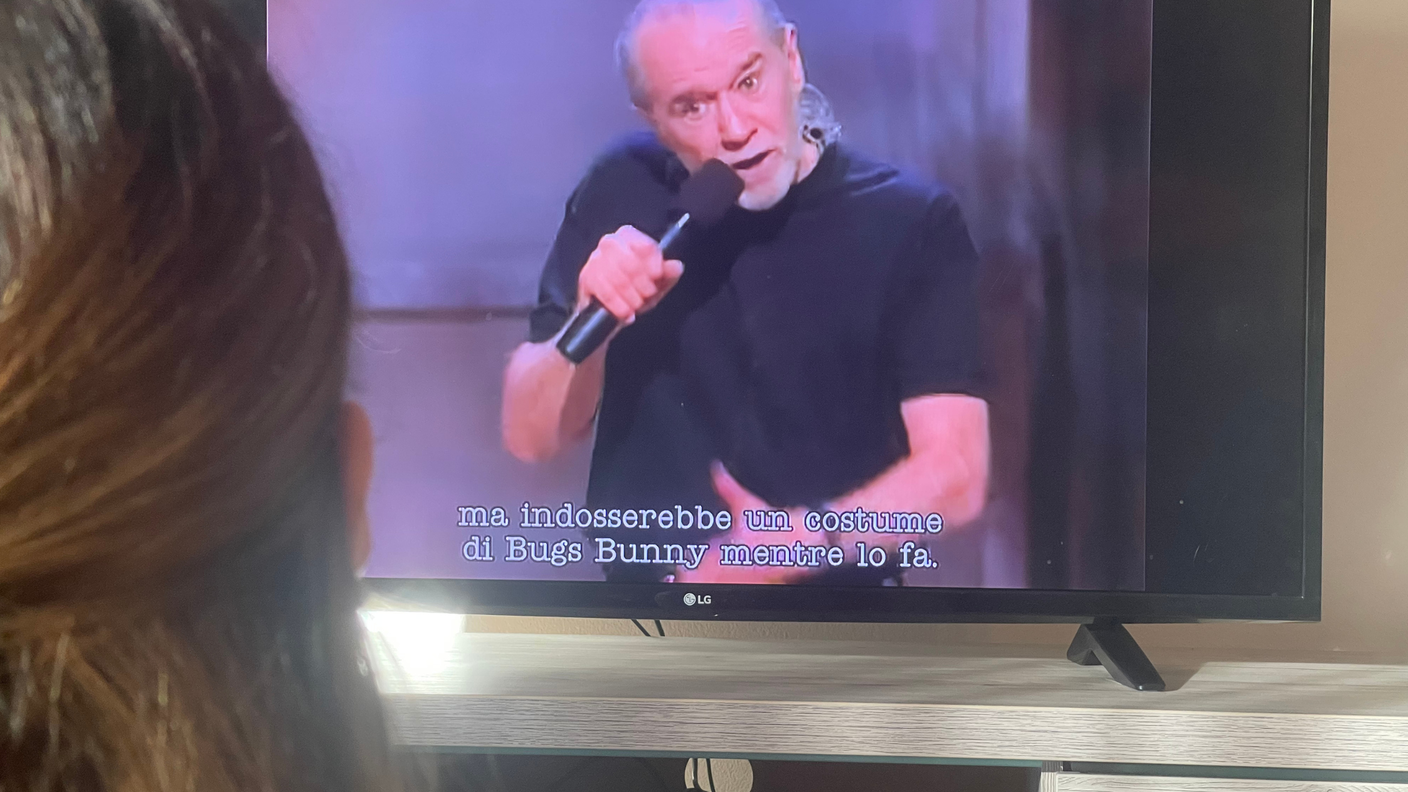Per la prima metà della mia vita ho consumato prodotti comici e umoristici quasi esclusivamente attraverso la letteratura. Non c’era dello snobismo in questo: semplicemente altri tipi di prodotti non mi divertivano. Per citare alcuni prodotti di successo italiani dell’epoca, Zelig mi annoiava, Colorado mi infastidiva, i cinepanettoni non erano cosa mia. Percepivo sempre un’aura carnevalesca nei prodotti di comicità, che mi faceva sentire come a una festa in cui qualcuno fa partire il trenino e ti obbliga a partecipare. Provavo sempre un imbarazzo soggiacente.
C’erano chiaramente delle eccezioni: ascoltavo Elio e Le Storie Tese, spesso tanto grotteschi da sublimare quell’imbarazzo, guardavo South Park ed ero andato a vedere Maurizio Crozza al Teatro Sociale di Bellinzona. Mi piacevano anche Bergonzoni e Benni, rimanendo in Italia. Però, ecco: la comicità non era proprio il mio pane, in quegli anni.
Tutto è cambiato con un ometto piccolo e vecchio, che mi è apparso su YouTube per puro caso.
Uno spettro, quasi, dato che le prime volte che l’ho visto nei video era già morto da almeno un paio d’anni. Quel folletto insolente, che sembrava fregarsene di ogni norma sociale e dire tutto quello che gli passava per la testa senza nessun freno mi faceva morire dalle risate.
Se mi sono interessato alla stand-up comedy, quindi, lo devo soprattutto a George Carlin. È grazie a lui (e ai video con i sottotitoli su YouTube) che ho scoperto Richard Pryor, Lenny Bruce, Louis C.K. – e quanto potesse essere divertente Robin Williams quando era su un palco, oltre che davanti all’obiettivo di una cinepresa.
Sorgeva però un problema: perché in lingua italiana non trovavo niente del genere? Né in Italia, né tantomeno in Ticino. C’erano comici che facevano monologhi sul palco – la formula della stand-up comedy, dal punto di vista visivo (una persona, un microfono e, al limite, uno sgabello) esisteva. Eppure, non era la stessa cosa.
Mancava la critica sferzante, la vera sfida verso il potere (non solo politico, ma sociale) il moto rivoluzionario – uniti alla voglia di raccontarsi in maniera onesta e vulnerabile. La comicità che trovavo in italiano sembrava ritenere la risata un fine, più che un mezzo.
Anche qui, c’erano delle eccezioni: retroattivamente avevo scoperto Marco Paolini, Paolo Rossi, Daniele Luttazzi, Beppe Grillo – esempi di come l’aspetto critico e satirico poteva coesistere con l’ottenimento di risate. Di come la comicità poteva essere lo zucchero per fare andare giù pillole amare. Ma quando li ho scoperti, molti di loro erano già usciti dai radar del grande pubblico della comicità: chi per editti bulgari, chi per l’inizio di una carriera politica, chi perché semplicemente si era dedicato a cinema e teatro.
Al tempo stesso però, qualcosa in Italia cominciava a muoversi. Nel 2011 Filippo Giardina stava selezionando una squadra di otto comedians che si sarebbero riuniti sotto la bandiera del progetto Satiriasi: lo stesso Filippo Giardina, Giorgio Montanini, Francesco De Carlo, Saverio Raimondo, Mauro Frantini, Velia Lalli, Pietro Sparacino e Daniele Fabbri. Era la prima volta che in Italia sembra esserci la volontà di portare un genere nuovo, che oltre ai temi classici della satira (politica, religione, sesso e morte) portasse anche contenuti più onesti e personali. Insomma, si stavano aprendo le porte per una comicità molto più simile a quella statunitense.
Alzati e… ridi!
Charlot 18.12.2022, 14:35
Contenuto audio
Il progetto dura tre anni, e sposta la comicità dai teatri ai locali italiani – prima al MADS di Roma e successivamente alla Locanda Atlantide. Nel corso degli anni ci saranno diversi tentativi di portare quell’anima in televisione, ma solo nel 2014 si trova la quadratura del cerchio con l’approdo a Comedy Central su Sky. La stand-up comedy in Italia rimane ancora un genere di nicchia, ma comincia a entrare e stabilirsi nell’immaginario collettivo, complici anche le piattaforme streaming che rendono i prodotti internazionali disponibili e sottotitolati.
Quella piccola detonazione di stand-up comedy in Italia, io non la vivo per questioni geografiche: nel frattempo, infatti, mi sono trasferito a Losanna per gli studi universitari. La cosa divertente però è che in Svizzera romanda sta succedendo qualcosa di simile. L’ispirazione, in questo caso, è più francese che statunitense.
Il boom della stand-up comedy nella Svizzera romanda
Sono gli anni in cui stanno cominciando a muovere i loro passi giovani umoristi della mia generazione, come Thomas Wiesel, Alexandre Kominek, Marina Rollman, Yoan Provenzano, Blaise Bersinger, etc. Tutti talenti svizzeri, nati tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, che approfittano della nascita di luoghi come il Kémédy Club a Ginevra per muovere i primi passi e farsi le ossa nel mondo della stand-up.
Canali radiofonici come One FM aprono ai giovani umoristi le loro porte, ospitando le loro “chroniques”, brevi interventi sull’attualità.
L’accoglienza è calorosa: la nuova generazione di comici trova le porte del Montreux Comedy Festival spalancate, mentre i comedy club in Svizzera diventano sempre più numerosi.
Grazie a queste apparizioni, esponenti come Rollman, Wiesel e Kominek ricevono diverse attenzioni dalla Francia, dove vengono contattati per partecipare a trasmissioni radiofoniche e spettacoli. Nel frattempo, il successo internazionale degli umoristi alimenta ancora di più l’interesse da parte dei media romandi a trattenere i propri comici sul territorio. Le loro apparizioni a Couleur 3 della RTS aumentano, si crea un circolo virtuoso che porterà diversi umoristi a collaborare con il servizio pubblico a diversi livelli, fino alla recente nascita del Couleur 3 Comedy Club.
In quegli anni, tra il 2013 e il 2017, posso dire che a Losanna si percepiva la nascita di qualcosa di importante. Una sorta di tempesta perfetta che ha trovato un territorio fertile ad accoglierla.
Sono tornato in Ticino alla fine del 2016 sperando di trovare qualcosa di simile anche nel nostro Cantone, ma non è stato così. Ed è in quel momento che ho cominciato a chiedermi quale fosse il motivo. Perché qui non si può fare una cosa del genere?
La comicità ticinese, tra forme classiche (molte) e innovazione (poca)
Credo non esista una risposta univoca a questa domanda, ci sono un insieme di cause concomitanti. La Svizzera italiana è la regione linguistica più piccola del Paese; il pubblico potenziale è minore rispetto a quello francofono. Questo non è un problema di per sé, ma è una discriminante quando si propone un prodotto di nicchia.
Per questo si ha una tendenza generale alla sicurezza dei prodotti generalisti, con tutte le controindicazioni del caso: il terreno per la sperimentazione dal punto di vista mediatico o culturale non è tra i più fertili. Nella Svizzera italiana esistono iniziative comiche e umoristiche, ma sono spesso radicate a una dimensione quasi esclusivamente identitaria.
Se prendiamo degli esempi di successo più o meno recenti, come i Frontaliers, le pagine social di BarNüm, Il Ticinese Medio, Non parlo lo svizzero, così come il Cabaret della Svizzera italiana, è chiaro già dal nome come la componente territoriale sia predominante. Che è una scelta comprensibile per differenziarsi, ma limita anche molto il raggio d’azione del prodotto e la libertà espressiva degli umoristi, rischiando di cadere nei soliti cliché sulle differenze tra le varie regioni. La sua principale caratteristica diventa così anche il maggior limite.
A unirsi a questo ci sono anche delle ragioni più culturali. A differenza della Svizzera romanda, che può contare su un modello particolare e rodato di stand-up comedy come quello francese, la Svizzera italiana trova nell’Italia un modello che, come abbiamo visto in precedenza, è ancora piuttosto giovane e in evoluzione. Si tende quindi a pescare dall’Italia le tipologie di comicità di maggior successo e più classiche, come la comicità di personaggio, i travestimenti, lo slapstick o gli sketch da social network. Tipologie di tutto rispetto e con una lunga storia alle spalle, ma che non brillano per spirito innovativo.
Inoltre, nella Svizzera italiana c’è forse la tendenza a percepire come aggressiva gran parte della satira politica o sociale. In un territorio così piccolo, ogni affermazione diventa personale e divisiva; una battuta a proposito di una personalità locale viene percepita come rivolta alla persona più che alla sua funzione. Si ha quindi, da parte degli umoristi, una forte tendenza all’autocensura e al restare nei limiti di una comfort zone in cui si è sicuri che nessuno possa offendersi.
Nel mondo mediatico ticinese c’è una grande paura dell’errore, e visti i tempi che corrono, non solo nel nostro territorio, ma a livello internazionale, è un timore comprensibile. Ma la paura di sbagliare mal si coniuga con la sperimentazione e, più nello specifico, con tutte le tipologie di umorismo più taglienti. L’errore è la base stessa della satira: non puoi testare quali siano i limiti senza avvicinartici e, in qualche caso, accettare che capiti di varcarli. Sia Lenny Bruce che George Carlin sono stati arrestati per delle battute. Non che questo sia per forza un esempio da seguire o a cui aspirare – erano altri anni e c’erano altre leggi sulle oscenità – ma è rappresentativo di come la paura di osare e l’autocensura si sposino male con la satira e la comicità.
Questa paura dei media va poi a impattare sui singoli comici, che per evitare l’errore si muovono sempre all’interno di ciò che già funziona. È sintomatico che il profilo satirico più conosciuto in Ticino, quello di Francesco Sottobosco su Facebook, si avvalga di uno pseudonimo. La paura delle conseguenze nel fare satira o nel testare i limiti della critica umoristica nel nostro Cantone è tale da spingere le persone a tutelarsi nascondendo la propria identità.
A differenza della Svizzera romanda, non c’è stata ancora una trasmissione radiofonica o televisiva, un club o festival a fare da apripista, quindi è più difficile che comici giovani si buttino in quella strada. Su Couleur 3, prima dell’arrivo di tutte le nuove leve, i due Vincent (Vincent Kucholl e Vincent Veillon) avevano già aperto le porte a un tipo di comicità più di stampo satirico con 120 secondes e 52 minutes, prodotti che hanno raggiunto in breve tempo un successo notevole. E il Festival di Montreux è una realtà importante da almeno trent’anni. In Ticino, per l’evoluzione che hanno avuto i social network negli ultimi decenni, sarebbe più probabile che chi decide di farlo riversi la sua creatività lì, e non nei Comedy Club: il potenziale di pubblico e di carriera, pur restando bassi, risultano inevitabilmente maggiori.
Insomma, ci sono diversi motivi per cui il Ticino non è un territorio fertile per un tipo di comicità che si allontani da quella identitaria. Mancano strutture, cultura umoristica ed esempi di successo che traccino una via in questa direzione. Non abbiamo avuto trasmissioni trainanti in questo senso, né ci siamo ancora dimostrati culturalmente pronti ad accogliere tipologie diverse di comicità.
Ci sono mancati i nostri due Vincents e le nostre Couleur 3, i nostri Kémédy Club e i nostri Montreux Comedy Festival; ci è mancato, forse, il coraggio di provare a cambiare le cose nel corso degli anni, e siamo rimasti indietro rispetto ai cugini francofoni. L’accoglienza tiepida ai rari spettacoli di stand-up comedy nei bar della Svizzera italiana è sintomo che siamo ancora lontani dal vedere una scena esplodere come è successo nella Svizzera romanda.
E forse è vero che l’unico modo per essere rilevanti dal punto di vista umoristico in Ticino è cavalcando i temi identitari, perché per il resto il pubblico guarda altrove, cercando prodotti internazionali o di altre regioni linguistiche. Magari va bene così, e sono l’unico a sentire la mancanza di altre tipologie di prodotto. La risata è soggettiva – ci divertono cose diverse, e forse per la maggior parte delle persone l’offerta umoristica è più che sufficiente.
Quello che so è che a volte provo la sensazione di essere tornato il ragazzino che fatica a fare il trenino alle feste; e mi chiedo se, forse, il problema sono io. In quei momenti, devo ammetterlo, mi manca un po’ Losanna. E anche George Carlin. Ma lui manca a tutti.

La sintassi della satira
Diderot 21.12.2020, 17:10
Contenuto audio