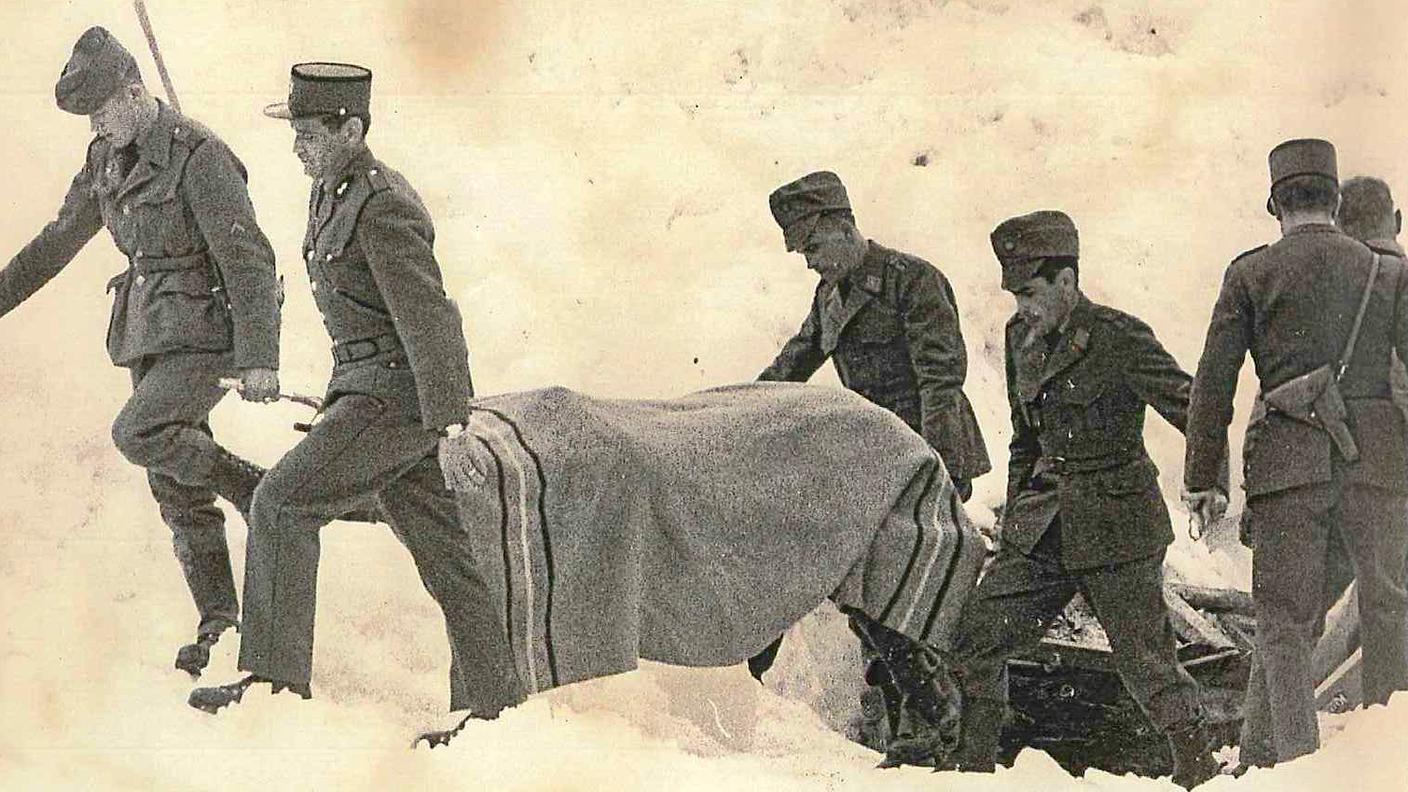Le idee di Karl Marx, a quasi due secoli dalla pubblicazione de Il Capitale, continuano a generare dibattiti.
Un recente caso in Germania ha infatti riacceso la discussione sul pensiero marxista e la sua relazione con la democrazia contemporanea. È successo ad Amburgo, dove si è verificato un fatto surreale.
L’8 aprile di quest’anno, la “Scuola Serale Marxista – Forum per la Politica e la Cultura” (Masch) ha vinto una causa contro l’Ufficio per la Protezione della Costituzione (Verfassungsschutz) davanti al tribunale amministrativo di Amburgo. Il tribunale ha stabilito che l’autorità non può più classificare l’associazione come “estremista di sinistra“. La Masch aveva fatto ricorso contro la sua menzione nel rapporto del Verfassungsschutz del 2021, che le aveva fatto perdere lo status di organizzazione no-profit. Chi era presente in aula racconta che si respirava un’euforia cauta, una rara sensazione di vittoria politica.
Ma questa vittoria si è poi ribaltata e un boomerang ha investito i circoli marxisti in Germania. Il problema sta nelle motivazioni scritte della sentenza, pubblicate in luglio. Sebbene il tribunale confermi la decisione a favore della Masch, la sentenza ribadisce però che alcune idee rivoluzionarie di Marx (come la “dittatura del proletariato”) non sarebbero invece compatibili con i principi di libertà e democrazia alla base dello Stato tedesco.
Karl Marx
RSI I servizi 02.02.2018, 22:26
Una lettura alternativa della questione arriva da Lucia Pradella, docente di economia politica internazionale al King’s College di Londra. Secondo la studiosa, la visione marxista della rivoluzione e della cosiddetta “dittatura del proletariato” non va intesa come un atto di violenza, ma come un processo di trasformazione sociale, in cui i lavoratori prendono in mano i mezzi di produzione per sovvertire l’ordine esistente. In L’attualità del Capitale. Accumulazione e impoverimento nel capitalismo globale (Il Poligrafo, 2010), Pradella sottolinea come le democrazie contemporanee tendano a concentrare potere e ricchezza nelle mani di una minoranza, escludendo la maggioranza. In questo quadro, la teoria marxista si propone come strumento per rompere il monopolio economico e politico della classe dominante.
Pradella critica apertamente la decisione del tribunale di Amburgo, definendola un tentativo di blindare lo status quo contro critiche radicali. A suo avviso, il provvedimento riflette una tendenza preoccupante: quella alla riduzione dello spazio democratico, in un contesto sempre più segnato da una “economia di guerra”, dove le spese militari aumentano e le disuguaglianze si aggravano.
Rivoluzione e dissenso nelle democrazie imperfette
Alphaville 22.08.2025, 11:30
Contenuto audio
«Da una parte i profitti delle grandi imprese sono alle stelle» - afferma Pradella - «dall’altro, un quinto dei lavoratori in Germania è a basso salario, più di un quarto della popolazione non ha alcuna forma di ricchezza netta; in questa condizione, bollare come antidemocratica la possibilità di trasformare l’ordine esistente significa manifestare apertamente che la democrazia attuale è in realtà una forma di dittatura che sta diventando sempre più militarizzata e repressiva»
Per Lucia Pradella, l’ordine democratico contemporaneo sembra attraversare una fase di regressione silenziosa, ma profonda. Il sostegno che molte democrazie occidentali continuano a garantire a regimi discutibili sul piano dei diritti umani, unito alla crisi dell’architettura imperiale che ha retto il mondo negli ultimi decenni, produce un effetto collaterale inquietante: la repressione crescente dei movimenti sociali e delle voci critiche. In questo contesto, la decisione del tribunale di Amburgo non appare come un episodio isolato, ma come il riflesso di un nervo scoperto — la paura dell’establishment di fronte a una contestazione radicale dell’ordine costituito.
La chiusura di spazi di discussione come i gruppi di lettura marxisti non è solo una questione giuridica: è un termometro culturale. Per Pradella, si tratta di un segnale allarmante per una società che dovrebbe, per sua natura, promuovere il confronto e il pensiero divergente. La vicenda solleva interrogativi cruciali sul ruolo del dissenso nelle democrazie contemporanee e sulla capacità — o volontà — dei sistemi politici di accogliere visioni alternative.