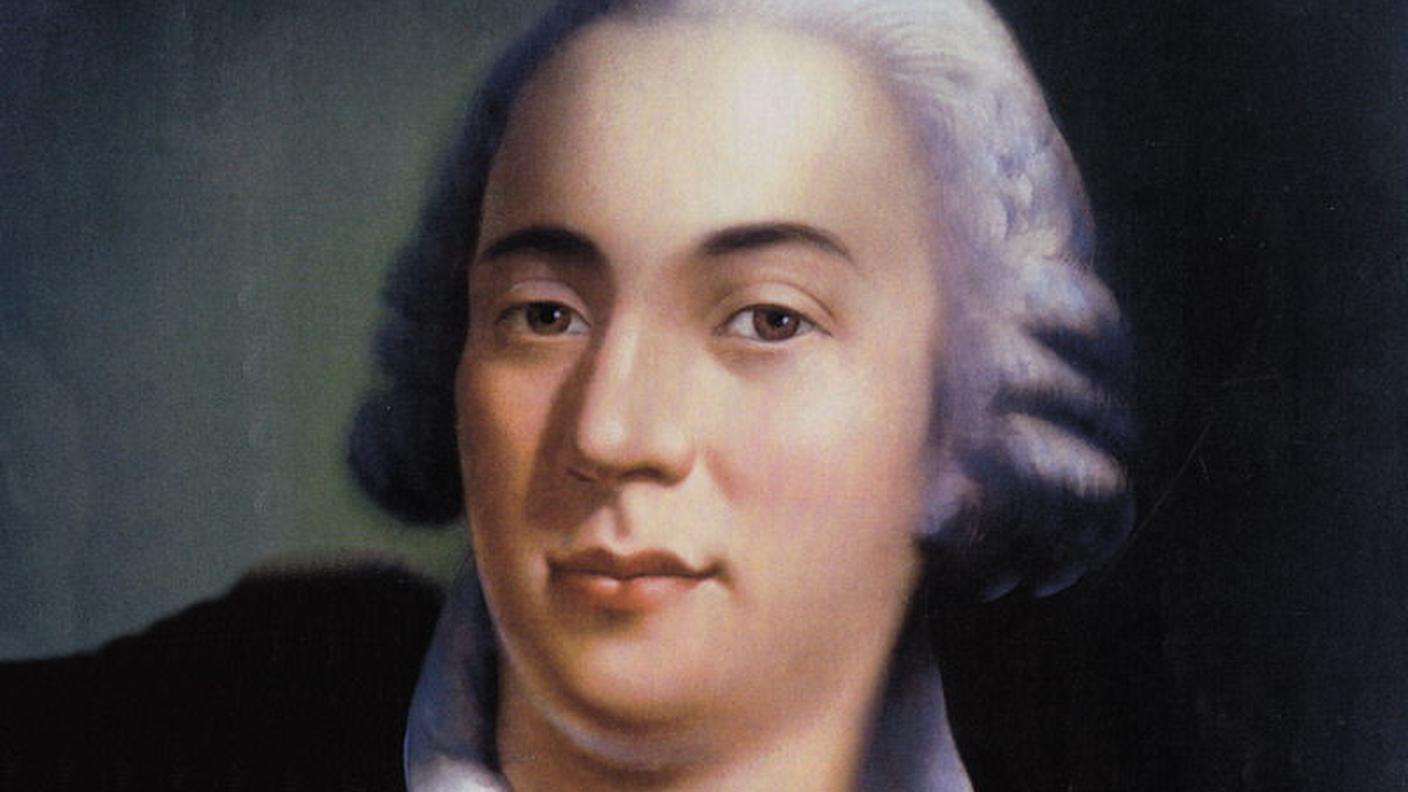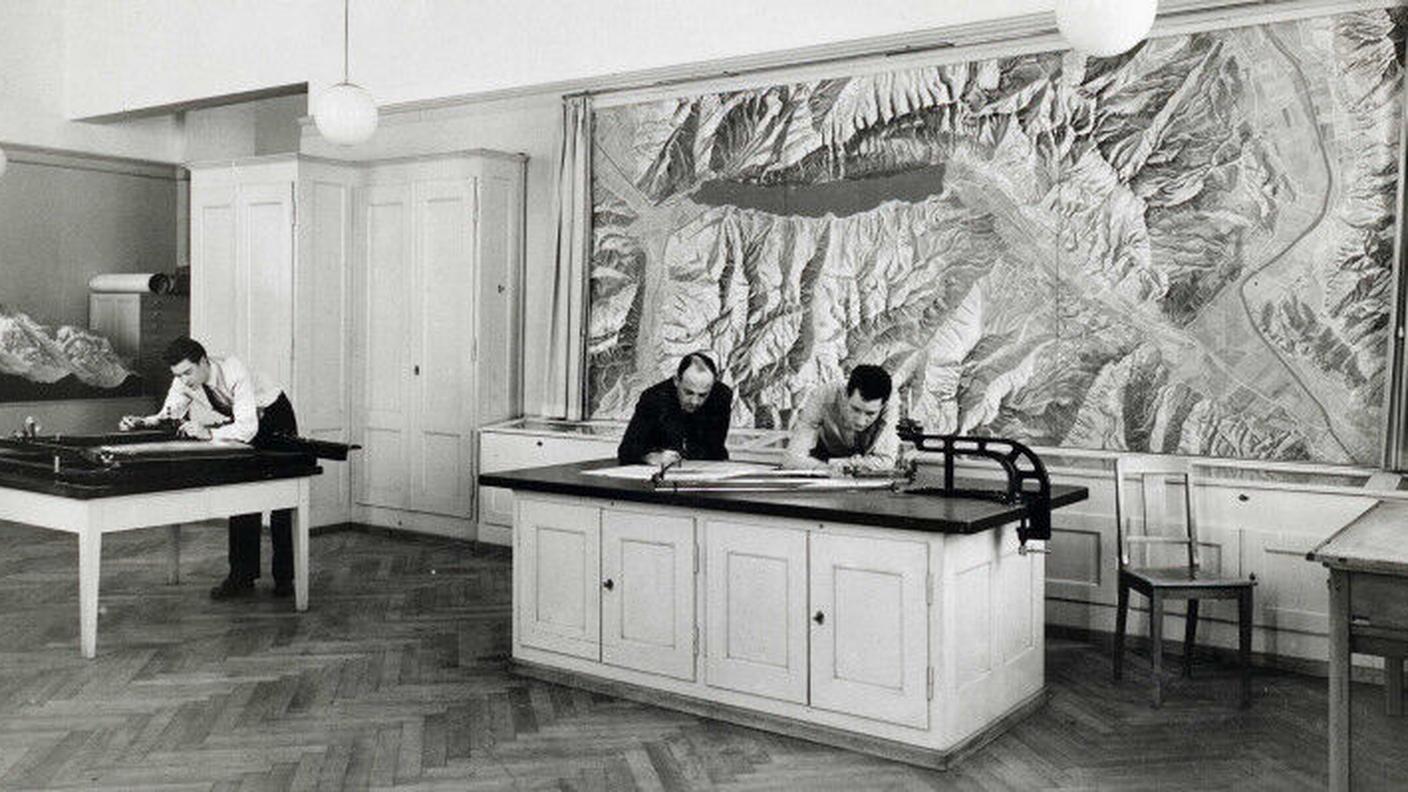Passò alla storia come la protagonista di una svolta decisiva nello sport femminile. Il suo “crimine”? Essere donna, e pretendere di correre più di 400 metri.
Nel il 1975, in una Svizzera che ancora vietava alle donne di cimentarsi nelle gare di resistenza, una giovane vallesana scelse di correre ugualmente: Odette Vetter, che sotto falso nome, e ben consapevole che quel passo clandestino non fosse soltanto un gesto personale, compì la sua corsa segreta, inaugurando una nuova stagione nello sport femminile elvetico.

La storia di Odette Vetter, donna e atleta
Prima Ora 03.10.2025, 18:00
All’inizio, la giovane Odette si allenava lontano da sguardi indiscreti: in pantaloncini corti e maglietta si sentiva addosso l’ombra del giudizio, come se quell’abbigliamento sportivo fosse un’offesa alla decenza comune. Per questo preferiva sentieri appartati, al riparo da curiosità e diffidenze.
La svolta avvenne nel 1974. Iscritta al Club atletico di Sierre, salì su un pullman diretto a Friburgo per assistere alla Morat–Friburgo, storica corsa di 17 chilometri che, dal 1933, ogni prima domenica di ottobre commemora la vittoria confederata del 1476. Lì tifava per i compagni, gridando i loro nomi. E fu proprio osservando quella fiumana di corridori – i più forti e i più lenti, tutti in marcia verso il traguardo – che maturò la sua decisione: «Anch’io lo posso fare. L’anno prossimo verrò a correre, anche se è vietato». In fondo, già allora si allenava regolarmente con gli uomini del club, coprendo fino a trenta chilometri a settimana.
![Sur la route de Morat-Fribourg [Ciné-Journal suisse].jpg](https://cleaver.cue.rsi.ch/public/cultura/storia/3160539-z3k66f-Sur-la-route-de-Morat-Fribourg-Cin%C3%A9-Journal-suisse.jpg/alternates/r16x9/3160539-z3k66f-Sur-la-route-de-Morat-Fribourg-Cin%C3%A9-Journal-suisse.jpg)
Sulla strada della Morat–Friburgo., 1942.
Il divieto non era solo un fatto sociale: era scritto nei regolamenti. Negli anni Settanta, nella Confederazione, alle donne erano infatti precluse le gare di resistenza; medici e dirigenti sportivi brandivano argomentazioni pseudoscientifiche e moralistiche: si parlava di rischi per la fertilità, di trasformazioni fisiche “innaturali”, di corpi femminili inadatti a sforzi prolungati. Come ricostruito nel documentario Free to Run, persino la scienza ufficiale si fece complice di pregiudizi grotteschi. Odette, oggi, ammette di aver creduto lei stessa a quelle voci, perché provenivano da autorità rispettate.
Eppure, nulla la fermò. Il 5 ottobre 1975, a venticinque anni, mantenne la promessa. Si iscrisse con lo pseudonimo “Joseph”, e chiese a un amico di ritirarle il pettorale. «Se fossi andata io – ricorda – non me l’avrebbero dato». Per passare inosservata indossò un cappellino che le copriva i capelli e una larga tuta da jogging che la soffocava sotto il sole d’ottobre. Come riportato da Namya Bourban nel suo articolo dedicato alla storia di Vetter (24heures.ch, 2025), a tradirla fu un organizzatore in giacca e cravatta, che le si avvicinò indignato redarguendola: «Siete imbroglioni![...] Con queste cose ci mandate tutto all’aria!». Uno dei banali pretesti addotti? Mancavano spogliatoi per signore.
Odette non si lasciò intimidire: ignorò insulti e ammonimenti, e si concentrò solo sull’arrivo. Al via, la paura lasciò spazio all’euforia: era allenata, determinata, pronta. A tre chilometri dal traguardo, sentì gli amici gridare il suo nome, ma quel grido rischiava di smascherarla. Allora raccolse le ultime forze e lanciò lo sprint finale. «Credo di aver corso il chilometro più veloce della mia vita», ha raccontato più volte.
E sebbene Odette non fosse la prima a introdursi di nascosto nel gruppo dei corridori, la sua disobbedienza assunse un rilievo immediato grazie alle telecamere della Radiotélévision suisse romande (RTS), che trasformarono un gesto clandestino in un caso mediatico, tanto che due anni più tardi, nel 1977, la Morat–Friburgo aprì ufficialmente anche alle donne. Da allora, la giovane vallesana non mancò quasi mai a quell’appuntamento, partecipando per decenni anche a gare nazionali e internazionali, fino alla maratona di New York nel 2000.
Corre ancora oggi: «È la mia medicina – confessa – il mio modo per dimenticare i problemi e relativizzare tutto».
Non fu però la sola in quella calda domenica del 1975. Al via si presentò anche un’altra donna, indossando una maglietta che domandava a chiare lettere: Pourquoi pas les femmes? (“Perché le donne no?”). Invano cercarono di fermarla: tagliò comunque il traguardo, lasciando dietro di sé immagini destinate a diventare simboliche.
La spinta che portò le due giovani svizzere ad infrangere le regole fu certamente ispirata anche da esempi esteri, in primis dal coraggio profuso da Roberta “Bobbi” Gibb e Kathrine Switzer – prime maratonete statunitensi – le cui storie circolavano sulle riviste specializzate, spronando anche le aspiranti atlete europee.
Per comprendere appieno la portata del gesto, occorre infatti guardare al contesto. Come spiega la storica Manuela Maffongelli (nei servizi RSI curati da Cristina Savi) in Svizzera le donne iniziarono a praticare ginnastica solo a fine Ottocento, e in Ticino agli inizi del Novecento. Ma quella ginnastica non aveva fini agonistici: serviva a “coltivare” corpi sani in vista della maternità, in contrapposizione a quella maschile, nata con intenti militari. E lo sport femminile rimase a lungo prigioniero di questa visione utilitaristica.
Solo negli anni Settanta, con il decreto per la promozione della ginnastica e dello sport e l’introduzione dell’educazione fisica obbligatoria, si aprì un varco. Nel 1970 nacque il primo campionato svizzero di calcio femminile e, gradualmente, anche discipline considerate “inadatte” alle donne – come sport di contatto e gare di resistenza – iniziarono a farsi strada. Ma la vera consacrazione arrivò nel 1984, con la maratona olimpica di Los Angeles. Anche allora, tuttavia, il corpo stremato della svizzera Gabriela Andersen Schiess scosse l’opinione pubblica: «Vedere un volto femminile sfigurato dalla fatica – osserva Maffongelli – non era un’immagine che la società era pronta a vedere».

Gabriela Andersen-Schiess, una corsa diventata storia
RSI Archivi 05.08.1984, 18:54
Osservando dunque il quadro complessivo, la corsa clandestina di Odette non appare soltanto come una prova di tenacia personale. Fu un gesto simbolico che incrinò consuetudini e pregiudizi, contribuendo a far avanzare il diritto delle donne a praticare lo sport di resistenza in Svizzera.
In effetti, anche quando non erano femministe militanti, le atlete rappresentavano comunque una sfida all’ordine sociale: «Lo sport femminile era lo specchio della società – sottolinea Maffongelli, responsabile dell’Archivio storico di Lugano e studiosa di Storia dello sport femminile nei primi decenni del ‘900 – e non è un caso che proprio tra il 1970 e il 1972 le donne abbiano ottenuto il diritto di voto».
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/Suffragio-femminile-il-difficile-cammino-delle-donne-svizzere--2566615.html
Eppure, Odette Vetter non partì da un’istanza politica. «All’epoca – racconta oggi – votare o non votare non aveva importanza per me. Quando si parlava di politica, ci chiedevamo: perché mai dovremmo interessarci? Non eravamo cresciute in quella cultura. […] Oggi, invece, vedo le cose in modo completamente diverso. Oggi, sì, scenderei in piazza a manifestare».

Una svolta nello sport femminile
Il Quotidiano 03.10.2025, 19:00