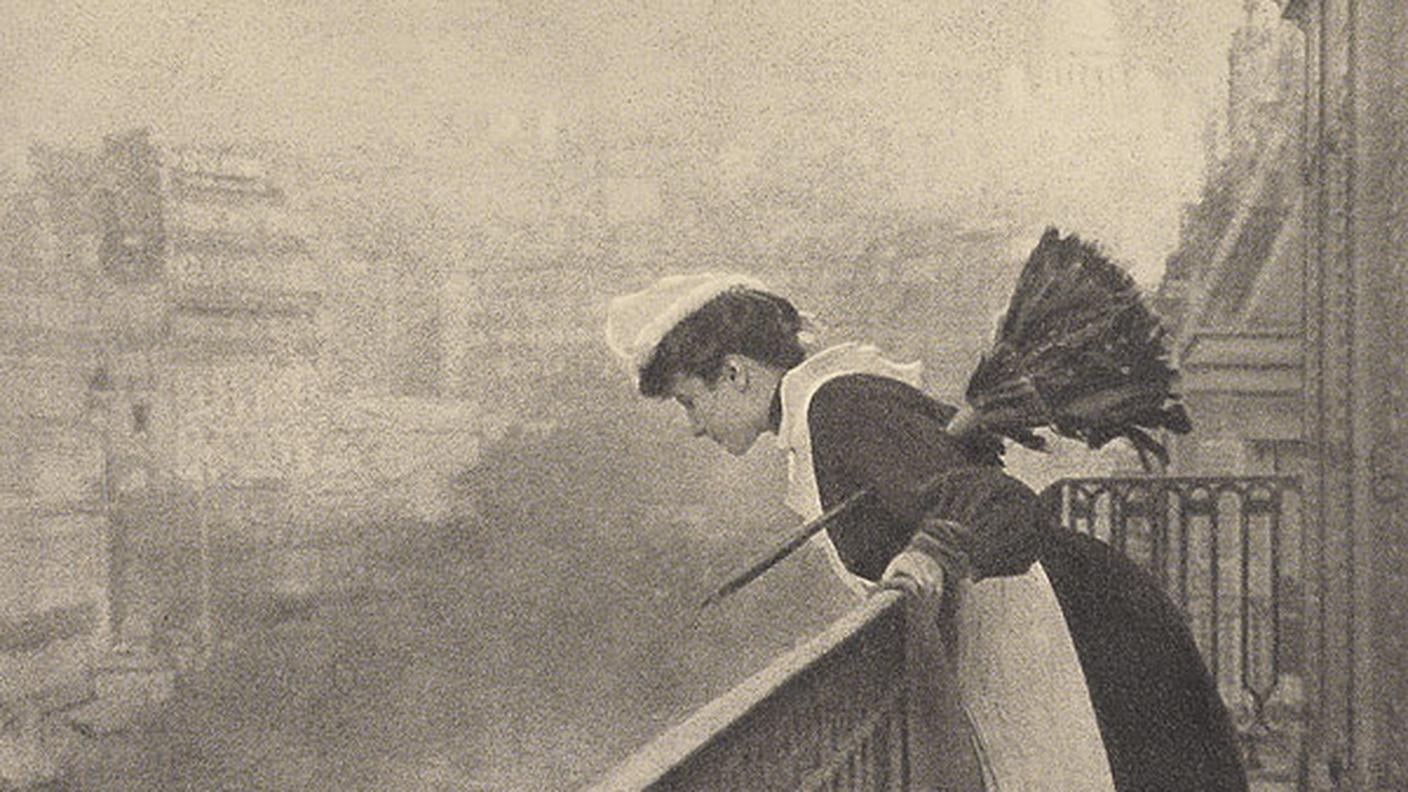Sto rileggendo Primo Levi, Se questo è un uomo, perché voglio tornare a sentire quello che sentivano gli ebrei nel Lager. Ma soprattutto perché vorrei immaginarlo oggi – immaginare quello straordinario scrittore, immaginare quell’impagabile libro – al cospetto della tragedia palestinese.
Un esercizio mentale che andrebbe suggerito a chi ancora presume Levi autore ebraico, quando il suo Olocausto resta – e resterà nei secoli – eminentemente cifra dell’universale e dell’umano.
Certo, nulla è comparabile, in assoluto, allo sterminio nazista. Ogni tentazione a ricondurre la “banalità del male” a una dimensione extra-storica ha qualcosa di irriverente e persino di osceno. E tuttavia non dobbiamo mai dimenticare che né Hannah Arendt né Primo Levi furono testimoni esclusivi della Storia: molto più radicalmente, furono tra i massimi speleologi del disumano.
Con l’azzardo che è delle grandi speranze, degli aneliti più puri e incondizionati, è dunque probabile che al cospetto dei tempi attuali, dell’annoso e decennale “scandalo” mediorientale, immaginerei che né l’uno né l’altro si sarebbero posti storicamente dalla parte della Realpolitik, magari eleggendo le ragioni degli uni a discapito dei torti degli altri, ma avrebbero scelto per sé la denuncia in quanto tale. E a fronte delle “vittime”, che Roger Garaudy declinava nel caso dei Palestinesi come “vittime delle vittime”, avrebbero innazitutto rifiutato qualsiasi partigianeria etnica, razziale o religiosa.
I due mestieri di Primo Levi
RSI Cultura 10.11.2024, 12:16
In effetti rileggendo Se questo è un uomo uno degli aspetti più sconsolanti dell’attuale scenario mediatico e intellettuale – intellettuale si fa per dire – salta subito all’occhio: laddove Levi stigmatizzava nella sua denuncia l’Uomo, quasi ovunque si spinga oggi lo sguardo tra le pagine della stampa compare viceversa quella capziosa e irriducibile forma di partigianeria che l’Uomo sembra deliberatamente perdere di vista. Detto in altre parole: se Levi ha scritto il suo lavoro in nome e nell’auspicio di una diversa antropologia, il discorso mediatico ribadisce al contrario, a spron battuto, l’ossessione per il contingente, quasi a voler rimarcare che il Male non è “banale” – non è cioè universale – ma alligna solo ed eminentemente da qualche parte.
Immaginiamolo allora oggi, questo Primo Levi che ben si guardò dall’intitolare il suo capolavoro Se questo è un ebreo. Saprebbe egli sacrificare il proprio universalismo in virtù degli antecedenti storici che produssero contro gli Ebrei ciò che oggi in larga misura si sta abbattendo contro i Palestinesi? Troverebbe egli sensato avanzare argomenti estorti alla più crassa Realpolitik? O a fronte del Male – sia esso nel terrorismo di Hamas o nell’inaudita vocazione genocida di Netanyahu – tornerebbe a chiedersi, semplicemente, se questo è un uomo?
Già, in definitiva si torna sempre lì. E tuttavia a questo lì – a questo centro di riflessione sulla banalità dell’umano e del disumano – non si torna mai abbastanza. O per meglio dire, la politica e la politologia non vi tornano mai abbastanza. Vi torna la grande letteratura, la grande filosofia, che delle contingenze storiche ha sempre saputo fare delle tragiche ipostasi del dato di fondo e della domanda di fondo: perché l’Uomo può arrivare a tanto? Se lo chiedeva Dostoevskij indagando la Russia negli abissi del sottosuolo, se lo chiedeva il buon vecchio moralista Bezukhov di Tolstoj, se lo è chiesto Solženicyn nel suo Arcipelago Gulag. E se lo chiedono da sempre tutti i grandi geni del romanzo: perché il Male? Ovverossia: perché il Male in sé?
È su questa domanda, in effetti, che le pagine di Primo Levi, la sequela di morti e di dolori che le innerva, continuano a risuonare. Non sulla domanda contingente, relativa e irrilevante – anzi, tanto più foriera di fraintendimenti da ingenerare il cortocircuito della ragione come “spirito di vendetta” – sul perché il Male israeliano, sul perché il Male nazista, sul perché il Male terroristico, ma sul perché il Male in quanto tale.
O altrimenti alla letteratura che servirebbe esistere? Potremmo trastullarci, finalmente liberi di professarci dalla parte assoluta della Ragione, con l’infinita catena delle cause e degli effetti, dei colpevoli e degli innocenti. Potremmo risalire all’indietro fino ai primordi dell’umanità e ripetere pedissequamente: perché qualcuno ha la Colpa primigenia. Ma questa non è una risposta filosofica né tanto meno una risposta letteraria: questa è una risposta giornalistica. Primo Levi non avrebbe mai detto: il Male e la Colpa sono nazisti. Egli avrebbe detto: il Male e la Colpa sono nell’Uomo che si è votato al nazismo. E allo stesso modo, immaginiamo, non avrebbe mai detto: il Male e la Colpa sono di Hamas. Egli avrebbe detto: il Male a la Colpa sono dell’Uomo che si è votato ad Hamas. E forse con più perentoria indignazione, oggi, avrebbe detto: il Male e la Colpa non sono della politica neocoloniale israeliana, ma dell’Uomo che si è votato al neocolonialismo sionista.
E non si tratta di spirito ecumenico, di rassegnazione all’equivalenza. Si tratta di antropologismo portato alle estreme conseguenze. Perché finché non sapremo gridare, oggi, se questo è un Palestinese, non solo non avrà avuto alcun senso gridare se questo è un Ebreo al tempo di Hitler, ma gridare se questo è un Uomo non avrà significato mai nulla. Né per gli uni né per gli altri né per l’Uomo in quanto tale.

Moni Ovadia. Sulla dignità
Segni dei tempi 17.11.2012, 01:00