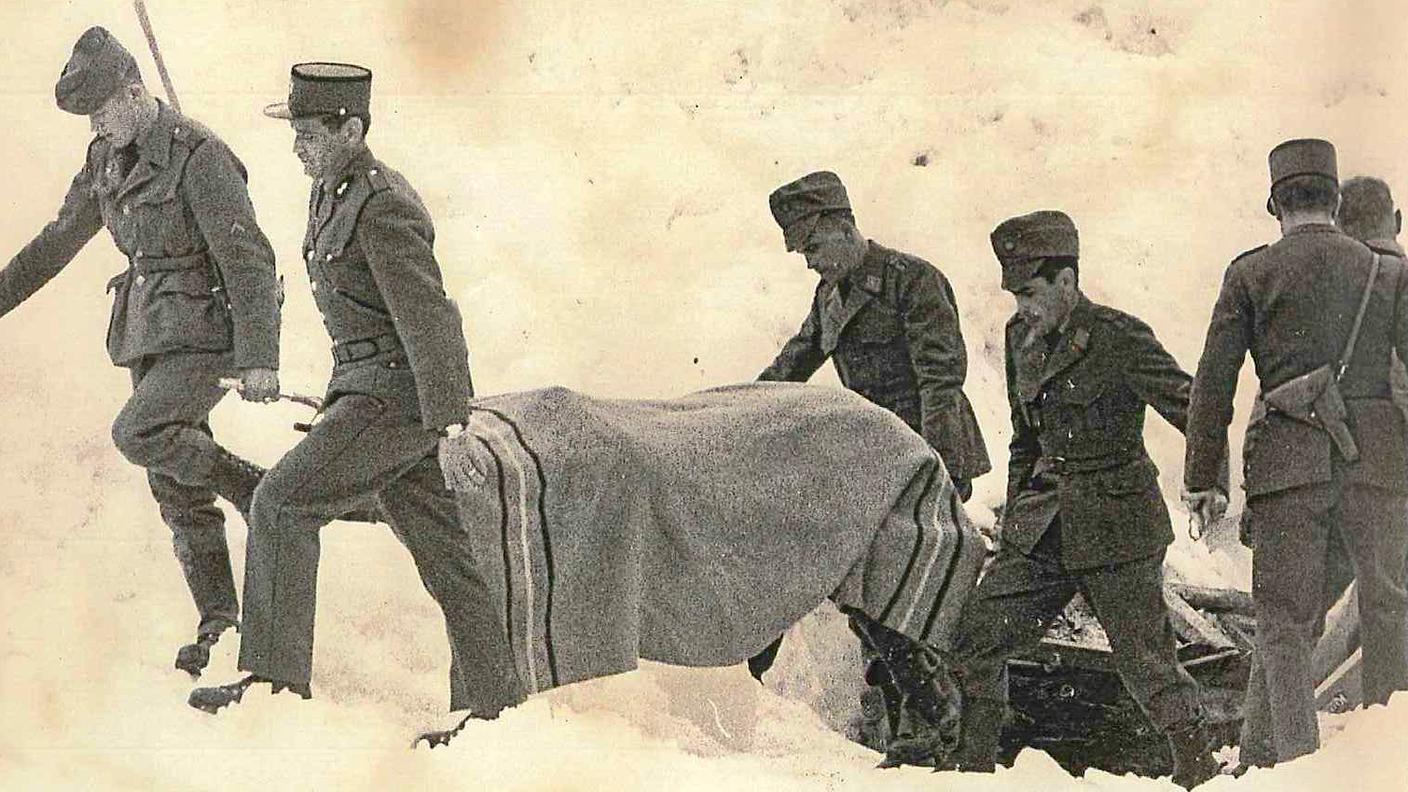La “X” nel suo nome: un’incognita che ancora ci interroga, a un secolo esatto dalla sua nascita, il 19 maggio 1925, e ci ricorda la sfida, ancora attuale, per i diritti civili.
Malcolm X: una figura centrale non solo dell’attivismo afroamericano, ma soprattutto una tra le voci più radicali del Novecento, che incarnò come pochi altri la rabbia lucida di un popolo segnato da secoli di schiavitù, segregazione e marginalizzazione. Dalla leadership nella Nation of Islam alla fondazione di organismi indipendenti come la Muslim Mosque e la Organization of Afro-American Unity, passando per il pellegrinaggio alla Mecca e il tentativo di internazionalizzare la causa afroamericana presso le Nazioni Unite, Malcolm ha portato avanti con forza la sua visione di liberazione fondata su autodeterminazione, orgoglio nero, diritti civili e giustizia globale.
Malcolm X tiene un discorso durante un comizio a Harlem, New York (Foto d'archivio, 29 giugno 1963).
Il motto con cui è ricordato - by any means necessary (con ogni mezzo necessario), spesso associata a un’espressione simile presente nell’opera teatrale del 1948 “Les Mains Sales” di Jean-Paul Sartre - ne ha cristallizzato l’approccio: radicale, determinato, senza concessioni. Non necessariamente violento, ma neppure passivo. È un invito a non accettare mai l’ingiustizia come condizione normale dell’esistenza, una dichiarazione forte e risoluta che implica il diritto, e talvolta la necessità, di utilizzare qualsiasi mezzo sia ritenuto utile o giustificabile per raggiungere un obiettivo giusto, in particolare nel contesto della lotta contro l’oppressione, in contrasto con l’approccio esclusivamente nonviolento di altri movimenti per i diritti civili dell’epoca.
Il suo nome di battesimo era Malcolm Little, nato a Omaha nello stato americano del Nebraska, in una famiglia attivamente coinvolta nel movimento di Marcus Garvey che promuoveva l’orgoglio nero e il ritorno in Africa come forma di liberazione. Little era un cognome molto comune tra la comunità afroamericana data la storia legata alla schiavitù, quando erano i padroni ad assegnare l’identità ai loro servi; la “X” scelta da Malcom fu dunque anzitutto un simbolo del suo rifiuto e del suo disprezzo nei confronti di questa pratica, sottolineando il distacco da quella tradizione e, di conseguenza, l’incertezza delle sue origini.
Come si legge nella sua autobiografia, la famiglia di Malcolm fu segnata da persecuzioni razziali; il padre (un predicatore battista) fu ucciso in circostanze sospette probabilmente da membri di un gruppo suprematista bianco conosciuto come Black Legion, sebbene le autorità dichiararono la sua morte un incidente. Un evento che lasciò una profonda cicatrice in particolare nella madre, minata nel fisico e nella psiche tanto da essere internata in un ospedale psichiatrico, dove rimase per circa 26 anni. Malcolm passò così per riformatori, case-famiglia e carcere.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico, venne segnato da un episodio molto traumatico quando confidò al suo insegnante il desiderio di diventare avvocato, ma si sentì rispondere che quella professione non era “realistica per un negro” (The Autobiography of Malcolm X, Malcolm X e Alex Haley, 1965). Fu uno dei momenti cardine che lo spinsero a interrogarsi radicalmente sulla condizione afroamericana.
Copertina della prima edizione di "The Autobiography of Malcolm X" (1965).
Nonostante avesse ottenuto i migliori risultati della sua classe, Malcolm decise dunque di abbandonare gli studi, per poi precipitare in una spirale di criminalità che lo portò a diventare un delinquente abituale, fino a essere condannato a un lungo periodo di detenzione (dal 1946 al 1952) con le accuse di furto, possesso illegale di armi e violazione di domicilio.
Fu proprio durante il carcere che avvenne in lui una profonda trasformazione filosofica e spirituale: entrò in contatto con le idee della Nation of Islam (N.O.I.), un movimento religioso e sociale afroamericano, nazionalista e anti-integrazionista. Malcom abbracciò la fede e abbandonò il suo “cognome da schiavo”. Dopo la scarcerazione divenne rapidamente uno dei principali esponenti della N.O.I, che sotto la sua guida da piccola setta si trasformò in un movimento di portata nazionale; ne divenne rapidamente il volto pubblico, portando il messaggio nei quartieri afroamericani, nei college e nei comizi, con uno stile oratorio magnetico, tagliente, provocatorio, e con un preciso obiettivo: abbattere le barriere etniche e ogni forma di discriminazione.
A causa di divergenze ideologiche, di comportamento e anche strategiche, l 8 marzo 1964 Malcolm annunciò tuttavia pubblicamente la rottura con la Nation of Islam, e solo pochi giorni dopo fondò una nuova organizzazione che battezzò Muslim Mosque Incorporated. A differenza della N.O.I., questo progetto segnava un distacco dall’idea che la religione dovesse essere l’unico elemento unificante della comunità afroamericana - una posizione che Malcolm aveva già espresso in un discorso interno ai quadri militanti nel novembre del 1963. Così, dopo un pellegrinaggio alla Mecca dove abbracciò l’Islam ortodosso e adottò il suo nuovo nome islamico, fondò anche l’Organizzazione dell’Unità Afro-Americana (OAAU), attraverso la quale sviluppò e divulgò una visione più ampia della sua lotta, che assunse anche una dimensione internazionale. Non più solo una battaglia per i diritti civili, ma una vera e propria lotta per i diritti umani, da condurre su un piano politico e culturale radicalmente trasformativo, collegando l’oppressione dei neri americani alle lotte di liberazione del Terzo Mondo.
Netto, duro, dirompente: il pensiero di Malcolm X non lasciava spazio a compromessi, e proprio per questo generava profonde divisioni. Il 14 febbraio 1965, solo una settimana prima del suo assassinio, la sua casa fu colpita da un attacco incendiario; lui e la sua famiglia riuscirono a salvarsi, ma il segnale era chiaro: la tensione attorno alla sua figura era ormai alle stelle.
Il 21 febbraio, durante un comizio all’Audubon Ballroom di New York, Malcolm X venne infine assassinato a colpi di pistola, davanti agli occhi di sua moglie Betty Shabazz e delle sue sei figlie (Malcolm X: A Life of Reinvention, Manning Marable, 2011). Il suo funerale, celebrato il 27 febbraio ad Harlem, cuore simbolico della comunità afroamericana, attirò oltre un milione e mezzo di persone.
In un clima di sospetti, rivalità e sorveglianza continua da parte dell’FBI, furono arrestati tre membri della Nation of Islam. Solo nel 2021, due di loro sono stati completamente scagionati grazie a una lunga indagine che ha rivelato l’insabbiamento delle prove e le gravi omissioni dell’FBI e della polizia di New York. (Assassinio a Malcolm X, scagionati due dei condannati, swissinfo, 2021). L’ombra della Nation of Islam rimane comunque al centro delle ipotesi: altri nomi, sempre interni all’organizzazione, vengono citati come possibili mandanti, ma il mistero sulle responsabilità reali e sulle eventuali complicità istituzionali continua a pesare sulla memoria pubblica di uno degli omicidi politici più controversi del Novecento americano.

Malcolm X, un’eredità ancora viva (1./5)
Alphaville 17.02.2025, 12:05
Contenuto audio
Un’immagine emblematica quella di Malcolm X, la cui rilevanza resta tuttavia ancora attuale: il processo di decostruzione dell idea di inferiorità delle persone nere rispetto ai bianchi negli USA è infatti una sfida ancora aperta e centrale, come afferma il giornalista Gabriele Santoro nel suo testo Rabbia e giustizia, sull attualità di Malcolm X. Malcolm non era però solo una figura storica: fu anche una voce, uno stile, un lessico, un suono; la sua retorica in effetti, più che una predica era un esplosione controllata, costruita con cura, con ritmo e precisione. In essa risuonano le influenze del teatro e del linguaggio biblico, ma anche l’ironia spietata della strada, la lucidità dell’intellettuale autodidatta e il dolore antico di un popolo ridotto al silenzio. Il professore di letteratura angloamericana Alessandro Portelli ha scritto che “Malcolm X aveva un modo di parlare che apriva gli occhi, che faceva vedere il mondo da un punto di vista diverso: quello dei poveri, dei neri, degli sfruttati.”
Il libro The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X di Les Payne e Tamara Payne (Liveright, 2020), frutto di trent’anni di ricerche, mostra infine con precisione le sfumature dell’evoluzione di un uomo e insieme delle sue contraddizioni: non fu mai un politico nel senso stretto, né un santino. Fu una persona che cercò coerenza tra pensiero e vita, tra fede e giustizia. E fu, fino all’ultimo, un individuo che mai accettò di essere definito da un altro individuo.