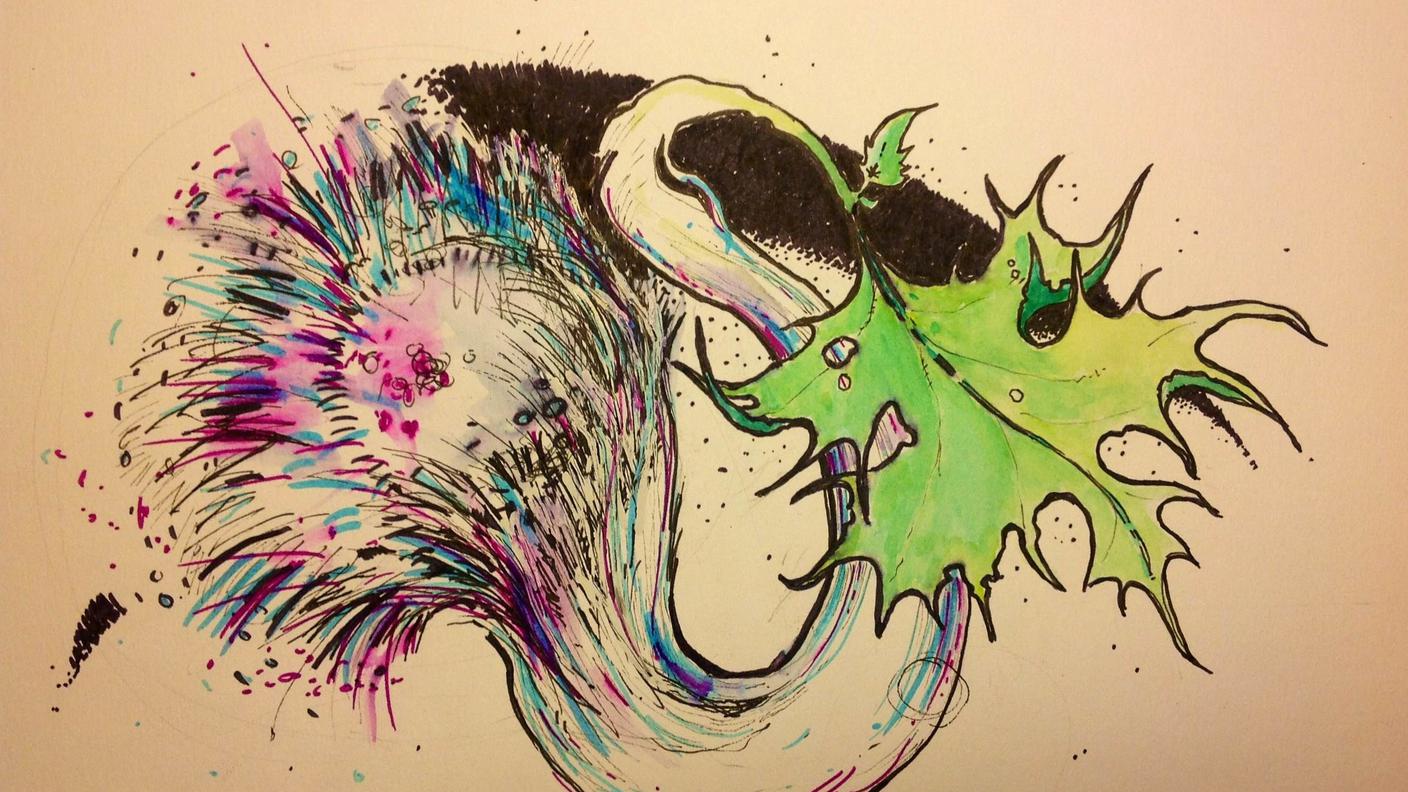Che si tratti di tonalità generate da pigmenti specifici o di tinte strutturali, i colori in natura giocano ruoli molto importanti: intervengono nella riproduzione, aiutano a mostrare la propria forma fisica, a inviare segnali di allarme e avvertimento e servono pure a mimetizzarsi per sfuggire ai predatori.
I colori in natura sono spesso associati ai fiori, le cui variopinte colorazioni sono indispensabili per attirare gli animali coinvolti nell’impollinazione. Possono essere create da pigmenti specializzati, oppure generate per iridescenza grazie a particolari microstrutture presenti sui petali. Alcune piante mostrano inoltre dei particolari colori visibili solo nello spettro ultravioletto, una gamma che il nostro occhio non percepisce, ma che gli insetti invece vedono benissimo. Ad esempio, il rosso acceso dei papaveri non è percepito dagli insetti, che di questo fiore vedono invece la luce ultravioletta riflessa dai suoi petali.

Gli insetti non vedono il rosso del papavero, ma la luce ultravioletta riflessa dai suoi petali
Pillole di colore
La serie “pillole di colore” della redazione digitale del giardino di Albert cerca di rispondere alle domande più insolite e curiose legate al colore nella nostra quotidianità: a che serve il colore in natura? I colori possono davvero influenzare la nostra mente? E com’è riuscito Homo sapiens a produrli nelle varie epoche? Scopri i contributi video legati a quest’articolo dalla pagina Facebook di RSI Cultura!
Un altro esempio di come la relazione tra i fiori e gli insetti impollinatori abbia un’influenza diretta sui colori è quello dei non ti scordar di me. Al centro di questi fiori si trova una piccola corona ben visibile a occhio nudo. Quando il fiore è pronto per essere impollinato e dispone di una buona quantità di nettare, la corona è di colore giallo, mentre diventa bianca – meno seducente per l’impollinatore – dopo la fecondazione.
Sempre in ambito botanico non va dimenticato il verde, generato dalla presenza della clorofilla. Pigmento fondamentale per la fotosintesi, ha la particolarità di non assorbire le lunghezze d’onda associate al verde, che sono così riflesse e visibili ai nostri occhi.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/Animali-scienza-e-colori--2165085.html
Uno degli aspetti chiave per garantire la sopravvivenza di una specie è la capacità di riprodursi e dare alla luce una nuova generazione con successo. Per farlo, nel regno animale la prima tappa è quella di trovare il partner giusto, cioè quello che dal punto di vista evolutivo ha i geni migliori, è in salute e sa procacciare il cibo per la prole.
Dal momento che i geni sono racchiusi all’interno delle cellule, gli animali hanno bisogno di indizi facilmente visibili per capire chi porta quelli buoni e chi è in salute. Un segnale chiaro è dato dal colore: il piumaggio sgargiante di numerose specie di uccelli, oppure la vistosa colorazione dei mandrilli maschi, sono un chiaro esempio di come il colore indichi lo stato fisico dell’animale. Il messaggio è limpido: più son colorato e più sono in forma!

Nel mandrillo maschio, il colore è direttamente legato allo stato di salute dell'animale
Ma la colorazione può avere anche un effetto dissuasivo nei confronti dei predatori. A volte l’animale è colorato con toni vivaci, decorati con delle striature o dei puntini per indicare la sua tossicità. Non mangiarmi, sono pericoloso! Pensiamo alle vespe, alle api, ma anche ad alcune cimici. Tutti animali che possiedono un pungiglione e/o del veleno. La colorazione che indica una reale pericolosità è detta aposematica. Oltre agli insetti, la troviamo in altri gruppi animali, come gli anfibi, i pesci, eccetera. Ed è presente anche nelle piante.
E poi ci sono le specie che non sono tossiche o velenose, ma imitano il colore di un altro organismo che invece lo è. In questo caso si parla di mimetismo batesiano (da Henry Bates suo scopritore). Uno degli esempi più famosi è quello dei sirfidi, degli insetti totalmente inoffensivi appartenenti all’ordine dei Ditteri - parenti cioè di mosche e zanzare - , la cui livrea ricorda però quella delle vespe e delle api.

I sirfidi sono insetti totalmente inoffensivi che imitano la colorazione delle vespe e delle api
Uno dei casi più strabilianti di mimetismo in natura è quello della falena Macrocilix maia, diffusa in Asia. Le sue ali sono caratterizzate dalla presenza di un disegno particolare, che non riproduce trame e colori di pericolo e nemmeno imita un animale velenoso. No, la colorazione mima una scena più elaborata, come se fosse un dipinto.
A guardarla bene si vedono due mosche indaffarate - per così dire - con del guano di uccello. Una vera opera d’arte dell’evoluzione, resa più realistica dall’odore di escrementi prodotto dalla stessa farfalla. Si tratta di un sistema di difesa molto efficace: molti predatori evitano infatti di mangiare insetti che si nutrono di feci, perché potrebbero essere vettori di malattie.

Il disegno sulle ali di Macrocilix maia riproduce la scena di due mosche vicine e delle deiezioni di uccelli
https://rsi.cue.rsi.ch/info/ambiente/Come-si-producevano-i-colori-nell%E2%80%99antichit%C3%A0--2864087.html
L’evoluzione si è davvero sbizzarrita nell’uso del colore. Le rane di vetro, tra cui la specie Hyalinobatrachium fleischmanni, protagonista di uno studio pubblicato nel 2022, non sono completamente trasparenti. Il loro dorso è di colore verde brillante, e le aiuta a confondersi nel fogliame delle foreste in cui vivono. A essere traslucido è il ventre, che permette di vedere tutti gli organi interni dell’animale. Non solo sono tra i pochi animali a essere trasparenti: queste rane hanno la capacità di far sparire alla vista anche gli organi. Per farlo, quando dormono spostano il 90% dei loro globuli rossi nel fegato, diventando così da due a tre volte più trasparenti e invisibili ai predatori. Al risveglio, i globuli rossi ritornano al loro posto e il sangue riprende il suo colore naturale, rendendo la rana nuovamente visibile.
Insomma, in natura se ne vedono davvero di tutti i colori!