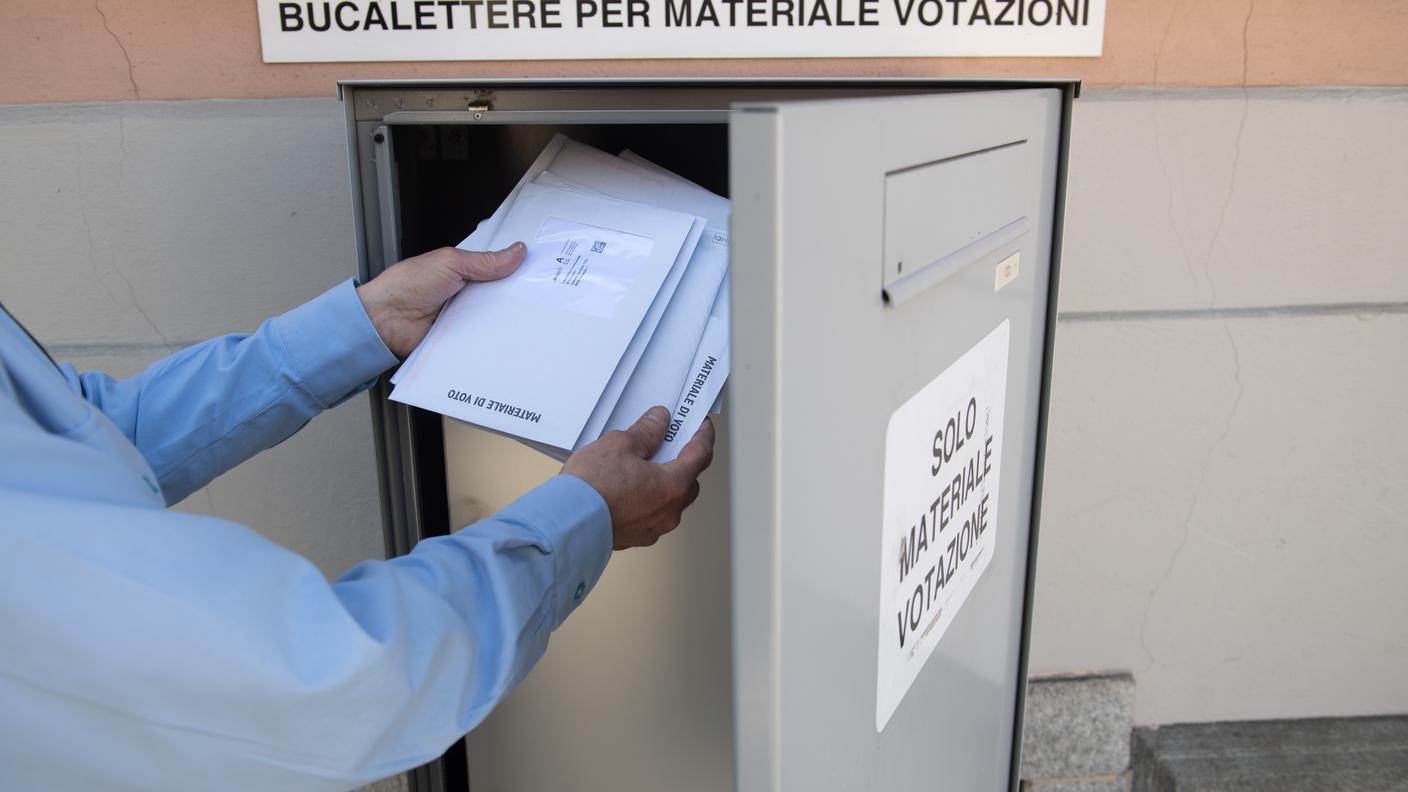Nel 1979, una risicata maggioranza di svizzeri disse “no” a qualcosa che oggi si dà per scontato: il diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni. Alcuni degli argomenti dell’epoca possono sembrare un po’ antiquati alle orecchie moderne. “I giovani di oggi sono certamente più disinibiti e precoci rispetto al passato, ad esempio in ambito sessuale – ma ciò non prova che siano più maturi politicamente o caratterialmente”, disse ai tempi un consigliere agli Stati. L’età di voto rimase a 20 anni.
Ma la storia stava andando in un’altra direzione. Già nel 1969, il Regno Unito aveva abbassato l’età di voto da 21 a 18 anni. Gli Stati Uniti fecero lo stesso nel 1971. Paesi come Australia, Svezia e Francia seguirono la tendenza negli anni ’70. E in Svizzera, dopo che vari Cantoni abbassarono l’età negli anni ’80, si tenne un nuovo voto nazionale nel 1991; questa volta la proposta passò con una maggioranza del 73%.
Raggiunto il limite
Trent’anni più tardi, il dibattito sull’età “giusta” per votare continua, ma il limite inferiore sembra essere stato raggiunto, almeno per il momento, in Svizzera. L’idea di concedere il diritto di voto ai 16enni e 17enni riemerge regolarmente, e viene immancabilmente respinta. Il Parlamento ha bocciato una proposta lo scorso anno, mentre otto Cantoni, l’ultimo dei quali Lucerna, l’hanno rifiutata tramite votazione popolare. Il Canton Glarona è rimasto l’unica eccezione, avendo approvato la misura nel 2007.
Perché questa idea non decolla? Un nuovo studio del Centro per la Democrazia di Aarau (ZDA) suggerisce che la causa non sia da ricercare nell’(im)maturità politica dei giovani stessi. Secondo i dati raccolti tramite sondaggi, la percezione civica dei cittadini svizzeri tra i 16 e i 17 anni è praticamente identica a quella dei giovani tra i 18 e i 25 anni: i minorenni sono altrettanto interessati alla partecipazione politica, altrettanto esposti al dibattito pubblico e consumano persino più informazioni politiche rispetto ai loro coetanei appena più grandi.
Per Robin Gut, coautore dello studio, i risultati sono sorprendenti. “Pensavamo che i cittadini di 16 e 17 anni avrebbero mostrato un minore interesse per la politica, dato che non hanno ancora diritto di voto. Ma alla fine non c’era alcuna differenza, o solo minima, tra i gruppi di età”.
Voterebbero?
Anche se lo studio suggerisce che i giovani cittadini siano soggettivamente “pronti” e interessati, non è ancora chiaro in che misura effettivamente andrebbero a votare, se ne avessero la possibilità.
Un sondaggio del 2014 ha rilevato che la maggioranza dei 16enni e 17enni in Svizzera era favorevole a mantenere l’età di voto com’era.
A Glarona, dove il sistema politico è caratterizzato dalla Landsgemeinde, i dati aneddotici sull’impegno giovanile dal 2007 in poi sono positivi. Tuttavia, i colleghi di Gut al ZDA hanno anche stimato che i giovani del Cantone votano meno rispetto ai cittadini più anziani, soprattutto sulle questioni locali.
Guardando oltre i confini, Argentina, Austria, Brasile, Ecuador e Malta hanno abbassato l’età di voto a 16 anni a livello nazionale. Alcuni Stati europei hanno fatto lo stesso a livello locale o regionale.
Gli studi sull’impatto di questa riforma sono generalmente positivi. In Scozia, i nuovi elettori di 16 e 17 anni hanno partecipato in massa al referendum sull’indipendenza del 2014 e hanno continuato a essere attivi anche in seguito. Anche in Austria, i 16enni e 17enni tendono a votare più rispetto ai nuovi elettori più anziani, e inoltre non votano in modo significativamente diverso, come riporta un rapporto del Consiglio d’Europa.
Elettori riluttanti
Una riforma di questo tipo, tuttavia, non è una soluzione miracolosa per risolvere la generale alienazione politica dei giovani. Il recente Global Youth Participation Index, che analizza 141 paesi attraverso una serie di indicatori socio-economici, civici e politici, non attribuisce un peso particolarmente rilevante all’abbassamento dell’età di voto – e nessuno dei primi dieci paesi in classifica consente di votare a 16 anni.
In generale, afferma Kirstie Dobbs del Merrimack College, che ha contribuito al rapporto, la dimensione “elezioni” è risultata una delle più deboli dell’intero indice. I giovani, in questo caso definiti in modo ampio come persone tra la metà dell’adolescenza e la fine dei vent’anni, “non sono particolarmente attratti dalle elezioni”, afferma.
Dobbs elenca alcune ragioni. Una è che i giovani hanno semplicemente altre priorità, come trovare una direzione professionale e personale. Un’altra riguarda la fiducia nelle procedure elettorali. Una ricerca precedente condotta da Dobbs in Tunisia dopo la Primavera Araba, ad esempio, ha rilevato che i giovani erano politicamente motivati, ma consideravano le elezioni corrotte.
Anche in una democrazia consolidata come l’Austria, lo Youth Participation Index osserva che il vantaggio di un’età di voto più bassa è controbilanciato da un “calo crescente della fiducia nei partiti politici”. L’Austria si è classificata al 14° posto.
In questo contesto, Dobbs ritiene che l’abbassamento dell’età di voto non faccia una grande differenza, almeno non da solo. “È un ottimo punto di partenza a livello politico, ma l’impatto dipende da ciò che lo circonda”, afferma. La cultura familiare, l’istruzione e il capitale sociale (cioè quanto si è integrati in una comunità) sono fondamentali. Inoltre, secondo Dobbs, la politica e i partiti politici non riescono ancora a raggiungere i giovani in modo efficace attraverso i canali digitali. Nel frattempo, i dibattiti sull’età per votare restano sempre lontani da temi come la salute mentale, aggiunge. “Come puoi convincere qualcuno ad andare a votare se non riesci nemmeno a farlo alzare dal letto la mattina?”
Inclusione democratica e giustizia
Robin Gut, dello ZDA, concorda sul fatto che abbassare l’età di voto non sarebbe una “svolta”, anche per quanto riguarda i potenziali effetti sulle votazioni in Svizzera. Secondo i suoi calcoli, i 16enni e 17enni rappresenterebbero il 2,4% di un elettorato svizzero ampliato, una quota significativa, ma non sufficiente a ribaltare l’esito di votazioni in cui prevale l’elettorato più anziano, come ad esempio la riforma delle pensioni. Al massimo, i giovani potrebbero fare la differenza in situazioni molto equilibrate, come la decisione del 2020, approvata dal 50,1% dei votanti, di acquistare nuovi aerei da combattimento.
Nel complesso, Gut sostiene comunque che, da un punto di vista scientifico, “nulla si oppone all’abbassamento dell’età di voto”. Gli ostacoli sono più politici che empirici, afferma: il tema semplicemente non ha priorità rispetto a sicurezza, politica climatica, riforma delle pensioni o sanità. Inoltre, i giovani non dispongono di una lobby forte né di finanziamenti adeguati, aggiunge Gut, e manca anche un consenso trasversale tra i partiti, con la riforma principalmente sostenuta dalla sinistra.
Con l’invecchiamento della popolazione, l’età di voto assume anche una crescente importanza in termini di giustizia democratica, osserva Gut. Da un lato, abbassarla sarebbe un “segnale” per dimostrare ai giovani che vengono presi sul serio. Dall’altro, diventa sempre più problematico che siano gli elettori più anziani ad avere così tanto potere decisionale su quelli più giovani. “Nel medio-lungo termine, con l’età mediana degli elettori che si avvicina ai 60 anni, dobbiamo affrontare questa questione” afferma.
Naturalmente, abbassare l’età di voto non può invertire le dinamiche demografiche, può solo mitigarne leggermente gli effetti. Per evitare davvero una futura gerontocrazia, Gut propone altre idee, come il diritto di voto familiare, o l’obbligo che una votazione ottenga anche la maggioranza tra gli under 40 per essere approvata. Idee che, ammette lui stesso, hanno ancora meno possibilità di successo rispetto all’abbassamento dell’età di voto.
Radiogiornale delle 07.00 del 29.07.2025: Il servizio di Alessio Veronelli sul voto elettronico in Svizzera
RSI Info 29.07.2025, 07:00
Contenuto audio