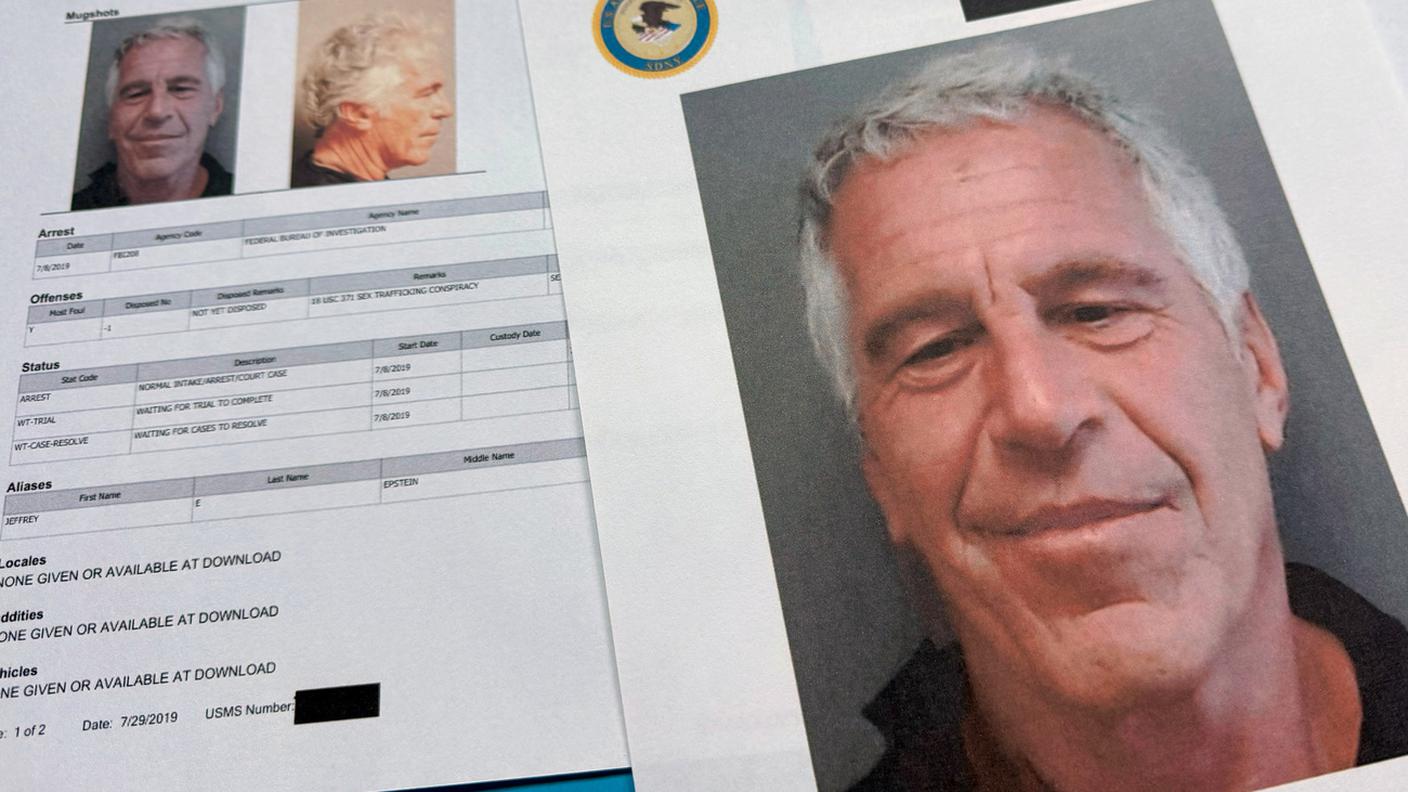La guerra dei dazi lanciata da Donald Trump sta forse attraversando una fase un po’ meno calda, come hanno in particolare mostrato i recenti negoziati a Ginevra fra USA e Cina. Lo stesso capo della Casa Bianca, partito lancia in resta per la sua offensiva commerciale, ha poi fatto dietrofront su più versanti, concesso tregue e sembra ora avere propositi meno aggressivi. Un po’ per effetto delle contromisure di non pochi Paesi, ma anche per l’impatto di questa politica daziaria sulla stessa economia degli Stati Uniti.

Alla politica dei dazi di Trump hanno fatto seguito più appelli al boicottaggio dei prodotti statunitensi
Questa situazione di stand-by potrebbe preludere a sviluppi più confortanti per gli esiti del confronto commerciale fra gli USA e il resto del mondo. Non sembra però aver affievolito un movimento di protesta che in vari Paesi, segnatamente sui social, punta al boicottaggio dei prodotti americani: si va da appelli generici ai consumatori, fino a vere e proprie liste di prodotti da mettere all’indice in risposta alla politica di Trump e ai suoi effetti per le economie degli altri Stati. Intanto un sondaggio ha evidenziato una netta propensione dei consumatori di cinque Paesi europei, fra i quali anche la Svizzera, a evitare gli acquisti di prodotti USA.
La sfida di restare sul pezzo
Campagne di astensione dai consumi accompagnano da decenni le proteste contro le politiche di multinazionali e Stati. Le motivazioni, per lo più, sono legate a questioni di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale. I giudizi sugli esiti sono stati spesso controversi. Ma quale potrebbe essere però la loro efficacia, nel momento in cui la protesta è veicolata da motivazioni di difesa della propria economia nel suo insieme?
Barbara Antonioli Mantegazzini, economista, è professoressa ordinaria presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Il punto è che ogni azione di boicottaggio, al netto degli slanci di natura emotiva, deve sempre fare i conti con tutta una serie di problemi, ci spiega Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa ordinaria presso la SUPSI in economia pubblica e in politiche per la sostenibilità. Uno dei primi concerne “chiaramente la sostituibilità dei prodotti”: è infatti “abbastanza difficile che l’astensione dal consumo perduri nel tempo”, se i beni presi di mira dal boicottaggio “non hanno alternative facilmente reperibili sul mercato” e anche comparabili sul piano di qualità e prezzi.
Ma un’altra criticità è legata all’esigenza di avere “un’adesione abbastanza ampia da parte dei consumatori”: si tratta insomma di raggiungere numeri piuttosto elevati, avendo a che fare con soggetti che sono “molto eterogenei nei loro valori, nei gusti e nella disponibilità a sacrificare una certa dose di convenienza, di comfort e di abitudine”. Il boicottaggio, infine, rappresenta un’azione collettiva che va mantenuta nel tempo. Ciò implica “costi di coordinamento abbastanza elevati”, vista la necessità di “tenere alta l’attenzione pubblica”, di “aggiornare le informazioni” e di assicurare una “coerenza dei comportamenti individuali”. Tutte esigenze non da poco.

Dagli scaffali di un supermarket in Danimarca: cartellini dei prezzi contrassegnati da una stella, per aiutare i consumatori a identificare e acquistare generi alimentari prodotti in Europa
Malgrado gli esiti dei boicottaggi siano spesso di breve durata, “in alcuni casi possono produrre effetti significativi anche nel medio-lungo termine, soprattutto in termini reputazionali”. Le imprese e i marchi al centro di contestazioni possono infatti subire danni immediati, “ma anche conseguenze più persistenti in termini di percezione pubblica e posizionamento di mercato”. Come nel caso di un noto brand della birra che, in seguito alle polemiche suscitate da una sua campagna pubblicitaria, registrò un calo delle vendite del 26% già nel primo mese per poi perdere la propria posizione di leader nel mercato statunitense. Si trattò, osserva Antonioli Mantegazzini, di un esempio rappresentativo “di come un’azione di boicottaggio, anche se circoscritta nel tempo, possa generare ripercussioni economiche e reputazionali anche per periodi più estesi”.
Il rischio di effetti collaterali
A dover fronteggiare più boicottaggi, per accuse di politiche antisindacali, è stata negli scorsi anni anche una grande multinazionale del caffè. Ma a fronte anche in questo caso di una diminuzione del fatturato, ci fu in seguito l’annuncio da parte dell’impresa della “chiusura di diversi punti vendita, con una serie di perdite di posti di lavoro”. Ciò evidenziò una volta di più un dato essenziale: il boicottaggio rappresenta infatti “uno strumento di pressione dal basso molto importante”, che può però anche indurre effetti collaterali “sicuramente non auspicabili”.

Il boicottaggio può indurre una pressione al ribasso sui prezzi, rendendoli così più attrattivi per consumatori meno sensibili, o anche indifferenti, alle istanze legate alle campagne
Le ripercussioni infatti non investono solo i vertici aziendali, ma “anche tutti i lavoratori lungo la filiera”. Ed eventuali contromisure da parte delle aziende possono anche “rendere il boicottaggio controproducente” a medio-lungo termine. C’è poi anche un altro rischio: le aziende prese di mira, “pur di mantenere le quote di vendita o quantomeno smaltire le scorte”, possono infatti decidere di reagire abbassando i prezzi. E questa pressione al ribasso rende di fatto i prodotti più accessibili a “consumatori che potrebbero essere meno attenti ai motivi del boicottaggio o addirittura contrari” alla sua logica.
Tornando però al clima di protesta contro i dazi di Trump, va attentamente considerato un ulteriore aspetto. Ci sono infatti prodotti americani, in fatto di brand, che escono però da stabilimenti con sede in Europa. Del resto, con la globalizzazione, “diversi brand operano con catene del valore che sono complesse e geograficamente molto distribuite”. Il boicottaggio può quindi anche generare conseguenze immediate a livello locale, “con una riduzione della produzione in siti che magari non sono quelli che si immaginavano” e possibili riflessi sulla loro forza lavoro. Un effetto boomerang, in sostanza, per realtà produttive e occupazionali che sono presenti proprio nei Paesi che si vorrebbero proteggere dalle politiche USA.
Schierarsi tramite i propri acquisti
Ad ogni modo l’indignazione per le conseguenze dei dazi sembra ormai fare una differenza rispetto a precedenti campagne di astensione dai consumi. Il boicottaggio quindi, viste le dinamiche geopolitiche in atto, si configura quindi sempre di più come “un modo per esprimere un giudizio politico attraverso le scelte di consumo”: come a dire che ci si schiera, “si vota”, attraverso i propri acquisti. Rispetto al passato si registra quindi “una maggiore carica emotiva”, ma anche una polarizzazione che “potrebbe addirittura sfociare in comportamenti estremi”. Come nel caso degli atti vandalici che hanno colpito Tesla e che certamente non hanno nulla a che fare con l’etica del boicottaggio. I rischi di derive e di strumentalizzazioni, vista la maggiore visibilità e viralità delle campagne, possono quindi essere molto elevati.

Acquisti, scelte di consumo che sottendono un giudizio politico
In conclusione, il boicottaggio si configura come una forma di pressione dal basso “che, pur fra limiti e criticità, continua a mostrare una certa capacità di incidere sul comportamento delle imprese e di stimolare dibattiti pubblici”. L’efficacia di questo strumento “dipende da numerosi fattori, dalla sostituibilità dei prodotti alla coesione dei consumatori, e i suoi effetti possono andare ben al di là degli obiettivi dichiarati”. Per questa ragione, più che come uno strumento ideologico o risolutivo, “andrebbe considerato come un fenomeno complesso da osservare con attenzione”, rileva l’esperta, esaminando “caso per caso l’equilibrio tra impatto simbolico, conseguenze economiche e possibili effetti collaterali”.
Da SEIDISERA del 19.05.2025
RSI Info 20.05.2025, 11:20
Contenuto audio