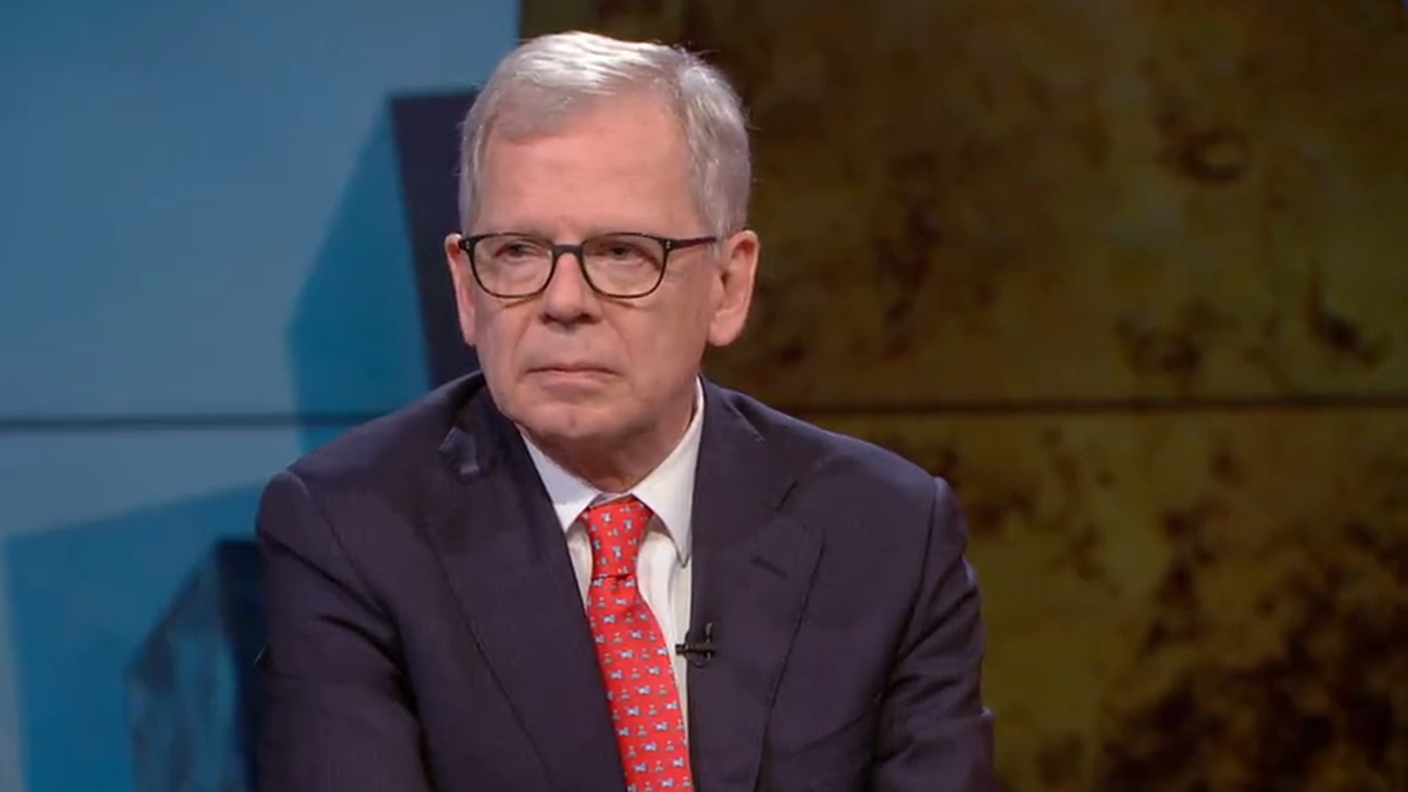“Lo Stato neutrale non sostiene militarmente nessuna delle parti. Non significa neutralità d’opinione: la Svizzera ha il diritto e il dovere di esprimere posizioni anche forti”. A sottolinearlo è l’ex ambasciatore Bernardino Regazzoni. La RSI lo ha intervistato a margine delle celebrazioni per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, organizzate lo scorso weekend dal Comune di Roveredo e dalla Parrocchia di San Vittore. Il ticinese, entrato al Dipartimento degli affari esteri dopo il dottorato in filosofia, che in carriera ha rappresentato la Svizzera in Sri Lanka, Italia, Francia, Costa D’Avorio, Congo, Indonesia e Cina, è intervenuto presso il Centro della Pace - Cappella di Santa Croce proponendo una riflessione su neutralità, diritto internazionale umanitario e universalità dei diritti umani. Temi di strettissima attualità dato quanto sta succedendo nel mondo e di riflesso anche in Svizzera.
La neutralità svizzera è un valore fondante, ma spesso discusso. Che significato ha oggi?
Ognuno ha la sua idea di neutralità, e se chiedessimo a dieci persone otterremmo dieci risposte diverse. Ma la neutralità, in senso giuridico, è molto semplice: in caso di conflitto militare aperto, lo Stato neutrale non sostiene militarmente nessuna delle parti. Non significa neutralità d’opinione: la Svizzera ha il diritto e il dovere di esprimere posizioni anche forti. Ma non deve fornire sostegno militare. Questo è il nocciolo. Gli stereotipi ci portano a sopravvalutare o sottovalutare la neutralità. Non è la panacea universale. Non significa che tutti i conflitti passino automaticamente da Berna o da Ginevra. È uno strumento che va usato con realismo e responsabilità.
Perché la Svizzera viene considerata una “potenza diplomatica discreta ma influente”?
Per diverse ragioni. Anzitutto per la sua politica di pace attiva. Penso al mio coinvolgimento in Sri Lanka, negli anni del conflitto etnico, quando la Svizzera facilitava il dialogo sul federalismo e sul cessate il fuoco. O in Indonesia, nelle province di Aceh e Papua. Poi c’è il ruolo di potenza protettrice: quando due Stati non si parlano, possono nominare un Paese terzo come canale di comunicazione. È ciò che avviene da decenni tra Stati Uniti e Iran, attraverso la Svizzera. Infine, la Ginevra internazionale: già sede della Società delle Nazioni dopo la Prima guerra mondiale, è diventata la sede europea delle Nazioni Unite. Ginevra è un luogo unico, che rende naturale incontrarsi in Svizzera. Non significa monopolio, perché c’è concorrenza e impegno economico, ma resta un punto forte.
In passato la diplomazia svizzera ha coinvolto anche personalità esterne, come capitani d’industria. Oggi com’è cambiata la situazione?
La diplomazia è un mestiere che si impara, ma non è un’esclusiva. Altri profili possono portare competenze utili. Negli anni ci sono stati innesti “non di carriera”, come quelli che lei ricordava. Personalmente li ho sempre guardati con favore, purché ci fosse reciprocità. Oggi, tra diplomazia classica e cooperazione allo sviluppo, le carriere sono più integrate. Si incontrano percorsi diversi che arricchiscono la professione. È giusto mantenere una specificità, con criteri chiari, ma senza ridurre tutto a un unico modello.
La Svizzera, piccolo Stato, può rischiare scenari simili a quelli di Paesi fragili come il Libano?
Non farei paragoni diretti: ogni Paese ha la sua storia. La Svizzera ha costruito un sistema federale equilibrato, che distribuisce potere e risorse tra regioni e lingue. Non è un modello esportabile, ma è stato efficace per noi. Detto questo, nessuno è al riparo. Lo abbiamo dimenticato per decenni, ma la guerra è tornata in Europa. La Prima guerra mondiale non la voleva nessuno: eppure è scoppiata per concatenazioni impreviste. Lo stesso può accadere oggi. Per questo, oltre a difendere le regole del diritto internazionale, dobbiamo garantire la nostra sicurezza, anche attraverso spese di difesa adeguate. Non è un discorso popolare, ma è realistico.
Lei ha parlato anche di diritto internazionale umanitario.
Sì. Credo sia una delle specificità svizzere più preziose, più ancora della neutralità. Le Convenzioni di Ginevra, ratificate da quasi tutti gli Stati, dicono che anche la guerra ha delle regole. La più importante è proteggere i civili. Questa sostanza elementare andrebbe ricordata più spesso. La Svizzera dovrebbe impegnarsi di più a diffondere queste regole, perché conoscerle e farle conoscere cambia il modo in cui guardiamo ai conflitti. I “buoni uffici” sono una formula spesso generica; il diritto internazionale umanitario, invece, ha contenuti concreti e universali.
Alla luce della sua esperienza, le regole internazionali sono davvero universali o solo “occidentali”?
È un tema cruciale. Io credo che siano universali. Basta guardare alla genesi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: non fu un prodotto occidentale, ma il frutto del lavoro di delegati provenienti da diverse culture. Il più convinto sostenitore dell’universalismo fu proprio il delegato cinese, che si basava sulla filosofia di Mencio e sulla bontà intrinseca dell’essere umano. Certo, oggi ci sono tentativi di creare regole alternative, da parte di autocrazie e teocrazie. Ma la distinzione fondamentale non è tra Occidente e resto del mondo: è tra Stato di diritto, nelle sue diverse forme, e autocrazie. Il rischio più grande è che siamo noi stessi, per primi, a minare l’ordine nato dopo la Seconda guerra mondiale, abbandonando l’idea di regole e glorificando solo la forza.
Ambasciatore, lei ha servito in numerosi Paesi. Come si vive una carriera così itinerante e quali ricordi conserva?
La domanda mi è stata posta più volte, e confesso di averne discusso a lungo anche con mia moglie, che è qui presente: abbiamo condiviso insieme 35 anni di tappe diplomatiche. Un diplomatico non può permettersi di partire con idee preconcette. L’immagine che ci facciamo di un Paese, spesso basata su una fotografia o su cinque minuti di televisione, non basta per affrontarne la realtà. Senza apertura, curiosità e gusto della scoperta ci si prepara all’infelicità. Io ho avuto la fortuna di possedere almeno in parte queste qualità e ogni Paese mi ha dato qualcosa. Se però devo citare un’esperienza che mi ha segnato in modo particolare, penso ai miei primi incarichi in Africa: la Costa d’Avorio e soprattutto Kinshasa, nell’attuale Repubblica Democratica del Congo. All’inizio della carriera, appena sposati, ci siamo trovati in contesti difficili ma umanamente ricchissimi. Lì ho imparato che, alla fine, ciò che resta non sono i dossier o le imprese ufficiali, ma la gente incontrata.

GrigioniSera del 25.09.25: il servizio di Alessandro Tini sulle celebrazioni per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale
RSI Info 25.09.2025, 19:00
Contenuto audio
In bassa Mesolcina nel weekend si è commemorato San Charbel Makhlouf, traslando le reliquie di questo santo della pace libanese accanto a quelle di San Nicolao della Flūe nella Cappella di Santa Croce - Centro della Pace, a San Vittore. Charbel, una figura di silenzio e contemplazione. Cosa può apprendere un diplomatico dal silenzio?
La diplomazia è un mestiere di contatto. Si impara con l’esperienza: non serve nascere con il dono naturale. Il diplomatico vive immerso nella parola: bilaterale o multilaterale, è sempre un continuo scambio. Non si dicono sempre cose geniali, ma è proprio dall’interazione costante che può nascere qualcosa di importante. Il silenzio, però, ha un ruolo complementare. È il momento in cui le parole decantano, diventano più chiare, acquistano significato. Senza pause, la parola diventa chiacchiera. Ai santi appartiene il silenzio, ai diplomatici la parola: ma l’una non esiste senza l’altra.
Quest’anno ricordiamo gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Quale eredità resta oggi viva?
La risposta immediata sarebbe: la pace. Ma rischia di restare troppo generica. Preferisco guardare a ciò che sorse subito dopo: la Carta delle Nazioni Unite, adottata pochi mesi dopo la fine del conflitto. Quella Carta è alla base del diritto internazionale contemporaneo: ha proibito l’uso della forza come strumento di politica estera e ha posto le tre colonne delle relazioni internazionali – diritti umani, sviluppo e sicurezza. Oggi queste regole sono spesso infrante o messe in ridicolo. Ma proprio per questo è essenziale ricordare che esistono. È diverso violare una regola che tutti hanno riconosciuto piuttosto che vivere in un mondo dove non ci sono regole. Leggere e rileggere la Carta delle Nazioni Unite o la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sarebbe un esercizio salutare anche oggi.
Ospite: Bernardino Regazzoni
Lo Specchio 05.02.2023, 19:20