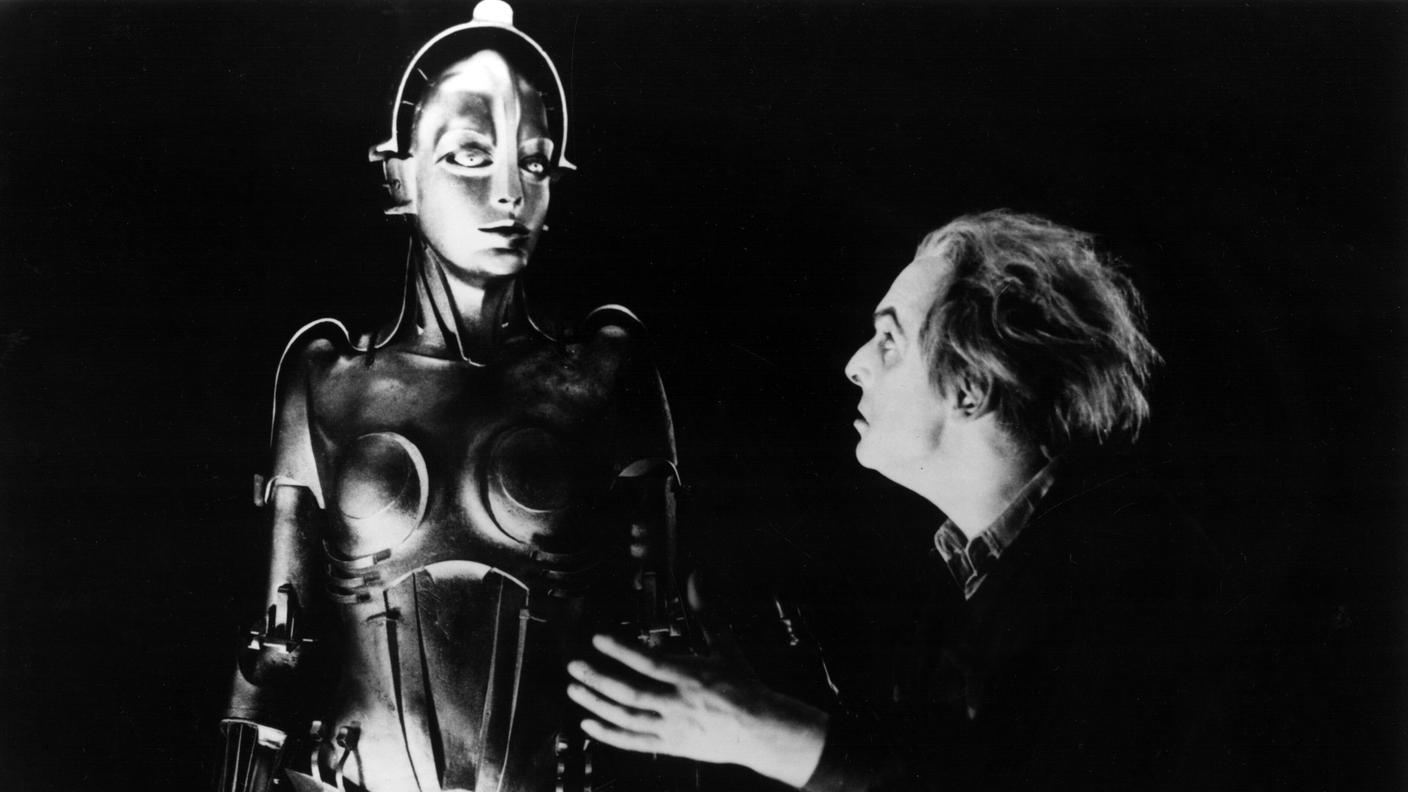C’erano una volta film italiani per i quali bastava acquistare all’Upim dei modellini giocattolo, attaccarli a dei fili invisibili, posizionare strategicamente la macchina da presa e simulare un volo spaziale. Et voilà: una sequenza era stata girata.
Erano i primi anni Sessanta, si cominciava a essere felici e ottimisti e si pensava al futuro come a un suono onomatopeico di fumetto: Boom!
Il design. La moda. L’arte. La musica. Tutto era pop. Facile. Consumabile. E il futuro sembrava così vicino, così come la luna. Lontano dalla povertà neorealista, in piena commedia italiana, il cinema appariva davvero un Re Mida. Tutto ciò che toccava, qualsiasi genere cinematografico, diventava oro: si riusciva con pochi soldi a realizzare dei western da far invidia agli stessi americani, degli spionistici che, per inventiva e fantasia negli intrecci, lasciavano stupefatto anche il James Bond originale, dei peplum dagli strabilianti ma economicissimi effetti speciali, da far sbiancare i Ben Hur e le Cleopatre d’Oltreoceano. Non è un caso che questi anni vengano definiti come “Hollywood sul Tevere”. E allora si sarà pensato: perché non provarci anche con la fantascienza?

Dietro le quinte della fantascienza italiana
RSI Archivi 17.06.1965, 10:01
Ennio Flaiano aveva tentato a teatro (purtroppo senza successo) con la pièce Un marziano a Roma, di comunicarci che non dobbiamo avere paura degli alieni, perché purtroppo i veri mostri siamo noi esseri umani. Troppo scomodo per essere accettato. Ci riproverà con maggiore successo al cinema Nicolas Roeg con L’uomo che cadde sulla terra (1976) con l’alieno dal fascino androgino David Bowie.
Sul fronte cinematografico italiano c’erano stati degli sparuti tentativi come il pioneristico Matrimonio interplanetario (1910) di Enrico Novelli, mentre altri film sul tema, appartenevano spesso e volentieri al registro comico o alla commedia, come il farsesco Mille chilometri al minuto (1939) di Mario Mattoli, l’autoriale La macchina ammazza cattivi (1952) di Roberto Rossellini e Baracca e burattini (1954) di Sergio Corbucci, in cui si prende di mira un abitante della Luna caduto sulla Terra.
Il termine fantascienza in Italia verrà coniato negli anni Cinquanta da Giorgio Monicelli, il primo curatore della rivista Urania. Il vero inizio ufficiale avviene però nell’anno di grazia 1958. Certo, appare ancora un film comico Totò nella luna di Steno che prende in giro il successo statunitense de L’invasione degli ultracorpi (1956) di Don Siegel. Ma nello stesso anno, senza ombra di dubbio si può affermare che La morte viene dallo spazio di Paolo Heusch sia il primo film italiano di fantascienza a tutti gli effetti. Più declinato all’orrore e un po’ sulla scia di The Blob (1958) di Irvin S. Yeaworth Jr, arriva nel 1959 sugli schermi italiani il cult movie Caltiki, il mostro immortale di Riccardo Freda, che anticipa l’Alien (1979) di Ridley Scott ed è incentrato su una creatura monocellulare che giace in letargo dalla notte dei tempi.
Proprio nel 1960 da una parte la produzione nazionale vira verso il gotico e l’horror, preannunciato sempre da Freda con I vampiri (1957) e ufficializzato con uno dei capolavori di Mario Bava, La maschera del demonio, che consacra il talento di screaming queen di Barbara Steele. e dall’altra verso la fantascienza allo stato più puro, ovvero la space-opera, con l’esordio di un altro specialista agli effetti speciali (il primo era Bava, che dirigerà un capolavoro fantascientifico nel 1965, Terrore nello spazio): Antonio Margheriti, che con Space Men, grazie alla complicità produttiva di Turi Vasile e Goffredo Lombardo per la Titanus, incassò 10 volte il suo budget (peraltro inferiore ai 50 milioni di lire).
Un po’ western, un po’ Flash Gordon: il cinema di Antonio Margheriti
Siccome nel 1960 nessuno sapeva con certezza di che colore fosse lo spazio, Margheriti decise di girare in bianco e nero le scene spaziali in cui gli astronauti si muovevano nel vuoto come pesci in acquario, per poi virarle in tonalità verdastre-azzurre. «A quei tempi nessuno ancora era andato nello spazio, solo Gagarin, e io avevo immaginato che soltanto i raggi del sole potevano dare il colore», spiegava il regista. La scelta di girare un film in bianco e nero era però dettata anche da ragioni economiche, dato che la pellicola a colori, oltre a rendere difficili gli effetti speciali, costava molto di più.
Siamo dalle parti ovviamente più della fantascienza alla Flash Gordon, di cui Margheriti era un avido lettore, piuttosto che di Asimov e Clarke: a trionfare non è la scienza, ma la fantasia. Sorta di western spaziale, Space Men ha molto a che fare con la fiaba: come Pollicino lasciava dietro di sé le briciole di pane, così il giornalista eroe lancia nello spazio viti e bulloni per confondere i sensori dell’astronave in avaria.
Space Men fu venduto in tutto il mondo e il successo commerciale convinse Lombardo ad affidare a Margheriti un altro film di fantascienza, Il pianeta degli uomini spenti, e subito dopo, in coproduzione con la Mgm (!), L’arciere delle mille e una notte, una commedia-fantasy per la quale realizzò dei complessi effetti speciali ottici.
Anni dopo la stessa Mgm, in seguito alla realizzazione di quattro film di fantascienza per la televisione americana, contattò Margheriti per offrirgli di collaborare alla realizzazione degli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Dopo una serie di incontri, Kubrick si convinse della bravura di Margheriti, ma il regista romano preferì rifiutare la proposta, che lo avrebbe impegnato per molto tempo, per dedicarsi ai suoi film.
In quegli anni, vigeva l’esterofilia e quindi i nomi degli attori e dei registi dovevano trasformarsi in pseudonimi anglosassoni. Per Margheriti si scelse il nome di Anthony Daisies, che era la traduzione del cognome del regista. Ma non venne ben accolto negli Stati Uniti, perché “Daisies” in inglese alludeva agli omosessuali. Margheriti optò allora per Dawson. Ma anche lì sorsero difficoltà, a causa dell’esistenza di un omonimo attore inglese, specialista in film di genere. Per salvarsi dall’equivoco, optò per una M. tra il nome e cognome: M. come Margheriti, ma anche come Murder! E così nacque il definitivo Anthony M. Dawson.
Se in Space Men, con sceneggiatura di Ennio De Concini, a minacciare la Terra era un’astronave impazzita, in Il pianeta degli uomini spenti è un pianeta che si avvicina pericolosamente al globo terrestre. Anche in questo caso la prima ispirazione è Flash Gordon di Alex Raymond: lo stesso personaggio del professor Benson (interpretato magnificamente da una vecchia gloria come Claude Rains) è molto simile a Zarro, lo scienziato amico di Gordon.

I Criminali della galassia di Antonio Margheriti, 1966
Tuttavia, il film di Margheriti appare molto più cupo del fumetto: se Mongo era abitato da un despota con mostri di ogni tipo, il pianeta Straniero di Margheriti non ospita nessuna forma di vita, ma nasconde miriadi di dischi volanti, programmati da una razza estinta per conquistare la Terra. Gli elementi più curiosi e pop del film sono ovviamente la rappresentazione di questi uomini spenti: grovigli di tubi luminescenti, una trovata di Margheriti per spendere poco e suggerire molto. Erano in effetti semplici tubi di plastica, illuminati di rosso e di verde e ripresi in controluce.
Se poi si aggiungono gli interni scenografici e avveniristici delle astronavi e altri effetti speciali ingenui ma convincenti – come un terremoto realizzato semplicemente facendo girare su se stessa la macchina da presa – si può dire con lo sguardo disincantato dell’oggi, che Il pianeta degli uomini spenti è una sorta d’installazione retrofuturista: un futuro talmente ingenuo e fantasioso da rendere impossibile qualsiasi sua realizzazione nella realtà.
Il mondo come volontà e rappresentazione, di un modellino in scala 1:6 (o al massimo 1:8). Margheriti inventa uno Spazio cinematografico e lo inventa scenograficamente, negli effetti, ma soprattutto inventa una dimensione astratta, mentale, del Cosmo e che è l’elemento che più colpisce e che ancora oggi funziona. Anche per questo motivo, Il pianeta degli uomini spenti ebbe successo e mantenne intatti i suoi pregi nel corso degli anni, tanto che nel 1978 potrà essere nuovamente distribuito con il titolo Guerre planetarie, sorta di risposta italiana al successo spaziale di Guerre stellari.
Il Quartetto Gamma 1: Star Trek prima di Star Trek
I quattro film commissionati dalla Metro Goldwin Mayer europea, ovvero il celebre Quartetto Gamma 1, comprendente I criminali della galassia (uscita nelle sale italiane luglio, 1965), I Diafanoidi vengono da Marte (uscita nelle sale italiane giugno, ’65), Il pianeta errante (luglio ’66), La morte viene dal pianeta Aytin (uscita nelle sale italiane gennaio ’67) hanno un particolare quanto leggendario modus operandi sul set, comune a tutti i quattro film che contavano interpreti in gran parte identici: l’utilizzo di ciak di colori differenti per poter riconoscere poi al montaggio le rispettive sequenze di ciascun film. I quattro film, infatti, vennero girati in sequenza, nel corso di 12 settimane (3 settimane a film, effetti speciali e post-produzione compresi), utilizzando la medesima troupe e riciclando le scenografie e i costumi, solo leggermente rimaneggiati di volta in volta.
I diafanoidi che vengono da Marte, che si ispira a L’invasione degli ultracorpi e che contiene una venatura gotica nella seconda parte (il tema della possessione da parte degli spiriti alieni riporta alla fascinazione dell’orrore senza corpo, fantasmatico e pervasivo e che ritornerà di frequente nella filmografia del regista), era destinato a diventare famoso fin dal titolo: avrebbe infatti ispirato il poeta Allen Ginsberg mentre si recava da Firenze a Milano, e fermandosi a San Gimignano avrebbe notato il manifesto del film di Margheriti. Arrivato a Milano avrebbe aggiunto alla sua poesia Pentagon Exorcism il verso: «Physical slavery to diafanoid chinese cosmic-eye Militar Tyranny…».
I primi due film vedono tra gli attori protagonisti Tony Russell e Jane Fate alias Lisa Gastoni, che verranno sostituiti negli ultimi due da Giacomo Rossi Stuart e Ombretta Colli. Da notare che sempre nei primi due titoli figura un giovanissimo Franco Nero.
La morte viene dal pianeta Aytin è il film più terrestre, ambientato nelle nevi di un finto Tibet. La sceneggiatura ha un’idea particolarmente originale: unire le credenze negli extraterrestri alla leggenda dell’abominevole uomo delle nevi. Il tentativo di mutare le condizioni climatiche del nostro pianeta per adattarlo alla vita degli invasori, sarà un tema usato più volte in seguito nel cinema di fantascienza e, una trama tragicamente anticipatrice del futuro del pianeta: l’innalzamento della temperatura globale e il conseguente scioglimento dei ghiacci del polo, con le catastrofi naturali ad esso correlate. Il plot di Margheriti non appare più così fantascientifico.
Grazie al successo del Quartetto Gamma 1, una pletora di film fantascientifici invadono gli schermi italiani: dai già citati Terrore nello spazio profondo e La decima vittima a 2+5 Missione Hydra (1965) di Pietro Francisci a …4…3…2…1…Morte! (1967) di Primo Zeglio, una coproduzione che porta sullo schermo il famoso eroe stellare di libri e fumetti tedeschi, Perry Rhodan. Da non dimenticare il cult movie anticipatore del fortunato filone sugli zombie di Romero, L’ultimo uomo della terra (1963) di Ubaldo Ragona (o come indicato nella versione statunitense, di Sidney Salkow), tratto dal romanzo postapocalittico di Richard Matheson Io sono leggenda (dimentichiamo la terribile trasposizione cinematografica con il titolo omonimo del 2007) in cui troviamo Vincent Price che vaga tra gli edifici dell’Eur di Roma.
La fantascienza è morta. Viva la fantascienza!
Ma la fantascienza pura (anche se contaminata come la intendeva Margheriti), la space opera, sparirà in pochi anni, come una meteora, dal cielo del cinema italiano. Diventerà un pretesto per raccontare altro, come nell’apodittico politico e ironico Omicron (1963) di Ugo Gregoretti, nel grottesco Il disco volante (1964) di Tinto Brass.
Con l’avvicinarsi del’68 assumerà le connotazioni della distopia apocalittica e della contestazione. Solo qualche esempio: Ecce Homo: i sopravvissuti di Bruno Gaburro, I cannibali di Liliana Cavani, Il seme dell’uomo di Marco Ferreri (tutti del 1969), H2S (1971) di Roberto Faenza.
Bisognerà aspettare i successi di Incontri ravvicinati del terzo tipo e di Guerre stellari per una nuova ondata di film fantascientifici, con cineasti quali Mario Gariazzo (Incontri molto ravvicinati del quarto tipo e Occhi dalle stelle, 1978), Al Bradley (al secolo Alfonso Brescia) e Ben Norman (Bitto Albertini), autori di pellicole in cui i titoli lasciano già presagire il peggio (rispettivamente: La bestia nello spazio del 1980 e Giochi erotici nella terza galassia del 1981), Lewis Coates (Luigi Cozzi, autore di Starcrash – Scontri stellari oltre la terza dimensione nel 1978 e Contamination nel 1980), Aldo Lado (L’umanoide, 1979), Ciro Ippolito (Alien 2 sulla terra, 1980).
Sul lato più comico non si può non ricordare il dittico con Bud Spencer: Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre (1979) e Chissà perché… capitano tutte a me (1980) di Michele Lupo, oltre a Ciao marziano (1980) di Pier Francesco Pingitore con Pippo Franco. Lo stesso Margheriti tornerà con il televisivo L’ isola del tesoro (1987) in versione fantascientifica e un Alien degli abissi (1989).
L’eredità fantascientifica della cometa-Margheriti
Antonio Margheriti oggi merita di essere ricordato come un gentiluomo ottocentesco, legato alla dimensione dei modellini, a una realtà analogica e umana. È stato un marziano nel mondo cinematografaro romano, un regista che ha girato i film che avrebbe voluto vedere da bambino.
E come tutti i bambini, conservava, dopo aver terminato ad esempio le riprese della quadrilogia Gamma 1, caschi spaziali e modelli di astronavi in solaio. Era orgoglioso di quelle costruzioni, scrupolosamente modellate sui progetti di Wernher von Braun degli anni ’50 e spinte da una propulsione a fiamma di acetilene.
Come il titolo di un suo film, L’inafferrabile invincibile Mr. Invisibile (1970), Margheriti era davvero invisibile e inafferrabile sui suoi set. A un occhio più attento lo potevi scoprire, vestito da operaio e disteso per terra, a creare qualche nuovo effetto.
Purtroppo è un mondo, quello della fantascienza anni Sessanta, che non può esistere più, costituito da trucchi alla Méliès e da un linguaggio pseudoscientifico che in realtà di scientifico non aveva nulla, ma di ironico molto: i protagonisti dei film di Margheriti dicevano cose come «Tu hai idrogeno al posto del cervello!» o «Tutto questo uranio è irritante».
Sui titoli di coda, prima della parola “Fine”, ricordiamo ancora immagini di astronavi in formazione, uomini con lo scafandro che galleggiano nel vuoto, la stazione spaziale Gamma 1 che orbita nello spazio «a molte migliaia di chilometri dalla terra». Un doppio finale è d’obbligo: oggi forse quei modellini giacciono da qualche parte dentro una cesta. Chissà se un bambino-regista li potrà far tornare a vivere, alla maniera di Toy Story. Ai posteri la fantascientifica sentenza.
Manlio Gomarasca, Diabolik e il cinema di genere
Diderot 05.05.2022, 17:40
Contenuto audio