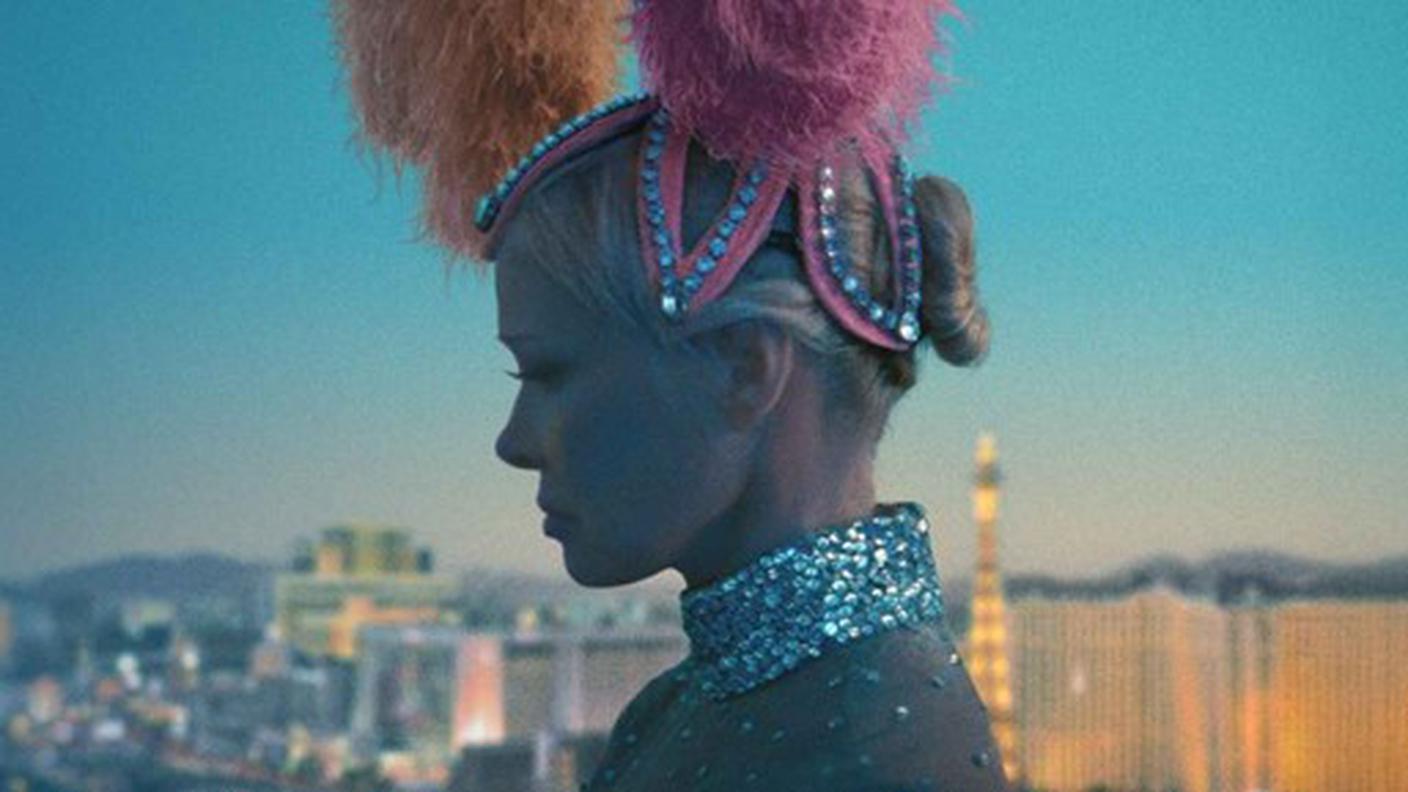Era il 2008 quando l'allora sessantatreenne Masaki Iwana (febbraio 1945 - 11 novembre 2020) concludeva il suo primo lungometraggio: Vermilion Souls. L'artista – da anni regolarmente di passaggio in Ticino grazie alle iniziative di Progetto Brockenhaus – all'epoca non era estraneo né alla pratica attorale né agli esordi tardivi: aveva infatti debuttato nel mondo della danza passati i trenta dopo una giovanile carriera teatrale; si era stancato, afferma, di ripetere le battute già decise dei copioni e si domandava, nonostante l'età, se fosse possibile esprimersi solo attraverso il proprio corpo. Aveva quindi deciso di consacrarsi al butō – particolare modo di intendere la danza nato in Giappone a fine anni Cinquanta – formandosi come autodidatta.
Al momento di dedicarsi, anche, al cinema Iwana aveva dunque alle spalle un forte percorso di ricerca come performer – moltissimi gli assoli realizzati in innumerevoli paesi – e insegnante. Generazioni di danzatori e teatranti si sono infatti formati grazie ai suoi laboratori tenuti presso la Maison du Butō Blanc, casa-studio da lui fondata in Normandia ad alcuni anni dal suo arrivo in Francia nel 1983.
Ed è proprio nella "sua" Normandia, in un luogo che avrebbe letteralmente fatto sognare Tarkosvkij, che il cinema di Iwana è largamente girato. La surreale vicenda di Vermilion Souls, ad esempio, ha luogo in un Giappone post-bellico interamente ricreato negli spazi di lavoro e di vita del danzatore: qui, in una cadente abitazione, lo spettatore assiste all'incontro fra un bambino e un gruppo di adulti affetti da un male incurabile che non gli permette l'esposizione alla luce del sole. La curiosa compagnia, composta da un soldato-guardiano zoppo, una ex-prostituta, un calligrafo storpio e una giovane enigmatica, attende con ansia la morte che, per concessione dello Stato, avverrà con una somministrazione di gas.
Fotografato in uno splendido bianco e nero e alternato da momenti di danza e istanti onirici, Vermilion Souls può essere letto come una sorta di manifesto filosofico del butō: i padri fondatori – Tatsumi Hijikata e Kazuo Ōno – hanno infatti insistito sulla volontà, attraverso la propria arte, di far camminare i morti, di mantenere saldo i legame tra il mondo dei vivi e quello dei defunti; similmente Iwana afferma che Vermilion Souls è un film sulla «vita che osa vivere la morte» e raggiungere una verità radicale.
Di matrice più autobiografica è invece il secondo lungometraggio di Iwana, A Summer Family (2010). L'ambientazione è ancora ricavata negli spazi della Maison du Butō Blanc, ma senza alcun intento finzionale. La pellicola racconta l'intreccio di relazioni affettive fra il danzatore giapponese Kamimura – alter ego di Iwana da lui stesso interpretato – la moglie Akiko e l'amante Yuzuko durante un'estate nella sua abitazione. La danza, qui, è in qualche modo l'oggetto stesso del film (alcune riprese sono state effettuate durante i laboratori organizzati da Iwana) unitamente allo spirito giapponese e a un erotismo dirompente che contorna la quotidianità di Kamimura.
Nel 2012, con Princess Betrayal, Iwana torna invece a una narrazione che sembra distanziarsi dalla cifra personale per approcciare l'universale tematica della solitudine (concetto caro al regista) e il duro passato del proprio paese. Più spoglio di dialoghi rispetto ai precedenti e immortalato da una essenziale fotografia a colori, il film vede protagonista un'anziana attrice-scrittrice che, insignita di una importante onorificenza, a partire da un'intervista a lei dedicata attraversa una rievocazione del proprio vissuto all'epoca della guerra. Pervasa da un eros meno crudo, ma non meno conturbante di Summer Family e Vermilion Souls, quest'opera, in cui la danza è decisamente meno presente, dà spazio a un racconto di immagini nette, colori, silenzi e antichi canti. Inoltre – cosa che non manca in nessuno di questi film – è presente una sorta di dimensione orrorifica, demoniaca, che sembra attingere a un universo di leggende popolari.
Con Charlotte-Susabi (2017) infine Masaki Iwana torna a universo di ispirazione autobiografica realizzando un nuovo surreale tassello della vicenda dell'alter ego Kamimura; Susabi (letteralmente "divertirsi") era infatti il titolo di una storica performance che vedeva agire Iwana su una lastra di vetro sostenuta da quattro bicchieri colmi d'acqua – l'assolo culminava con la rottura del tutto e con una danza fra i cocci. Mentre si reca in un negozio parigino ad acquistare del materiale per le sue esibizioni, Kamimura si imbatte in una donna che richiama alla sua mente il ricordo della ex-moglie. In quello stesso giorno incontra Charlotte, una storpia che si insinua nei suoi sogni come un intrigante e sensuale fantasma. Questi eventi scatenano nell'artista, disilluso e amareggiato da sé e dal mondo, una sorta di viaggio fra realtà, memoria e immaginazione.
Degna dei migliori appuntamenti del «Fuori orario» ghezziano, l'insolita e raffinata filmografia di Masaki Iwana è parte integrante del percorso di un artista fedele alla radice profonda del butō. Ora che i padri fondatori sono morti e le prime generazioni di danzatori che diedero vita a tale pratica vanno, via via, scomparendo, essa, oltre ad essere un'intensa opera d'arte, è un'importante testimonianza di un modo di concepire creatività, vita e morte.