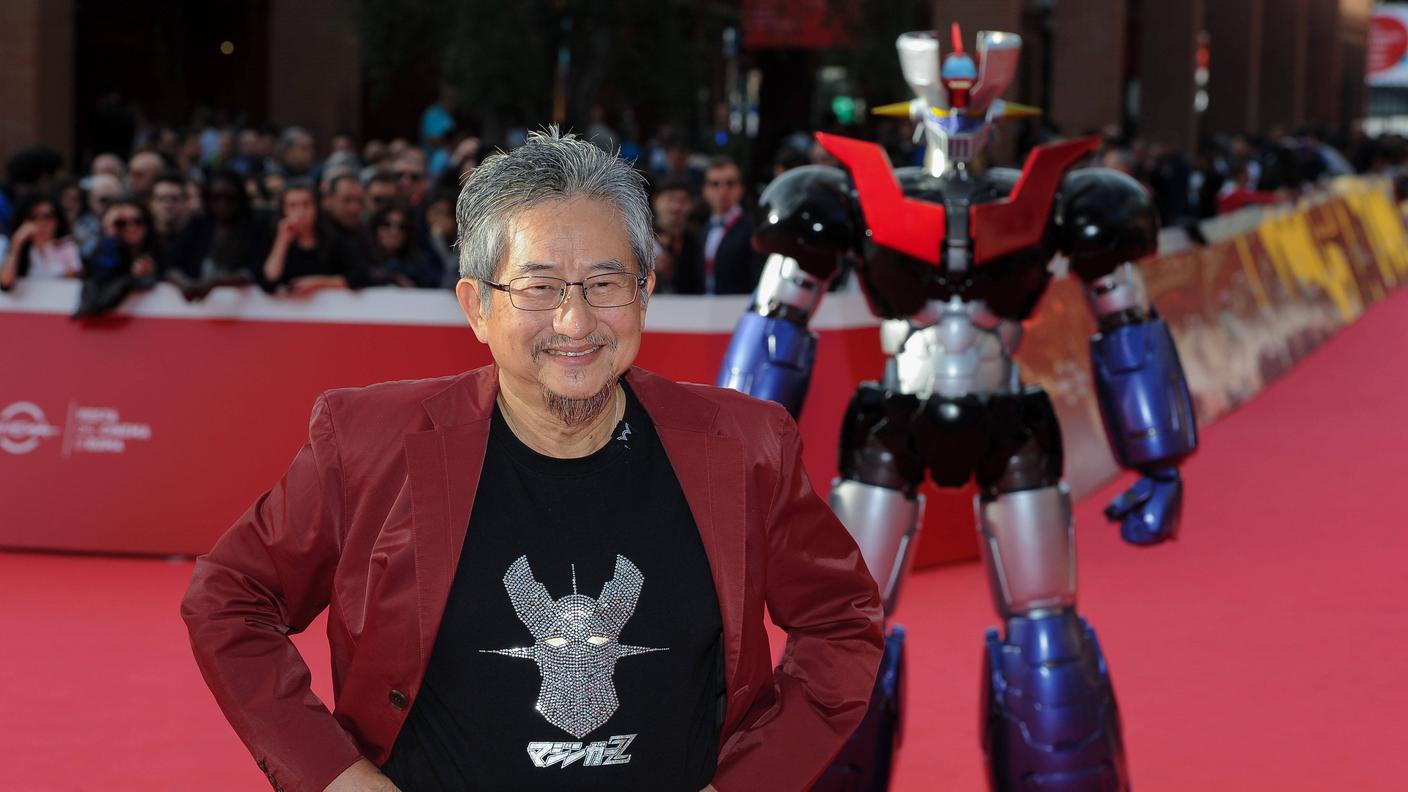«Nel 1944, alla fine della guerra, tutto era distrutto in Italia. Il cinema come ogni altra cosa.» È il motivo per cui si poteva godere di una libertà immensa, spiega Roberto Rossellini ne Il mio dopoguerra (edizioni dell’asino), raccolta di memorie apparse per la prima volta sui Cahiers du cinéma.
Un periodo in cui dalle macerie di una civiltà si creavano i presupposti per un nuovo inizio, in ogni ambito umano. Come durante il conflitto, anche nell’immediato dopoguerra il cinema soffrì la mancanza di fondi, di pellicola, di risorse, ma l’assenza di una struttura, con Cinecittà ridotta a rifugio per gli sfollati, rappresentò anche l’assenza di regole e leggi che potessero imbrigliarne le idee. E se qualcosa non mancava, là dove tutto era assente tranne il dolore, erano proprio le idee. In questa zona grigia, tutto, o quasi, era concesso, e sperimentare era uno dei pochi modi per narrare l’inenarrabile coi quattro soldi raccolti a stento per pagarsi qualche metro di pellicola. «È in condizioni simili che cominciai a girare Roma città aperta.»
È una leggenda, quella secondo cui Rossellini non si servisse di una sceneggiatura, ma è certo che non ne comprendesse bene la necessità. Serviva a convincere i produttori, a mettere nero su bianco la continuità di un film, ma non poteva porre vincoli alla creatività e all’improvvisazione. Era uno strumento in continua evoluzione, dalla nascita del soggetto all’ultimo giorno di montaggio, e che acquisiva senso e ragione di esistere grazie alle mani attraverso cui passava, agli attori che ne interpretavano le voci.
Con Roma città aperta, le cose non andarono diversamente. L’idea di scrivere qualcosa di concreto nacque parlando con gli sceneggiatori Sergio Amidei e Alberto Consiglio, ai quali si sarebbero aggiunti successivamente Ferruccio Disnan, Celeste Negarville e un ritroso Federico Fellini. Un soggetto pensato per un documentario sul partigiano don Giuseppe Morosini si sarebbe così trasformato in un film di finzione, che era allo stesso tempo il manifesto di una nuova corrente cinematografica fondata sulla realtà: il prototipo dell’opera neorealista.
«Mi sono sempre sforzato di dire che per me il neorealismo era solo una posizione morale. La posizione morale era di obbiettivamente mettersi a guardare le cose e di mettere insieme gli elementi che componevano le cose, senza cercare di portarci nessunissimo giudizio.» Ciò che componeva le cose, alla fine dell’occupazione nazista di Roma, era la miseria umana di un mondo devastato, e una vita che aveva assistito con occhi spalancati alla desolazione morale di un’epoca, facendo tesoro dell’orrore. Rossellini ha sempre sostenuto che nei suoi film c’era molto di autobiografico. Roma città aperta non fa eccezione, perché «Roma città aperta è il film della paura: della paura di tutti, ma soprattutto della mia.»
In questa Roma distrutta bastò filmare quel che c’era nelle uniche condizioni possibili. Come raccontò a James Blue e ai suoi studenti della Rice University di Houston, girare Roma città aperta fu «una vera e propria avventura, senza una lira, senza negativo, senza elettricità. Perciò ho girato in un posto che era vicino a dove si pubblicava un giornale per le truppe americane, The Stars and Stripes, e rubavamo l’elettricità da loro.»
Ritratto di Anna Magnani
RSI Cultura 03.05.2023, 10:31
Le condizioni più sfavorevoli si trasformarono così in un’opportunità, quella di liberarsi dalle strutture del cinema vigente per reinventare un linguaggio che potesse provare a descrivere la realtà delle cose. Se, lontano dai teatri di posa, le scenografie naturali assicurarono le ambientazioni ideali, agli attori, professionisti e non, fu affidato l’arduo compito di restituire la paura e il coraggio dei protagonisti, che in un contesto reale come quello dell’occupazione furono ispirati da personaggi esistiti: realmente vittime della ferocia nazifascista.
La figura di don Pietro, interpretata da Aldo Fabrizi, rimanda a quelle dei presbiteri antifascisti Pietro Pappagallo, vittima dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, e Giuseppe Morosini, fucilato dai tedeschi il 3 aprile del 1944. La figura di Pina, interpretata da Anna Magnani, si rifaceva invece a Teresa Gullace, uccisa dai soldati tedeschi mentre cercava di parlare col marito, in una scena che richiama limpidamente la lunga corsa di Pina dietro la camionetta che trascina via il marito. È la finzione che si nutre di realtà per dare un senso al reale, senza giudizi e senza risposte, ma con inevitabili punti interrogativi a costellarne i contorni e a perforarne il cuore.
Visconti e il neorealismo
RSI Cultura 29.09.2016, 12:11
Come scrisse lo stesso Rossellini, il desiderio era di cogliere le cose nella loro essenza: «Non mi interessava nel modo più assoluto costruire un racconto romanzato, secondo le regole della drammaturgia cinematografica, perché i fatti erano di per sé molto più drammatici di qualsivoglia convenzione spettacolare.»
La realtà serve però sviscerarla, talvolta trascenderla, affinché il cinema possa raggiungere il proprio obiettivo. Un obiettivo che nel cinema del reale non è la spettacolarità o il racconto, ma il «mondo». Come scrive Gianni Rondolino nella sua monografia su Roberto Rossellini: «Pareva quasi che Rossellini volesse scrutare la realtà fino ai limiti del possibile, o del tollerabile, per farne emergere un significato trascendente, che in certo senso la giustificasse, le desse un valore.» Un reale tanto difficile da restituire da rendere necessaria una nuova forma di racconto che, forse anche a causa della propria unicità, non fu molto apprezzata all’uscita. Rivalutato col tempo e assurto a manifesto del cinema neorealista, Roma città aperta resta, dopo ottant’anni, uno strumento fondamentale per riappropriarci della realtà.

Roberto Rossellini e Ingrid Bergman con i figli, Roma, 1953