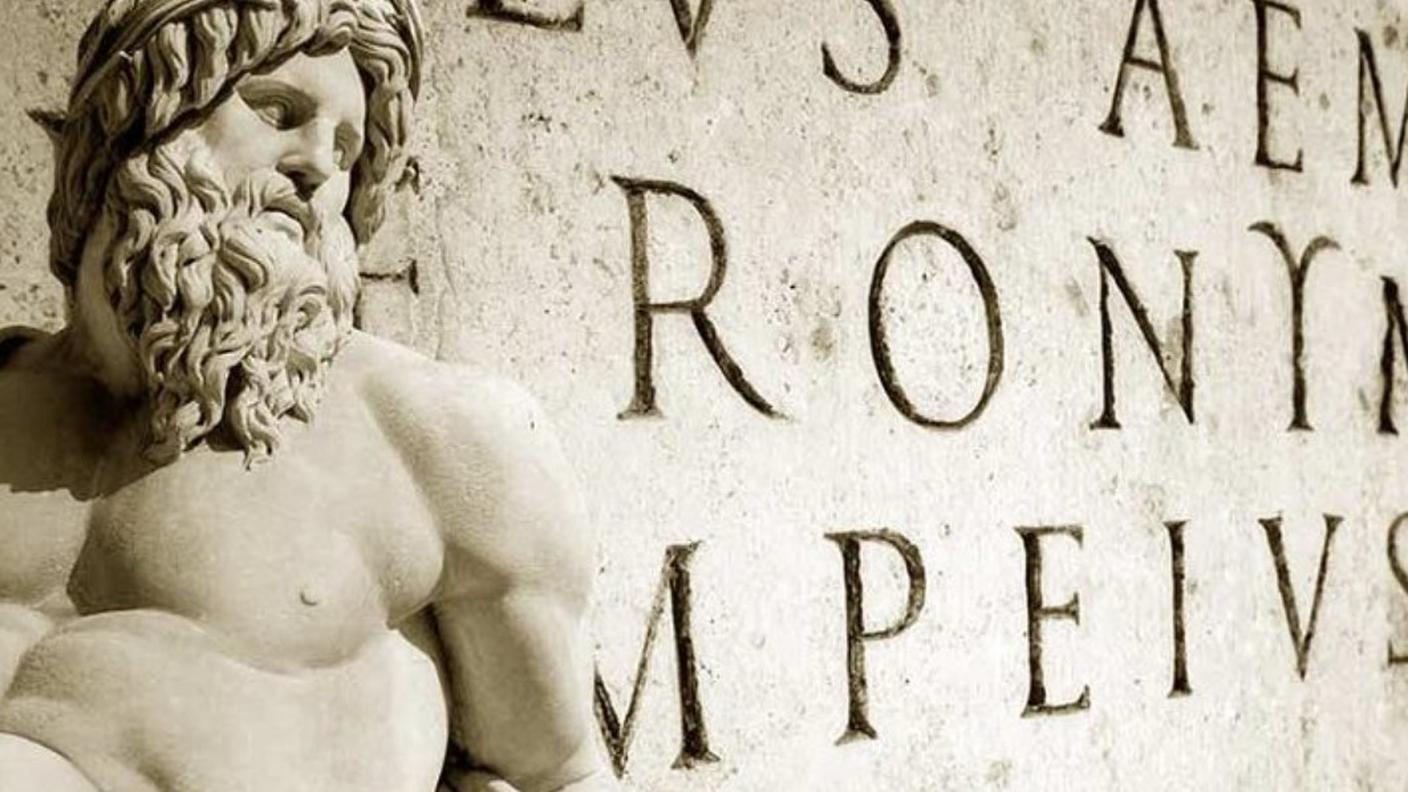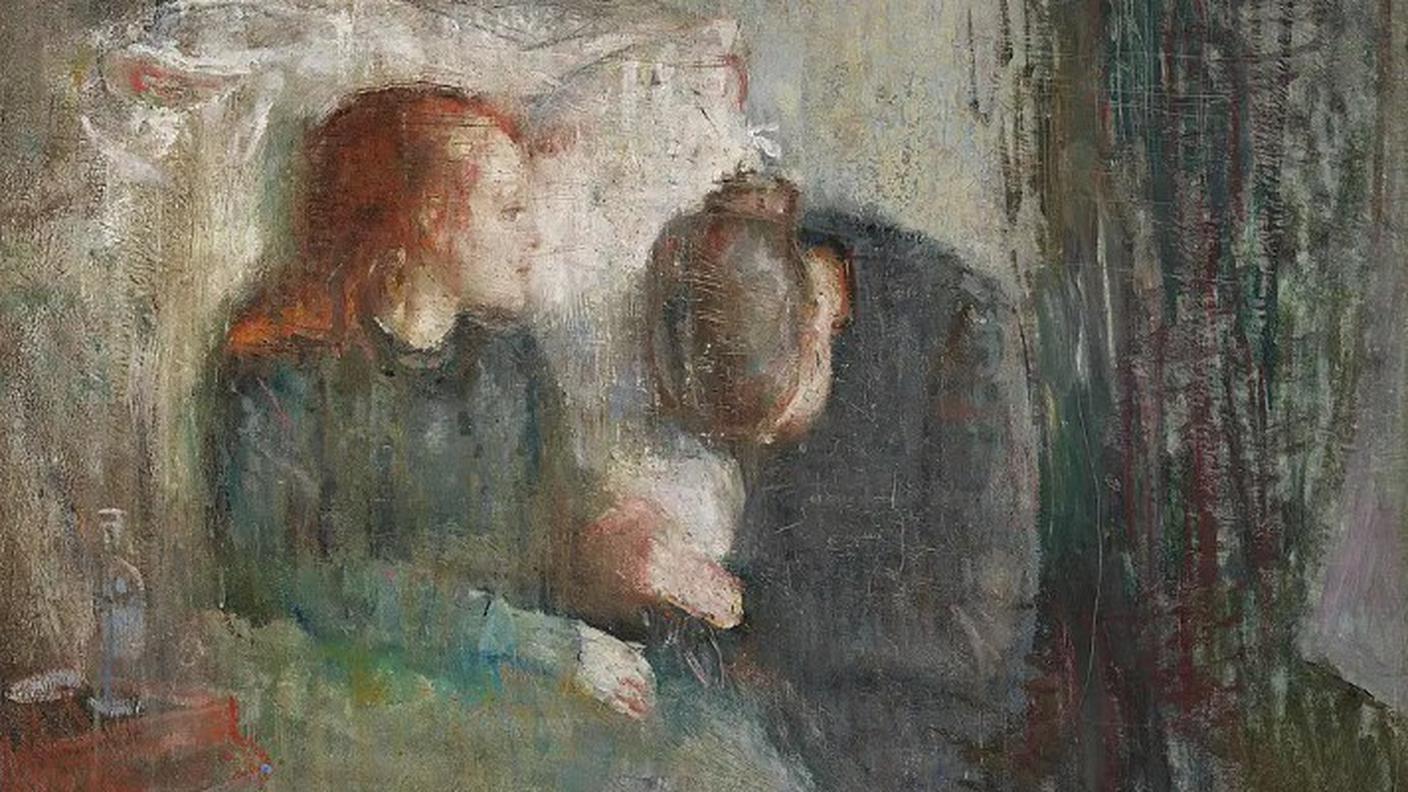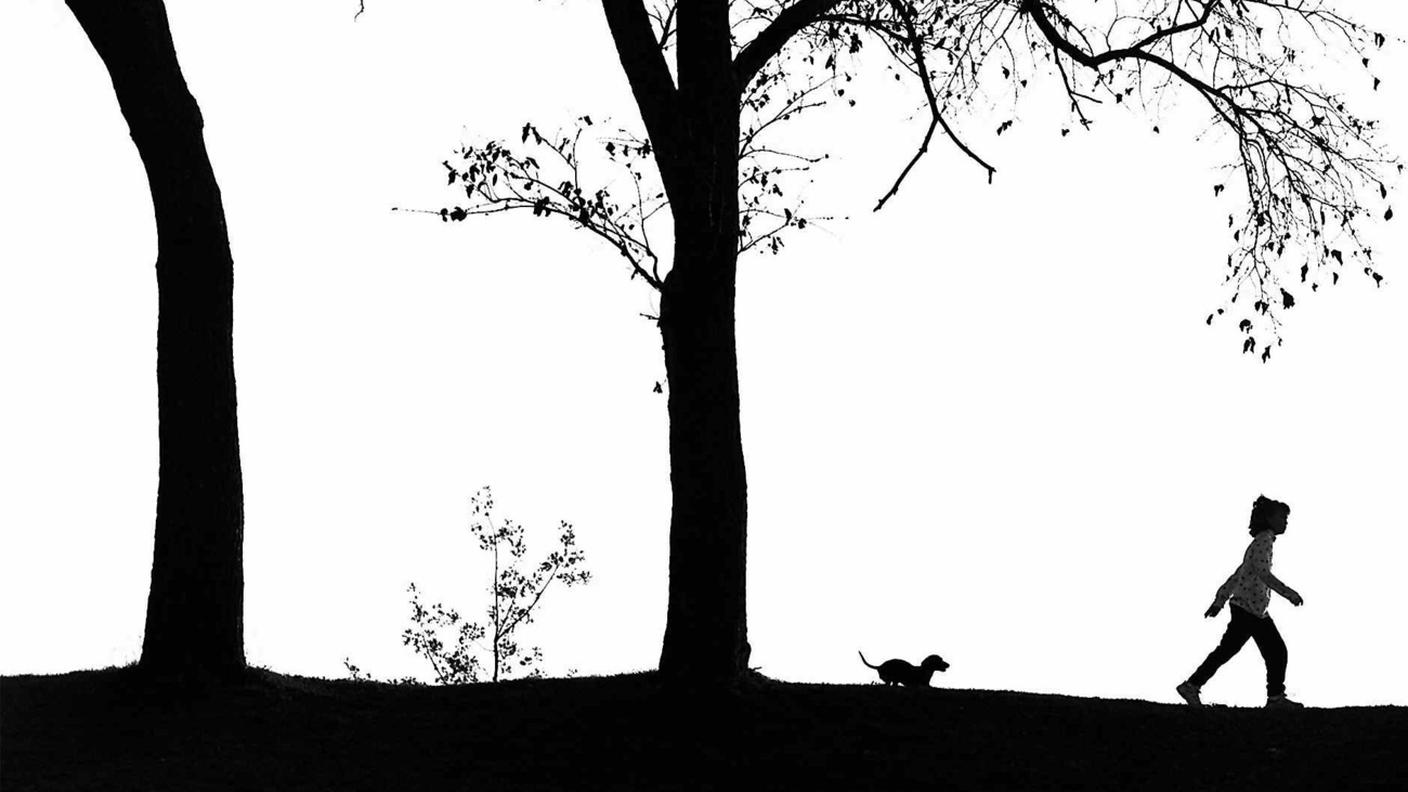Millesettecento anni fa nella città bitinica di Nicea, l’odierna İznik ubicata a poco più di cento chilometri da Istanbul, veniva celebrato il primo concilio ecumenico o generale della storia del cristianesimo. Convocata dall’imperatore Costantino nella sua residenza estiva, per risolvere «una contesa locale che si era estesa a tutte le Chiese dell’Impero romano d’Oriente e a numerose Chiese dell’Occidente», la grande assise del 325, iniziata, secondo la datazione di Socrate di Costantinopoli, il 20 maggio (più correttamente, invece, il 19 giugno) e conclusasi il 25 luglio, aprì la serie dei cosiddetti concili imperiali dell’antichità: sette in tutto quelli congiuntamente celebrati e riconosciuti da Oriente e Occidente. La contesa, cui si accennava prima, era scoppiata qualche anno prima tra il vescovo di Alessandria Alessandro e uno dei suoi presbiteri, il brillante e colto Ario, che predicava la creaturalità del Logos in nome di un rigido monoteismo e sosteneva, dunque, che Cristo non può essere “Figlio di Dio” in senso proprio. Diretto contro la dottrina ariana, il Simbolo o Credo è indubbiamente il documento più importante del concilio di Nicea, di cui non possediamo gli atti ma unicamente i canoni e, per l’appunto, la professione di fede. Professione di fede, che è solitamente conosciuta come Simbolo niceno-costantinopolitano per la più ampia confessione della divinità, personalità e azione salvifica dello Spirito Santo, formulata dal primo concilio di Costantinopoli (381) in risposta agli errori degli pneumatomachi.
Non meraviglia pertanto che papa Leone XIV, incontrando lunedì 19 maggio 2025 in Sala Clementina le delegazioni ecumeniche e interreligiose convenute per l’inizio del suo ministero petrino, abbia dedicato un significativo passaggio del relativo discorso al primo concilio ecumenico di Nicea, «tappa fondamentale per l’elaborazione del Credo condiviso da tutte le Chiese e Comunità ecclesiali». Per capirne di più, abbiamo raggiunto telefonicamente il vescovo Massimiliano Palinuro, che, già docente di Nuovo Testamento e Filologia greca neotestamentaria presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, è dal 2021 vicario apostolico di Istanbul.
1700 anni dalla celebrazione del concilio di Nicea: quale il significato e l’importanza di una tale data anniversaria?
L’anniversario del concilio di Nicea ci costringe a rispondere ancora una volta alla grande domanda: Chi è veramente Gesù? È la domanda che risuona nei Vangeli e nel corso della storia risuona di generazione in generazione. Il primo concilio ecumenico di Nicea ha codificato per la prima volta e in maniera chiara la professione di fede nella divinità della persona di Gesù. Non nel senso, ovviamente, di un’invenzione della fede cristiana da parte dei padri conciliari di Nicea, che hanno invece formulato con chiarezza, attraverso categorie comprensibili a quel tempo, la dottrina della natura divina di Gesù, consustanziale (‘oμοούσιος / omooúsios) al Padre. Nicea resta assolutamente attuale, perché l’eresia ariana, che negava la natura divina di Gesù e la riduceva alla semplice dimensione umana e creaturale, di fatto non è stata mai veramente sradicata, ritornando di secolo in secolo e riproponendo la grande domanda: Chi è veramente Gesù? Nel nostro tempo vediamo nuove forme di arianesimo e negazione della natura divina di Cristo attraverso i continui tentativi di ridurre la sua persona e il suo messaggio alla sola dimensione sociale e umana. Da qui l’importanza fondamentale di Nicea, giustamente richiamata lunedì da papa Leone.
Alcuni ritengono che la formula nicena della consustanzialità del Figlio dovrebbe essere ripensata secondo categorie del pensiero contemporaneo. È ammissibile una tale richiesta?
La formula di Nicea sulla consustanzialità del Figlio non è un feticcio intoccabile. È, invece, un criterio di riferimento. Evidentemente, quella formula non può essere alterata. Può essere però reinterpretata e ridetta con linguaggi e immagini meglio comprensibili agli uomini e alle donne del nostro tempo. La teologia esiste proprio con lo scopo di riformulare e ripensare la verità rivelata, annunciandola all’uomo di oggi. Quindi, è necessario conservare la fedeltà sostanziale alla dottrina nicena. Ma, al contempo, è possibile, anzi auspicabile, che sia la teologia sia i pensatori del nostro tempo riformulino in maniera più comprensibile all’uomo contemporaneo la verità immutabile, che è stata proclamata a Nicea.
Qual è il valore del Credo niceno per i cattolici?
Per noi cattolici il Credo proclamato a Nicea e a Costantinopoli ha un valore fontale. È la fonte a cui attingere e il criterio per misurare la nostra appartenenza alla fede cristiana. E questo è valido non solo per noi cattolici ma per tutte le confessioni cristiane. Il credo formulato a Nicea e a Costantinopoli è da esse accolto senza eccezioni, al punto che si può dire che chi non accoglie la formula niceno-costantinopolitana neppure può dirsi cristiano.
Perché il Simbolo niceno-costantinopolitano è così importante per il dialogo ecumenico, in particolare con le Chiese dell’ortodossia?
In un mondo così lacerato da divisioni e rivalità il compito di noi cristiani è quello di abbattere muri e costruire ponti di comunione: per troppi secoli le divisioni tra cristiani sono state giustificate da motivazioni politiche o hanno provocato contrasti politici. Ecco, è giunto il tempo in cui la fede cristiana, innanzitutto, non deve mai essere più causa di divisione nella famiglia umana. Ma è anche il tempo in cui la grande famiglia cristiana dei discepoli di Gesù deve essere veramente il segno di unità di tutta la famiglia umana. È necessario, quindi, accelerare il cammino ecumenico, utilizzando la strategia di papa Giovanni XXIII, ossia cercare ciò che unisce e mettere da parte, se c’è, ciò che ci divide: solo camminando insieme e conoscendoci a vicenda potremo scoprire di avere in comune molto più di quanto immaginiamo.
Il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo aveva invitato lo scorso anno papa Francesco a visitare la Turchia in occasione del 1700° anniversario di Nicea. È ormai certo che tale viaggio apostolico sarà fatto da Leone XIV. Cosa può dirci nel merito e quali le aspettative?
Il viaggio di papa Francesco era in procinto di essere realizzato. Addirittura, anche durante la sua malattia era stato confermato, essendo piena intenzione del pontefice di venire in Turchia al termine della sua convalescenza. Ovviamente, con la sua morte tutto è stato messo da parte. Ma è adesso programmata la visita di papa Leone XIV, cui sia il Governo turco sia la Chiesa locale cattolica sia il patriarca ecumenico Bartolomeo hanno rinnovato l’invito a visitare la Turchia e, in particolare, Nicea in occasione di questo millesettecentesimo anniversario. Il Governo turco sta provvedendo alla realizzazione di infrastrutture, che rendano fruibili i resti archeologici del Palazzo di Costantino, in parte sommersi nel lago di Nicea. Questo, ovviamente, anche nella prospettiva di valorizzazione ai fini turistici. Ma scopo principale di tali infrastrutture sono la degna accoglienza della visita del Papa e la celebrazione ecumenica, che si intende realizzare proprio laddove il concilio venne celebrato. Il che, secondo la tradizione, ebbe luogo nel Palazzo senatorio di Nicea, residenza estiva dell’imperatore Costantino.
Quali sono i rapporti tra il vicariato apostolico d’Istanbul e il patriarcato ecumenico di Costantinopoli?
I rapporti tra il vicariato apostolico, e in generale la comunità cattolica, con il patriarca Bartolomeo e con il patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono eccellenti; anzi, posso dire che qui a Istanbul le relazioni ecumeniche sono decisamente molto più forti che in tutto il resto del mondo. Lo stesso si può dire in riferimento alle altre confessioni cristiane. Forse è provvidenziale che il cammino ecumenico sia così forte in questi luoghi: proprio qui, dove la grande divisione ebbe inizio nel 1054, deve anche iniziare la grande riconciliazione tra l’Oriente ortodosso e l’Occidente cattolico. Siamo perciò costantemente impegnati a vivere nella quotidianità una tale fraternità, una tale comunione. Qui a Istanbul questo cammino di riconciliazione è iniziato con la presenza del mio predecessore Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, nei suoi dieci anni in cui guidò il vicariato apostolico. E da parte ortodossa, di lì a poco, la presenza luminosa del patriarca Atenagora ha spalancato le porte anche in quella Chiesa al cammino ecumenico: egli è stato davvero nel mondo ortodosso il grande profeta dell’unità. Dopo di lui questo cammino è stato intensificato dal suo successore Demetrio e, quindi, da Bartolomeo, che da quasi trentacinque anni guida, come primate della Chiesa ortodossa, il percorso del dialogo ecumenico. I patriarchi Atenagora, Demetrio e Bartolomeo hanno coraggiosamente aperto il cammino di fraternità e riconciliazione qui a Istanbul. Tutto ciò produce i suoi buoni frutti in relazioni concretamente fraterne. Questo è davvero opera della Grazia!
Della stessa sostanza del padre
Alphaville 08.04.2025, 11:45
Contenuto audio