Clicco sull’icona con la freccia a cerchio. Aggiorno la pagina. Sarà la quarta o quinta volta che lo faccio, non so cosa mi aspetto che succeda. Se follia è compiere la stessa azione aspettandosi esiti diversi, il mio comportamento rasenta la follia.
Sono sul sito della mia libreria di fiducia. Ho davanti la pagina dell’edizione italiana di Rifiuto di Tony Tulathimutte. Aspetto da settimane la sua uscita, prevista il prossimo 24 settembre. Una parte di me è convinta che aggiornando la pagina qualcuno deciderà di anticipare la data. So che è impossibile. La ricarico un’ultima volta. Sempre 24 settembre.
Trovare una motivazione per la mia impazienza è difficile. L’autore statunitense classe 1983 non è tra i miei scrittori preferiti, e non si può nemmeno dire che la sua fama lo preceda: ha attirato l’attenzione in patria, ma da noi è poco più che uno sconosciuto. All’attivo ha un solo romanzo, Cittadini privati, pubblicato nel 2016 in lingua originale e tradotto in italiano nel 2019. Se devo essere onesto, faccio parte della grande fetta di pubblico che non l’ha letto. A maggior ragione: perché trepido nell’attesa di Rifiuto?
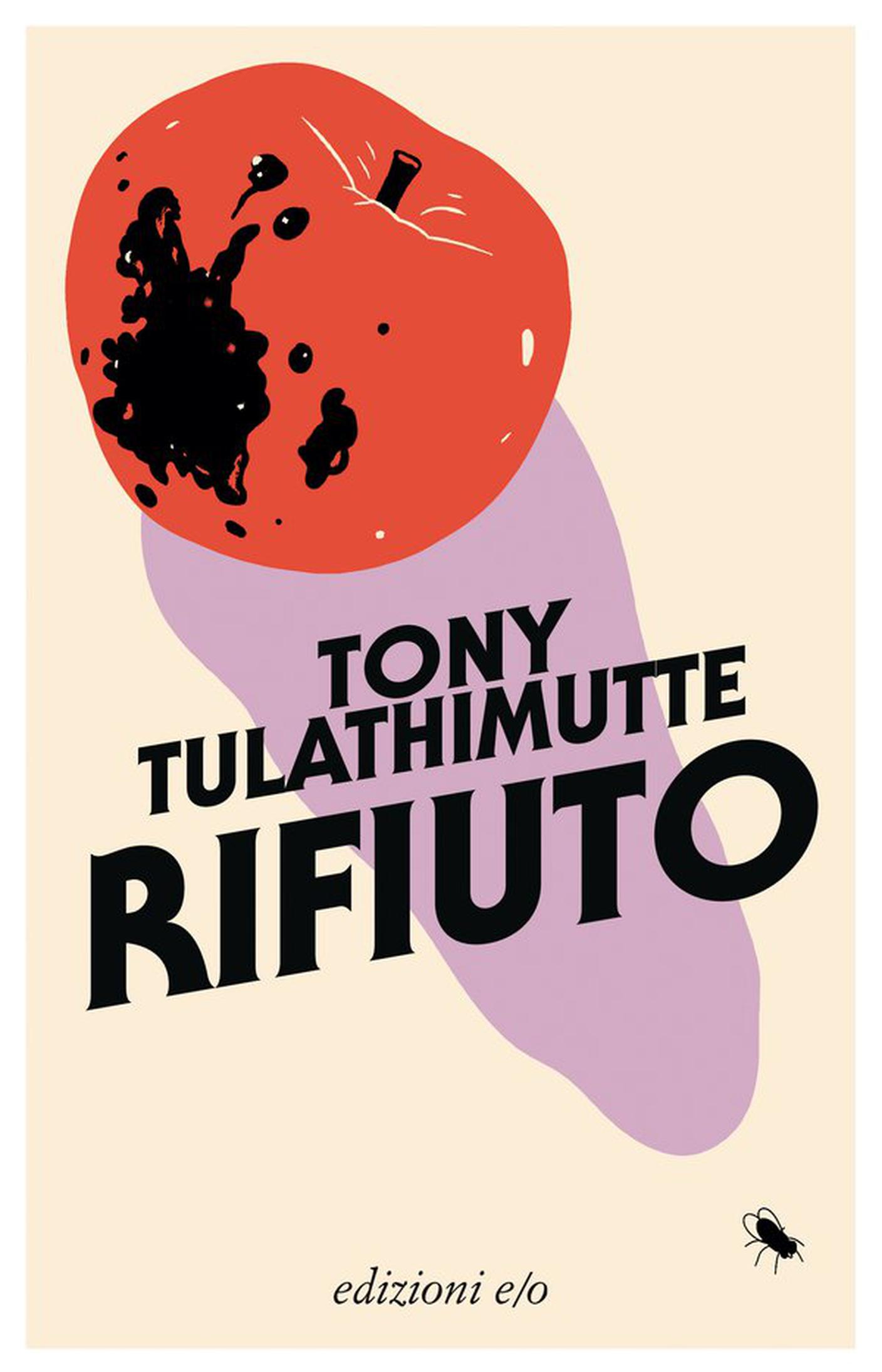
Rifiuto, Tony Tulathimutte, 2025
La prima risposta che mi do è che sono una vittima delle recensioni entusiaste. Ho sentito parlare della raccolta di racconti da Jia Tolentino del The New Yorker. Lo ha inserito nella sua lista di migliori opere del 2024. Lo stesso hanno fatto New York Times, Vogue, Esquire, Time e Wall Street Journal. Insomma, negli Stati Uniti l’opera non è passata inosservata – ma non è questa la ragione del mio interesse.
Ho sfogliato la versione in lingua originale di Rifiuto e sono andato in fissa. Il motivo può sembrare stupido: c’erano delle emoticon. C’erano delle emoticon e dei messaggi, delle discussioni sui forum e dei post sui social network. E non solo: sembravano realistiche. In quei racconti c’è internet, i social, la vita digitale e le sue conseguenze. Sono storie di rifiuti, come da titolo, spesso ricevuti da uomini – e c’è chi le vede come le prime narrazioni che riguardato redpillati e incel, ovvero gruppi di uomini che si incontrano online e si contraddistinguono per le idee misogine e antifemministe. Tematiche quantomeno attuali.

Chi sono gli incel?
SEIDISERA 04.07.2025, 18:00
Contenuto audio
Come detto, internet non è però presente solo nei contenuti, ma nella forma. Ed è questa la cosa che mi interessa di più.
Ho da tempo la sensazione che la letteratura abbia un grosso problema con la contemporaneità, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione della tecnologia. Molti autori sembrano volerla evitare, o almeno la relegano a comparsa. Una sporadica telefonata con uno smartphone, un riferimento vago ai social network, una breve ricerca sul web: la tecnologia che usiamo quotidianamente sembra sempre essere quel dettaglio che viene inserito svogliatamente perché è inevitabile citarlo. Ma niente di più.
In un’intervista rilasciata al The Guardian nel 2021, nell’ambito della presentazione del suo Kentuki, la scrittrice argentina Samanta Schweblin sembra della mia stessa opinione: “Come lettrice, avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato tra letteratura e tecnologia. Ogni autore che leggevo, e anche io stessa, scrivendo, si impegna enormemente a non nominare le tecnologie. Nella vita di tutti i giorni abbiamo accettato la tecnologia in modo molto naturale, ma nella narrativa cerchiamo di non parlarne”.
Corpi virtuali
Alphaville 11.11.2024, 12:35
Contenuto audio
È un cortocircuito, quello di cui parla l’autrice. Tutti noi possediamo uno smartphone, navighiamo su internet per svariate ore al giorno, abbiamo un profilo su uno o più social network; gli scrittori che provano a tradurre questa realtà su pagina sono però pochi. Ma perché? È davvero possibile provare a escludere completamente una parte così importante della nostra quotidianità? Si può davvero parlare del presente escludendo la tecnologia?
Niccolò Ammaniti un paio di anni fa ha affrontato l’argomento nel corso di un’intervista: “È interessante immaginare di voler scrivere una storia nel presente ed escludere per esempio i social. Non lo puoi fare. Però ti rendi corto che perdi pagine con cellulari, risposte, quindi che fai? Dici: forse ci spostiamo vent’anni fa, così non ho questo problema narrativo. (…) Mi spaventa molto in questo momento raccontare una storia contemporanea, perché purtroppo questa presenza è una presenza costante nella nostra vita. E diventa una presenza anche nella narrazione”.
Se nelle parole di Samanta Schweblin si percepiva la denuncia di una mancanza e il conseguente appello a colmarla, lo scrittore italiano sembra più confrontato con un problema seccante. Le pagine in cui vengono riportati gli scambi attraverso la tecnologia sono “perse” per rappresentare quella parte “purtroppo” presente nella nostra vita. La soluzione: ambientare la storia nel passato. Una posizione che si può certo comprendere – rappresentare la tecnologia deve essere una sfida per uno scrittore, sfida che nel suo ultimo romanzo, La vita intima, lo stesso Ammaniti ha in parte accettato – ma che sembra forse un po’ arrendevole.
Alcuni tentativi di tradurre internet in letteratura ci sono stati, va detto. Nel 2021 la statunitense Patricia Lockwood, nel suo Nessuno ne parla, ha cercato di portare le modalità espressive e ricettive dell’online su carta, affidandosi a una protagonista influencer. Nello stesso anno l’olandese Hanna Bervoets, con Questo post è stato rimosso, ci ha portati nel mondo disturbante dei moderatori di contenuti dei social network. E questi sono alcuni esempi che testimoniano la volontà e la necessità di una sorta di “realismo virtuale”, ma i tentativi rimangono sempre limitati nel numero.
Quindi rimane la domanda: perché è così difficile parlare di tecnologia contemporanea in narrativa? E soprattutto, perché è complicato farlo utilizzando gli stessi linguaggi che la contraddistinguono?
Forse uno dei problemi è la velocità con la quale si muove lo sviluppo tecnologico. Affrancare la propria opera a uno specifico social network o a un particolare fenomeno del web lo relega a una dimensione temporale specifica e destinata a essere superata in fretta. La sensazione è di destinare la propria opera a vita breve, come succede con le notizie di attualità e la cronaca.
Meglio quindi scegliere un’epoca che ha già superato il test del tempo, della quale si conoscono con maggiore chiarezza le caratteristiche destinate a sopravvivere. Questo punto si collega anche all’età anagrafica di molti scrittori capaci di raggiungere il grande pubblico. Oggi la scrittura non è uno dei mestieri più attrattivi per gli under 30 e per affermarsi nell’industria editoriale serve tempo ed esperienza. Negli ultimi anni vediamo autori nati tra la metà degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta ritagliarsi sempre più spazio, ma si tratta di una generazione di passaggio nata in un mondo ancora fortemente analogico e cresciuta parallelamente all’imporsi del digitale. I millennial, insomma, di cui fa parte anche Tony Tulathimutte. E forse proprio questa generazione di autori farà i primi passi per inserire sempre più elementi della contemporaneità digitale in letteratura, aprendo le porte a chi ne è sempre vissuto immerso.
C’è anche la possibilità che siano i lettori a essere poco interessati a trovare una rappresentazione fedele dell’universo tecnologico contemporaneo sulla carta stampata. Chi è interessato a questo tema si indirizzerà più verso la saggistica che verso la narrativa. Come detto, viviamo immersi nella tecnologia, e molte persone leggono anche alla ricerca di una pausa antitetica al costante bombardamento di notifiche, messaggi, chiamate ed e-mail. Se ritrovi tutti questi elementi anche nei romanzi, la fuga dalla contemporaneità è destinata a fallire miseramente.
Eppure la questione è importante, non è solo estetica. In discussione c’è il ruolo della letteratura nella società. Sicuramente non le si può imporre di essere relegata a mera cronaca del contemporaneo, ma è interessante capire se tra i suoi compiti non ci sia in ogni caso il parlare di noi e della nostra epoca. Può davvero disinteressarsene e lasciare l’incombenza solo alla cronaca, al giornalismo, alla saggistica?
Il contesto storico nel quale ci muoviamo è complesso, come in fondo lo sono sempre stati tutti per chi li vive. È più facile vedere con chiarezza una situazione quando ci si allontana, sia fisicamente che temporalmente. Ma la tecnologia, con le sfide che ci lancia e le certezze che distrugge, porta con sé molte domande che secondo me la letteratura non può evitare. Ci parla di noi e del nostro rapporto con il reale, con l’alterità, con la solitudine, con tutti i grandi temi che hanno fatto la storia della letteratura. E a differenza di altre rivoluzioni lo fa anche a livello linguistico.
Mai come oggi si scrive, mai come oggi si legge. Siamo immersi nelle parole. Parole ascoltate in video, in podcast, ma anche lette in commenti, messaggi, articoli, e-mail. Internet ha fatto nascere nuovi linguaggi, modificato quelli esistenti, dato vita a modalità linguistiche e narrative inedite. Ha pescato a strascico nella narrativa, ne ha riproposto i modelli, li ha semplificati e a volte svuotati di senso. I risultati possono piacere o non piacere, ma non si possono negare. Trattarli con sufficienza o relegarli a moda passeggera è ormai anacronistico: è un quarto di secolo che ne siamo sempre più immersi. Certo, possiamo continuare a guardarla con snobismo e decidere che non sia abbastanza significativa da essere riportata sulla carta stampata. Ma ho la sensazione che sarebbe una grossa occasione persa. Per capire di più su noi stessi, per capire di più su come comunichiamo.
E quindi aggiorno la pagina. Niente, esce sempre il 24 settembre.




