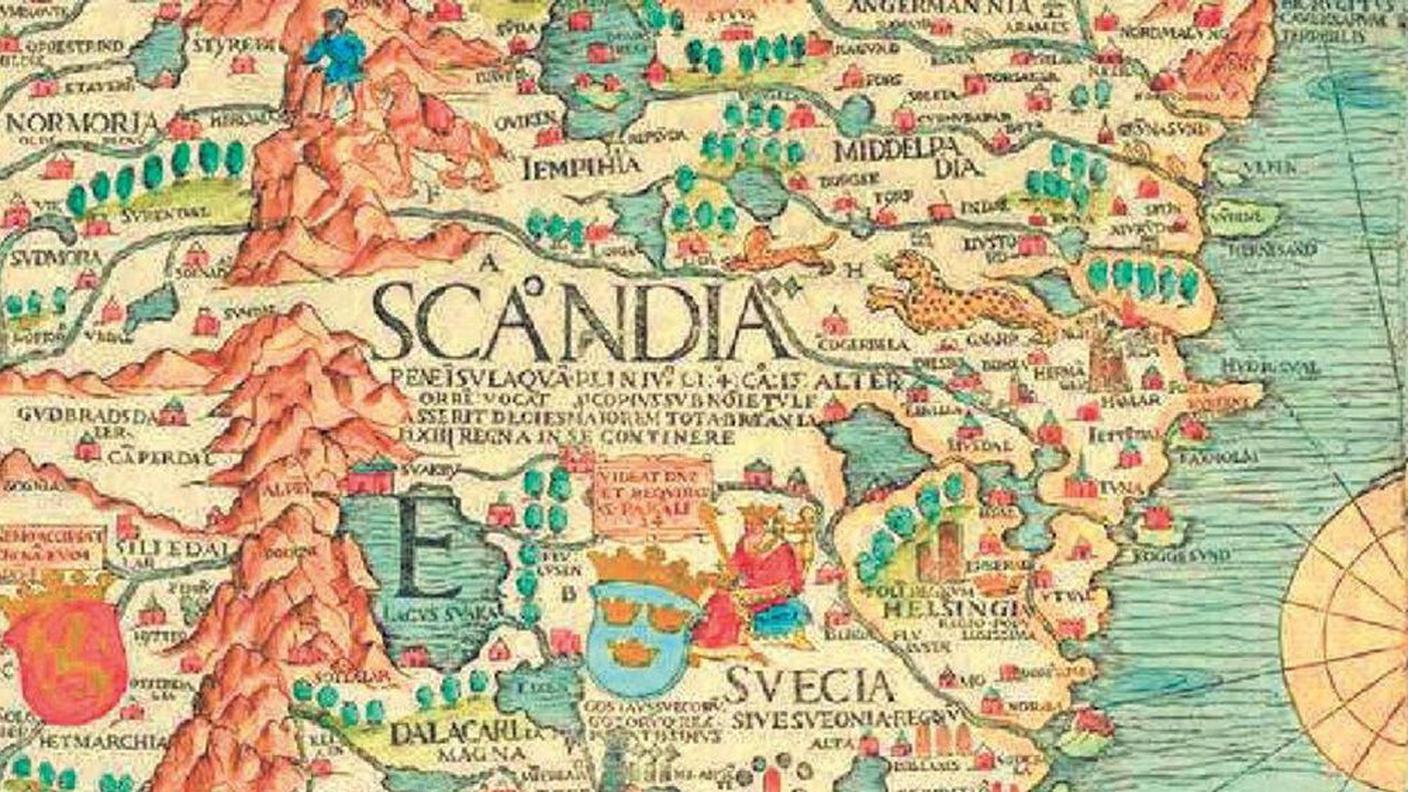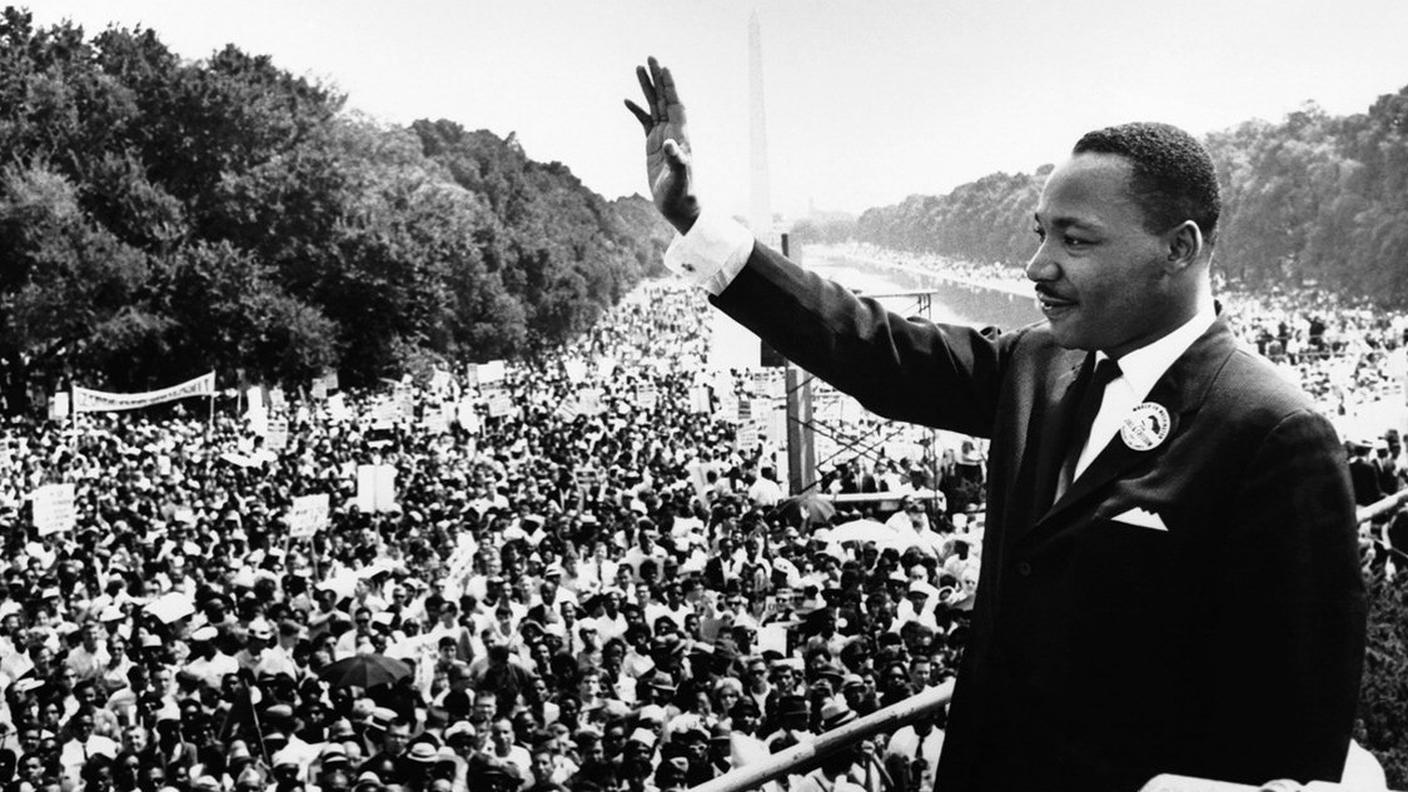Varietà delle macchine idrauliche
In un censimento ufficiale del 1895 in Ticino si contavano: 654 mulini, 85 frantoi, 85 seghe, 25 magli, 72 peste o pile e 162 macchine idrauliche d’altro genere. Quindi un totale di 1083 macchine idrauliche. Se si considera che la superficie cantonale è di circa 2800 km2, di cui la metà è bosco, risulta che c’era poco meno di una macchina idraulica ogni chilometro quadrato.
Nel mulino – la macchina idraulica più diffusa e iperonimo di tutto il genere – la forza dell’acqua viene impiegata per macinare i cereali. Ma di opifici idraulici ce n’erano una grande varietà. Il principio comprende la presenza di una ruota mossa dall’acqua, che a sua volta trasmette il movimento ad un meccanismo che aziona uno strumento.
I mulini, grazie al movimento rotatorio, macinavano grano, mais, segale, orzo e altri cereali, fornendo così farina per panificare, per i dolci o per la polenta. Il movimento rotatorio veniva impiegato anche nei frantoi, dove si spremevano olive, lino o noci, da cui si otteneva l’olio.
Le peste o pile trasformavano invece il movimento rotatorio in movimento verticale: in questo caso la pilatura permetteva di decorticare l’orzo e il miglio dalla loro “buccia”. Lo stesso meccanismo era impiegato dalle segherie, dove il movimento verticale era trasmesso a una lama seghettata. Ma anche nei magli, dove una pesante mazza batteva il metallo che si stava lavorando, che a sua volta era posizionato su un’incudine. Sempre nei magli, ma anche in molti altri contesti in cui si trovava un forno che raggiungeva temperature elevatissime (quindi fonderie, cementifici ecc.), la macchina idraulica poteva azionare un mantice, che alimentava le braci.
Quindi, la forza dell’acqua (e in alcuni paesi anche la forza del vento) per secoli ha fatto funzionare il mondo, in modo assolutamente ecologico. E lo fa ancora oggi, anche se viene coinvolto un intermediario: il generatore, che trasforma l’energia primaria in energia secondaria, quindi elettricità.
Col tempo si è iniziato a utilizzare l’elettricità anche per la macinazione dei cereali e per le altre attività fino a quel momento mosse grazie alla forza dall’acqua. Dei più di 1000 opifici idraulici ticinesi molti sono stati demoliti oppure trasformati in abitazioni o grotti. Altri invece sono stati restaurati e valorizzati da parte di comuni, fondazioni, musei o da preziosi gruppi di volontari, che ne hanno fatto luoghi dimostrativi per mantenere viva la memoria storica di un’attività, ma anche il gusto del cibo prodotto grazie a lavorazioni completamente artigianali.
Il mulino di Bruzella: non solo un museo
Uno di questi è il Mulino di Bruzella, che si trova in un magnifico angolo della Valle di Muggio, sulle rive del fiume Breggia. Le prime tracce di un mulino risalgono al XIII secolo, ma il nucleo dell’edificio attuale è del Settecento, e negli anni è stato pian piano ampliato.
Tra il 1890 e il 1965 il mulino di Bruzella era gestito dalla famiglia Frigerio, poi l’attività è stata abbandonata. Già nel 1983 il Museo etnografico della Valle di Muggio lo ha acquistato, restaurato e rimesso in attività. Dal 1996 la mugnaia Irene Petraglio si prende cura dell’edificio, delle macchine, della roggia e dell’attività, producendo durante tutto l’anno circa 20 tonnellate di farina di mais. Il Mulino di Bruzella non è quindi solo un luogo dimostrativo, ma una vera e propria sede di produzione.

Il Mulino di Bruzella
RSI Cultura 25.05.2025, 14:00
Come funziona il mulino di Bruzella?
La prima componente essenziale è la roggia. La ruota del mulino non viene azionata direttamente dal fiume che scorre, ma dall’acqua deviata precedentemente a monte con una presa, e condotta fino al vertice della ruota grazie a un piccolo canale. A Bruzella la roggia, molto ben visibile, è lunga 150 metri.
L’attuale ruota motrice in ferro risale al 1980, ed è molto grande: ha un diametro di 3 metri ed è composta da 42 cassettoni. All’interno dell’edificio è collegata all’albero motore e agli ingranaggi di moltiplica, che imprimono la necessaria velocità alle macine. L’apparato tecnico compone il cosiddetto “castello”, ed è tutto un sistema di ruote dentate e rocchetti, che spostano l’asse del movimento rotatorio da verticale a orizzontale. Le macine in pietra richiedono un movimento rotatorio “piatto” e ogni macina necessita di un rocchetto. A Bruzella in origine c’erano due macine in funzione, ma oggi ne è rimasta attiva solo una.
Se seguiamo il percorso che faceva il granoturco capiamo subito che il mulino si sviluppa su più livelli verticali per ragioni funzionali: nel mulino, infatti, edificio e macchina sono una cosa sola, l’architettura è l’involucro della macchina.
Il grano arrivava al piano più alto, dove veniva pulito dalle impurità, e poi pesato. Un sollevatore a manovella permetteva di sollevare i sacchi di fino ad arrivare all’imbocco del primo contenitore del grano, il cassone di raccolta, che era collegato, attraverso uno scivolo di legno, alla tramoggia, che si trovava 2 piani più in basso. Oggi il grano viene perlopiù caricato direttamente nella tramoggia.
La tramoggia è una sorta di imbuto in legno che convoglia il grano verso il centro delle macine.
Le due macine sono in pietra e pesano 6 quintali l’una. Hanno un profilo leggermente inclinato e la superficie è incisa con delle scanalature: questo, con l’aiuto della forza centrifuga, fa si che i chicchi scivolino verso l’intercapedine più esterna e più stretta, e vengano così schiacciati e macinati.
Il prodotto che esce dalla macina non è ancora pronto: bisogna setacciarlo per separare la farina dalla crusca (che serviva per alimentare le galline e i maiali).
Inizialmente si setacciava la farina a mano. Poi anche i mulini hanno accolto la tecnologia e alle ruote dentate è stata collegata una cinghia di trasmissione che avviava l’elevatore a tazze verticali.
Questo sistema (una sorta di ascensore) permetteva di automatizzare il passaggio dal piano inferiore a quello di mezzo, dove si trovava il buratto, quindi la macchina che serviva per setacciare. Il buratto è di forma esagonale e aveva un aspo girevole, azionato sempre dall’albero motore principale. La setacciatura avveniva grazie a una tela metallica con maglie di diversa grandezza, che permettevano di ottenere farine differenti.
Su questo livello si trovava anche il deposito, che custodiva i sacchi di farina fino alla vendita o al ritiro da parte dell’agricoltore autorizzato alla macinazione diretta del proprio raccolto.
Verso il mulino industriale
Vista la centralità del prodotto (il grano o i cereali in generale), sin dagli inizi dell’industrializzazione la tecnologia dell’attività molitoria viene resa sempre più performante e produttiva. Grazie ai sistemi di trasmissione si cerca e si ottiene un sempre maggiore processo di automatizzazione.
Ad Arbedo si trova un mulino a ruota idraulica che aziona una tecnologia semiautomatica, già a carattere industriale, che risale al 1936: il Mulino Erbetta viene messo in funzione dalla Fondazione omonima a scopi dimostrativi.
In Ticino esistevano diversi mulini industriali, per esempio il Mulino Bernasconi di Viganello, il Molino Rezzonico di Chiasso o il Mulino della Cooperativa Agricola Ticinese di Giubiasco, ma hanno tutti cessato l’attività. L’unico mulino industriale rimasto è quello di Maroggia, gestito dalla famiglia Fontana, e dopo l’incendio che lo ha colpito nel 2020 dispone di impianti completamente nuovi. Oggi i mulini sono completamente automatizzati e digitalizzati e la macinazione avviene nei laminatoi.
Fonti e informazioni pratiche:
Ringraziamo la mugnaia, Irene Petraglio, e la sua aiutante, Silvia Medici, per le preziose informazioni sul funzionamento del Mulino di Bruzella.
Apertura del mulino: mercoledì e giovedì: 14.00 – 16.30 , domenica: 13.00 – 16.30. Presso il mulino si trova anche un museo dedicato alla macinazione del grano e agli opifici idraulici lungo la Breggia. Informazioni: Museo etnografico Valle di Muggio, Cabbio
Ivano Camponovo, Il Mulino dei Galli. Momenti di vita quotidiana nella Valle della Motta e dintorni del XIX secolo, Coldrerio, 2007.

Bruzella, riparte il mulino
Il Quotidiano 02.08.2021, 21:30