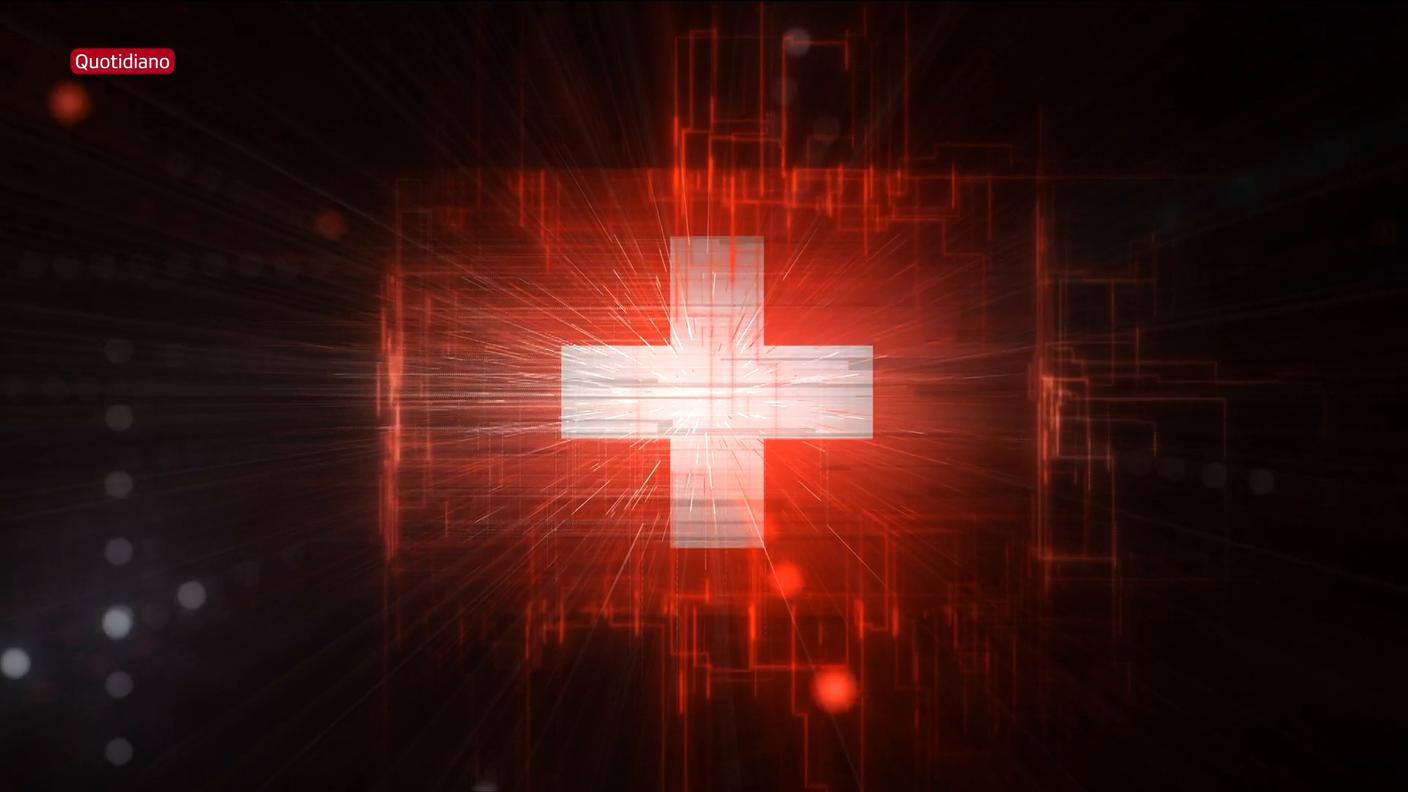L’AI + X Summit di Zurigo è un grande convegno dedicato al mondo dell’intelligenza artificiale (IA). Qui ci si aspetta di trovare robot umanoidi, startup di finanza o soluzioni nell’ambito della salute e del benessere. Eppure, se c’è una cosa che abbiamo imparato da questa prima edizione delle Swiss{AI}Weeks, una serie di eventi in tutta Svizzera dedicati all’IA cui appartiene anche l’AI + X Summit, è che le applicazioni dell’IA non escludono alcun ambito. Nel programma del ritrovo organizzato dall’ETH AI Center, il centro dedicato all’IA del Politecnico Federale di Zurigo, c’è così anche un intervento sul tema biodiversità. Vedere sul programma il titolo “IA e biodiversità” dell‘intervento di Sara Beery, professoressa al Massachussets Institute of Technology (Stati Uniti), ha forse stupito qualcuno, ma, senza fare troppo rumore mediatico, l’IA sta già dando una mano concreta alla preservazione del patrimonio naturale del nostro pianeta.
Quando l’intelligenza artificiale è svizzera
Alphaville 23.09.2025, 11:05
Contenuto audio
Per proteggere la natura è prima di tutto necessario conoscerla a fondo. Oggi, con i mezzi digitali e i metodi scientifici, questo significa acquisire e analizzare dati. Ad esempio, osservare le immagini delle fototrappole per capire quali e quanti animali siano presenti sul territorio. È il caso di un progetto che Sara Beery ha sviluppato in Africa, dove un centinaio di fotocamere sono state utilizzate per osservare delle zebre di Grévy all’interno di un programma di protezione. A partire dalle strisce del manto degli animali, il sistema è in grado di distinguere e riconoscere i singoli animali, per poterli così contare e stimare la popolazione totale. In questo progetto pilota, il metodo è stato confrontato con la più lenta e costosa analisi fatta da degli operatori umani con l’obiettivo di sviluppare un nuovo metodo d’indagine per il futuro.
Fototrappola con sensore di movimento
L’IA permette anche di esplorare possibilità d’indagine prima precluse per la mole imponente di lavoro necessaria. È il caso di un progetto sviluppato con iNaturalist, la più grande banca dati per immagini di animali del mondo con oltre 300 milioni di fotografie scattate da semplici appassionati in un massiccio progetto di citizen science (scienza partecipativa). Assieme alla piattaforma, il gruppo di Sara Beery ha sviluppato un algoritmo chiamato Inquiry che consente ai ricercatori di selezionare rapidamente fotografie di animali in diversi contesti. Ad esempio, cercando “uccelli che si cibano” gli scienziati possono rapidamente ottenere fotografie di questi animali mentre si nutrono. Così possono osservare che cosa mangiano gli uccelli, ottenendo anche informazioni sul contesto, come la stagione e trarne conclusioni sullo stato dell’ecosistema. «Nascosto in tutti quei pixel, nei 300 milioni di immagini, c’è molto di più. Puoi capire le relazioni trofiche (interazioni ecologiche relative alla nutrizione, ndr), le reti alimentari, i processi riproduttivi, lo stato di salute. Puoi osservare i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica, perché nel database ci sono esempi di tutti questi diversi e fondamentali fattori ecologici che al momento non sono davvero accessibili. Il nostro approccio consiste proprio nel creare strumenti che permettano a qualsiasi scienziato di cercare i dati rilevanti per la propria ricerca, trovarli, verificarli grazie alla propria competenza, esportarli e poi analizzarli», spiega la professoressa. Secondo le sue stime, l’analisi che ora può essere fatta in pochi click richiederebbe circa 40 anni di lavoro a tempo pieno per essere svolta da una persona.
Un pettirosso con une preda nel becco
Un altro progetto importante tutt’ora in corso riguarda il monitoraggio dei salmoni negli Stati Uniti occidentali. In California si sta attualmente procedendo alla rimozione di una grossa diga nel fiume Klamath, ma è necessario verificare l’impatto sulla fauna locale. Sara Beery ha così contribuito a sviluppare un sistema di IA in grado di riconoscere e contare i salmoni sulla base dei dati di sonar posti sott’acqua, dispositivi volti a osservare l’ambiente subacqueo simili a quelli dei sommergibili. Il rilevamento è necessario per stimare lo stato dell’intero ecosistema. Però, riconoscere correttamente una specifica specie animale in un ambiente complesso e in continuo cambiamento come quello di un fiume è tutt’altro che facile. «È fondamentale avere una stima solida del numero di esemplari che non dipenda dalle condizioni ambientali. Bisogna assicurarsi che i conteggi riportati, quelli su cui si baseranno le azioni e le decisioni di conservazione, siano affidabili. In altre parole, si tratta di garantire l’affidabilità dei dati nonostante la complessità del sistema reale che si sta misurando».
La diga sul fiume Klamath durante i lavori di riapertura nel 2024
I dati presi con questi sistemi servono a prendere decisioni sulla gestione del territorio ed è fondamentale che siano accurati. Ad esempio, il Dipartimento della pesca e della caccia dello stato dell’Idaho si basa su un algoritmo sviluppato da Sara Beery per decidere quanti ungulati e lupi abbattere ogni anno. Attualmente, oltre mille organizzazioni in ambito ambientale utilizzano un suo software, chiamato MegaDetector, in tutto il mondo: si tratta di un modello di IA che permette di riconoscere automaticamente gli animali fotografati e di eliminare automaticamente le fotografie scattate a vuoto dalla fototrappola.
Il ruolo di questi sistemi nella gestione dell’ambiente non si limita al processo decisione, ma include il monitoraggio dei programmi di riqualificazione. È il caso, ad esempio, di un progetto che sta partendo in Amazzonia, dove, all’interno di una vasta rete di collaboratori, stanno cercando di capire come utilizzare diverse tipologie di dati per monitorare il ripristino di una porzione di foresta. «Una parte fondamentale di questo lavoro consiste nel valutare, ad esempio, se in alcune aree ci sono state attività estrattive o disboscamenti per l’agricoltura, mentre in altre zone la foresta è rimasta intatta e protetta: come si possono comprendere rapidamente le principali differenze nella biodiversità tra queste due realtà? E poi, se si avvia un processo di rigenerazione, come si può verificare che stia davvero funzionando?», spiega la ricercatrice. L’intelligenza artificiale, dunque, sta già avendo un profondo impatto anche nella salvaguardia dell’ambiente. Certamente in modo più discreto rispetto ai clamori multimiliardari di altre applicazioni di questa tecnologia.
L’IA e i suoi stregoni
Kappa in libertà 29.09.2025, 18:00
Contenuto audio