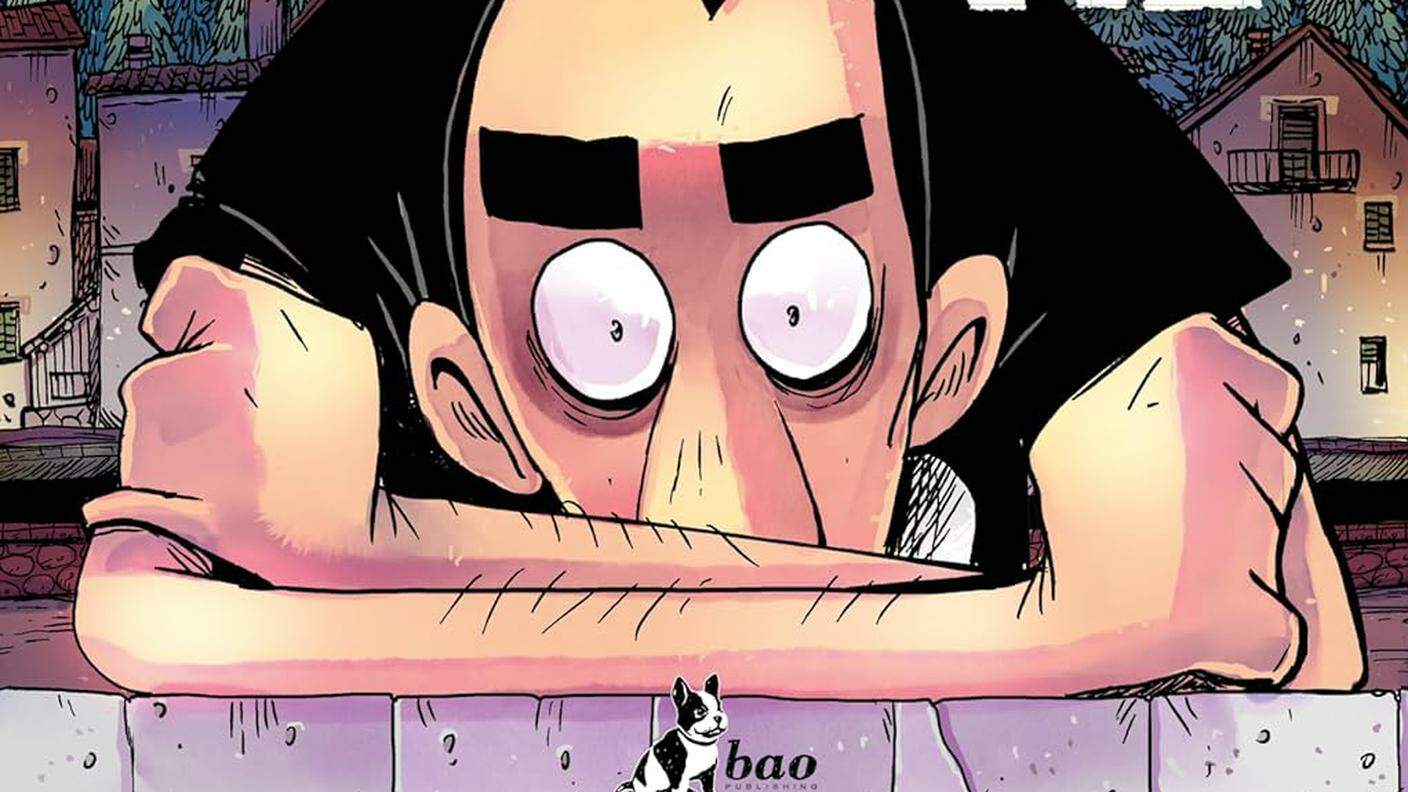Un lettore onnivoro del calibro di Hermann Hesse, riferendosi nello specifico a uno dei suoi “livres de chevet”, il “Siebenkäs”, straordinario quanto negletto romanzo del narratore tedesco Jean Paul, disse una volta che nei grandissimi scrittori c’è tutto. Basta scegliere l’opera -ma a volte basta un solo libro- di uno di questi grandissimi scrittori, e in linea teorica non c’è bisogno di leggere altro.
Si tratta ovviamente di un paradosso, non privo tuttavia di un sostanziale fondo di verità, perché ci sono alcuni libri -non tantissimi, forse, ma nemmeno pochissimi- che contengono davvero tutto. Nel novero di questi libri, e in posizione tutt’altro che secondaria, figura “Grande Sertão” del brasiliano João Guimarães Rosa, che non è soltanto uno dei massimi capolavori della letteratura dell’America latina del secolo scorso ma è anche -e soprattutto- un mondo, perché reinventa un luogo specifico, il Sertão (contrazione del termine “Desertão”, “deserto”, che indica le zone dell’entroterra del Brasile, incolte e scarsamente popolate, dove la Natura ha il predominio assoluto sull’uomo), e lo trasforma nella metafora della vita e perfino nella vita stessa, in virtù di un prodigioso intreccio di simbolismi sorretto da una lingua che nel Novecento ha pochi paragoni.
Esattamente come Joyce col “flusso di coscienza”, Céline con la “piccola musica” e (almeno in parte) Thomas Bernhard con “l’arte dell’esagerazione”, anche Guimarães Rosa, lavorando sul lessico e la sintassi del portoghese parlato nel Sertão e del cosiddetto “Mineiro” dei Minas Gerais, ha creato infatti un linguaggio, e in virtù di questo linguaggio ha reinventato e ricreato la realtà, di modo che il suo Sertão diventa una coordinata esistenziale, una categoria dello spirito, non una dimensione specifica della vita ma appunto la vita stessa nella sua totalità. Un po’ come la Dublino di Joyce, oppure una certa Parigi restituita da Céline in virtù dell’utilizzo dell’argot. Se si volesse trovare un paragone nella letteratura italiana del Novecento, il pensiero non potrebbe che correre alle «tenebrose fonazioni» della Brianza/Maradágal ricreata da Carlo Emilio Gadda ne “La cognizione del dolore”.
Uscito originariamente nel 1956, ristampato nel 1963 e pubblicato in traduzione italiana nel 1970, “Grande Sertão” costituisce l’apice della produzione narrativa di Guimarães Rosa, nato nel 1908 a Cordisburgo nella regione di Minas Gerais e morto nel 1967 a Rio de Janeiro. Le altre sue opere, in particolare “Corpo di ballo” e “Sagarana”, ma anche lo straordinario racconto “Mio zio il giaguaro”, per quanto di altissimo livello, sono piuttosto distanti dall’assoluta e irripetibile perfezione del capolavoro. Come tutti i grandissimi libri, anche “Grande Sertão” si avvicina e porta quasi a compimento la magnifica quanto irrealizzabile utopia flaubertiana del “libro su niente”, perché nelle sue cinquecento densissime pagine non succede niente -come in una giornata qualsiasi a Dublino, oppure in un remoto villaggio francese dove si consuma un tristo adulterio di provincia- ma in realtà succede tutto, e questo niente/tutto si regge solo ed unicamente sulla forza dello stile, sulla precisione e sulla magica potenza evocativa (si vorrebbe dire: espressiva e non banalmente comunicativa) delle parole, di ogni singola parola che assurge al rango di “mot juste”.
Ambientato, come dice il sottotitolo, nelle zone chiamate “Veredas” o anche “Campos Gerais”, le vallate fertili che si aprono tra gli altopiani secchi e arenosi del Sertão, il libro racconta la storia di Riobaldo e del suo amico e compagno di avventure, il bellissimo ed efebico Diadorim, che nelle ultime pagine si rivelerà sorprendentemente una donna. La vicenda è narrata in prima persona dallo stesso Riobaldo, che si rivolge a un immaginario interlocutore col titolo di “Vossignoria”, in un linguaggio stranissimo, intimo e colloquiale, ricco di confidenze, sottintesi, rimandi e allusioni, dal quale si può forse dedurre che l’interlocutore sia la coscienza dello stesso Riobaldo e che quindi tutta la narrazione sia in realtà un gioco di specchi, una confessione, un monologo interiore.
Riobaldo e Diadorim sono due “Jagunços”, membri delle bande dell’antico Sertão, un luogo dove non c’era alcuna legge e la vita degli “Jagunços”, che molto spesso da banditi si trasformavano in difensori degli oppressi, era regolata da un ferreo codice di disciplina e di onore. E’ proprio in nome di questo codice non scritto, ma anche di una tensione latamente omoerotica (perché in quel momento non si sa ancora che il bellissimo Diadorim è una donna che si è finta uomo per diventare “Jagunço”) che Riobaldo compie il gesto intorno al quale ruota tutta la trama: la vendetta di Joca Ramiro, padre di Diadorim, che era stato tradito e assassinato da Ermogene e Riccardone, i due capi di una banda rivale. Non c’è altro, perché tutto il resto è racconto che si confonde col Sertão, e lo stesso Riobaldo, pagina dopo pagina, si trasforma nel Sertão stesso, mentre il Sertão, da parte sua, diventa Riobaldo, in una sorta di unione mistica che nega ogni forma di approccio logico e razionale alla “realtà” e al mondo esterno dei “fatti”.
Tuttavia c’è anche un'altra dimensione, se mai possibile ancora più profonda, straniante, abissale, perché restituisce davvero il cuore di tenebra della condizione umana. Libro grandissimo e incommensurabile, “Grande Sertão” si inserisce anche -forse chiudendolo definitivamente- in uno dei grandi miti della cultura occidentale, quello di Faust. Nel suo continuo vagare lungo le strade e i sentieri del Sertão, e cioè del mondo e della vita, Riobaldo si sente infatti costantemente inseguito e minacciato dal diavolo, il tentatore, per il quale inventa una serie di mirabolanti epiteti: «Il Padre del Male, il Manfarro, il Fistola, il Cane della Notte, Quello che non esiste, l’Io-Sfrenato, il Lui». Una notte, poco prima di vendicare Joca Ramiro, decide infine di sfidarlo, evocandolo nella losca e impenetrabile oscurità di una remota e infida brughiera.
Ma il diavolo non compare. Forse non esiste, oppure non è altro che il nulla che insidia e nega la vita, il presente che sdrucciola ad ogni istante nel passato, il tempo che scivola ineluttabile nel vuoto, senza remissione e redenzione. Comunque sia, Riobaldo tiene fisso lo sguardo nel buio e nel vuoto, ricavandone una salvezza all’apparenza molto affine ma nella sostanza molto diversa da quella del Faust di Goethe, che invece viene rigenerato dall’aurora e trova un significato che riassume e insieme trascende lo “Streben”, la sua tensione verso l’Assoluto. Per Riobaldo, invece, il senso della vita e della sua odissea sono precisamente quel vuoto, quel buio, quello sguardo tenuto coraggiosamente fisso sul Nulla e sulla Morte, come lasciano intendere le ultime parole del romanzo: «Nonnulla. Il diavolo non c’è! E’ quel che dico, se fosse… Quel che esiste è l’uomo umano. Traversia».
«Il Sertão è confusione in una grande eccessiva calma», e quel che esiste è l’uomo umano: alla fine, terminato il lungo racconto/confessione, l’ormai anziano Riobaldo, «quasi rivierasco», si chiede quale significato abbiano avuto le sue avventure nel Sertão e cioè «nell’andirivieni delle cose». L’unica risposta che trova è forse la più plausibile, probabilmente la meno consolante, sicuramente la più sincera: «So qualcosa di me? Eseguo».